poteva andare decisamente meglio's Articles

La molteplicità dei concerti previsti nelle diverse sedi sparse per la città, mi ha reso impossibile quest’anno l’ascolto esaustivo delle varie esibizioni, rendendo difficile poter fare un realistico consuntivo di questa 40a edizione del Bergamo Jazz Festival, chiuso domenica sera al Teatro Creberg (posto in periferia della città, di rimpiazzo all’usuale Teatro Donizetti in centro città, attualmente in restauro) con il concerto dei quattro direttori alternatisi dal 2006 alla guida artistica della manifestazione. In questo senso, ho dovuto operare un’inevitabile selezione, con una scelta a priori alla fine caduta su complessivi otto concerti. (Continua a leggere)
 Coltivavo l’intenzione dichiarata di replicare il provocatorio Flop Jazz che aveva ottenuto un riscontro inaspettato di lettori a fine anno scorso, ma devo confessare che non è mia abitudine ascoltare volutamente musica mediocre con tale fine. Diciamo che capita di inciamparci, ma tendenzialmente preferisco occupare il tempo libero ascoltando musica valida, se non di pregio, pertanto non mi sono capitate molte occasioni per criticare in negativo ciò che ho ascoltato e nemmeno è detto che abbia poi voglia di scriverne. In molti casi non ne vale proprio la pena. Tuttavia, uno dei pochi dischi ascoltati in questo periodo che mi hanno deluso e stimolato alla scrittura è questo A Cosmic Rhythm with Each Stroke che mi appresto a commentare, ovviamente senza pretesa di avere verità rivelate in tasca. (Continua a leggere)
Coltivavo l’intenzione dichiarata di replicare il provocatorio Flop Jazz che aveva ottenuto un riscontro inaspettato di lettori a fine anno scorso, ma devo confessare che non è mia abitudine ascoltare volutamente musica mediocre con tale fine. Diciamo che capita di inciamparci, ma tendenzialmente preferisco occupare il tempo libero ascoltando musica valida, se non di pregio, pertanto non mi sono capitate molte occasioni per criticare in negativo ciò che ho ascoltato e nemmeno è detto che abbia poi voglia di scriverne. In molti casi non ne vale proprio la pena. Tuttavia, uno dei pochi dischi ascoltati in questo periodo che mi hanno deluso e stimolato alla scrittura è questo A Cosmic Rhythm with Each Stroke che mi appresto a commentare, ovviamente senza pretesa di avere verità rivelate in tasca. (Continua a leggere)
 Christian Scott. Dove eravamo rimasti? Già, a ‘Ruler Rebel’, primo capitolo dell’ambiziosa Centennial Trilogy, dedicata ai temi dell’integrazione razziale e culturale nell’America del nuovo millennio. Se avete letto la recensione di ‘Ruler Rebel’, saprete che non ha suscitato in me impressioni particolarmente favorevoli, anzi. La speranza era piuttosto che i capitoli successivi ne prendessero le distanze, vista la piattezza e la noia che vi regnavano incontrastate. Purtroppo, puntuale come una bolletta, arriva il “purtroppo”, perché ‘Diaspora’ è sostanzialmente identico al predecessore. Talmente identico che è possibile descriverlo con un bel copia e incolla. Pronti? Via! (Continua a leggere)
Christian Scott. Dove eravamo rimasti? Già, a ‘Ruler Rebel’, primo capitolo dell’ambiziosa Centennial Trilogy, dedicata ai temi dell’integrazione razziale e culturale nell’America del nuovo millennio. Se avete letto la recensione di ‘Ruler Rebel’, saprete che non ha suscitato in me impressioni particolarmente favorevoli, anzi. La speranza era piuttosto che i capitoli successivi ne prendessero le distanze, vista la piattezza e la noia che vi regnavano incontrastate. Purtroppo, puntuale come una bolletta, arriva il “purtroppo”, perché ‘Diaspora’ è sostanzialmente identico al predecessore. Talmente identico che è possibile descriverlo con un bel copia e incolla. Pronti? Via! (Continua a leggere)
 Prendo atto che da Liquid Spirit del 2013, Gregory Porter, cantante e songwriter, ha ottenuto un enorme successo, vendendo oltre un milione di copie a livello globale, vincendo nel 2014 il Grammy nella categoria Best Jazz Vocal Album, ma l’ascolto di quest’ultimo suo lavoro, come quello di allora che avevo recensito un paio di anni fa, mi ha lasciato del tutto indifferente e forse meriterebbe le stesse parole. Probabilmente capirò poco di cantanti, può anche essere, ma francamente non comprendo tutto questo entusiasmo per un canto e una proposta che nella grande tradizione afro-americana del pop-soul (stento a considerarlo all’interno del vocal jazz, ma in fondo non è poi così importante) paiono essere del tutto ordinari. Mi domando seriamente cosa dovrei dire allora di giganti del genere come Ray Charles, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Donny Hathaway, Luther Vandross e Michael Jackson, tanto per citare i più noti (ma potrei fare decine di altri nomi), ai quali, si dice, la voce baritonale di Porter (almeno in parte) si ispirerebbe. (Continua a leggere)
Prendo atto che da Liquid Spirit del 2013, Gregory Porter, cantante e songwriter, ha ottenuto un enorme successo, vendendo oltre un milione di copie a livello globale, vincendo nel 2014 il Grammy nella categoria Best Jazz Vocal Album, ma l’ascolto di quest’ultimo suo lavoro, come quello di allora che avevo recensito un paio di anni fa, mi ha lasciato del tutto indifferente e forse meriterebbe le stesse parole. Probabilmente capirò poco di cantanti, può anche essere, ma francamente non comprendo tutto questo entusiasmo per un canto e una proposta che nella grande tradizione afro-americana del pop-soul (stento a considerarlo all’interno del vocal jazz, ma in fondo non è poi così importante) paiono essere del tutto ordinari. Mi domando seriamente cosa dovrei dire allora di giganti del genere come Ray Charles, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Donny Hathaway, Luther Vandross e Michael Jackson, tanto per citare i più noti (ma potrei fare decine di altri nomi), ai quali, si dice, la voce baritonale di Porter (almeno in parte) si ispirerebbe. (Continua a leggere)
 Se ci seguite da un po’ di tempo, saprete che Christian Scott gode di enorme stima su queste webpagine. Senza arrivare a dire che, in Italia, siamo stati i soli e i primi a seguire la sua carriera e a notarne la crescente importanza all’interno degli ultimi dieci anni di jazz, possiamo almeno dire “però quasi”. Un cammino iniziato con l’ottimo ‘Rewind That’ e arrivato ad una sintesi perfetta di tutte le varie sfaccettature esibite fino a quel momento nell’ancora recentissimo ‘Stretch Music’. Tutta questa premessa serve per mettere in chiaro una cosa: il nuovo cd è un bel fiasco, non importa quanto se ne stimi l’autore. Primo album di una trilogia che verrà completata nel corso del 2017, ‘Ruler Rebel’ fa un salto della cavallina troppo azzardato con le sonorità dell’illuminato predecessore, franando rovinosamente in un insipido minestrone jazz-o-tronico. (Continua a leggere)
Se ci seguite da un po’ di tempo, saprete che Christian Scott gode di enorme stima su queste webpagine. Senza arrivare a dire che, in Italia, siamo stati i soli e i primi a seguire la sua carriera e a notarne la crescente importanza all’interno degli ultimi dieci anni di jazz, possiamo almeno dire “però quasi”. Un cammino iniziato con l’ottimo ‘Rewind That’ e arrivato ad una sintesi perfetta di tutte le varie sfaccettature esibite fino a quel momento nell’ancora recentissimo ‘Stretch Music’. Tutta questa premessa serve per mettere in chiaro una cosa: il nuovo cd è un bel fiasco, non importa quanto se ne stimi l’autore. Primo album di una trilogia che verrà completata nel corso del 2017, ‘Ruler Rebel’ fa un salto della cavallina troppo azzardato con le sonorità dell’illuminato predecessore, franando rovinosamente in un insipido minestrone jazz-o-tronico. (Continua a leggere)
Dopo ben trentadue anni, la rassegna musicale milanese Aperitivo In Concerto chiude i battenti. Ed è un vero peccato, perché si trattava di una delle più interessanti e intelligenti d’Italia. (Continua a leggere)
 Qualche anno fa ‘Injuries’, esordio degli svedesi Angles 9, aveva attirato l’attenzione di diversi tra gli addetti ai lavori che si erano sprecati in elogi e in paragoni altisonanti (tra gli altri: Duke Ellington, Charles Mingus e Carla Bley) per via di una originale declinazione in chiave moderna e post-free della musica per big band. Su queste pagine avevamo corretto il tiro: non si trattava di un miracolo di orchestrazione per ensemble allargato di musica jazz contemporanea, bensì di un amatoriale quanto fallimentare tentativo di estendere le forme della scuola avant-jazz europea a un combo di nove elementi (due sassofoni, una cornetta, una tromba, un trombone, un pianoforte, un basso, una batteria e un vibrafono).
Qualche anno fa ‘Injuries’, esordio degli svedesi Angles 9, aveva attirato l’attenzione di diversi tra gli addetti ai lavori che si erano sprecati in elogi e in paragoni altisonanti (tra gli altri: Duke Ellington, Charles Mingus e Carla Bley) per via di una originale declinazione in chiave moderna e post-free della musica per big band. Su queste pagine avevamo corretto il tiro: non si trattava di un miracolo di orchestrazione per ensemble allargato di musica jazz contemporanea, bensì di un amatoriale quanto fallimentare tentativo di estendere le forme della scuola avant-jazz europea a un combo di nove elementi (due sassofoni, una cornetta, una tromba, un trombone, un pianoforte, un basso, una batteria e un vibrafono).
Quest’anno è la volta di ‘Disappeared Behind the Sun’, pubblicato il 17 gennaio ancora una volta dalla Clean Feed (il cui catalogo troppo spesso vanta discutibili esperimenti eseguiti con pochissima competenza e creatività), e ancora una volta i limiti della musica degli Angles 9 (la cui line up è rimasta invariata dai tempi di ‘Injuries’) si rivelano invalicabili. L’idea di fondo è molto semplice: mentre pianoforte, basso e batteria procedono su un sostenuto passo jazz-funk, abbellito dagli arrangiamenti del vibrafono, i cinque fiati ora tessono le idee melodiche portanti dei brani, ora si cimentano in lunghe sezioni solistiche corali. (Continua a leggere)
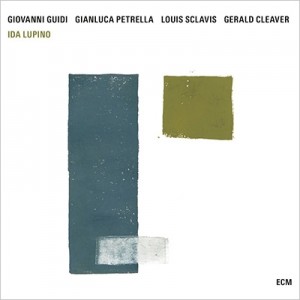 Erano anni che non mi avvicinavo più all’ECM. La curiosità di sentire il SoupStar, che dal vivo mi ha sempre emozionato, con l’aggiunta di due musicisti come Louis Sclavis e Gerald Cleaver mi fatto saltare l’ostacolo. Inoltre anche la presenza di un brano che amo, Ida Lupino, ha fatto da par suo. Nonostante queste premesse, il disco purtroppo conferma le stesse caratteristiche “nordiche” dell’ECM. Suonato e registrato benissimo beninteso, ma che non riesce a emozionare. Peccato perchè dal pezzo iniziale, What We Talk About When We Talk About Love, un incedere su piano e batteria ipnotico dove il trombone di Petrella si inserisce benissimo, fino a Ida Lupino, le premesse per un gran disco c’erano tutte. L’ottima intesa tra i musicisti, rende l’ascolto molto piacevole anche se molto riflessivo, i colori e i ritmi si sovrappongo in maniera ottimale. (Continua a leggere)
Erano anni che non mi avvicinavo più all’ECM. La curiosità di sentire il SoupStar, che dal vivo mi ha sempre emozionato, con l’aggiunta di due musicisti come Louis Sclavis e Gerald Cleaver mi fatto saltare l’ostacolo. Inoltre anche la presenza di un brano che amo, Ida Lupino, ha fatto da par suo. Nonostante queste premesse, il disco purtroppo conferma le stesse caratteristiche “nordiche” dell’ECM. Suonato e registrato benissimo beninteso, ma che non riesce a emozionare. Peccato perchè dal pezzo iniziale, What We Talk About When We Talk About Love, un incedere su piano e batteria ipnotico dove il trombone di Petrella si inserisce benissimo, fino a Ida Lupino, le premesse per un gran disco c’erano tutte. L’ottima intesa tra i musicisti, rende l’ascolto molto piacevole anche se molto riflessivo, i colori e i ritmi si sovrappongo in maniera ottimale. (Continua a leggere)
 Dopo una notevole serie di album autoprodotti e la vittoria della Thelonious Monk Competition 2014, il trombettista Marquis Hill approda su una casa discografica di spicco, guadagnandosi l’opportunità di farsi conoscere presso un pubblico più ampio. ‘The Way We Play’ schiera una band rodatissima, il fido Blacktet (in cui spiccano in particolar modo la batteria di Mkaya McCraven e il vibrafono di Justin Thomas) al gran completo, e si pone l’obiettivo riammodernare il repertorio jazzistico con originali riletture di standard (‘Moon Rays’, ‘My Foolish Heart’, ‘Polka Dots’, ‘Maiden Voyage’, ‘Straight No Chaser’, una splendida ‘Moon Rays’) e di rappresentare l’anima musicale di Chicago. Non per niente il disco viene introdotto da una rielaborazione del tema dei Bulls, su cui viene annunciata la formazione al completo, da Makaya McCraven fino al leader. (Continua a leggere)
Dopo una notevole serie di album autoprodotti e la vittoria della Thelonious Monk Competition 2014, il trombettista Marquis Hill approda su una casa discografica di spicco, guadagnandosi l’opportunità di farsi conoscere presso un pubblico più ampio. ‘The Way We Play’ schiera una band rodatissima, il fido Blacktet (in cui spiccano in particolar modo la batteria di Mkaya McCraven e il vibrafono di Justin Thomas) al gran completo, e si pone l’obiettivo riammodernare il repertorio jazzistico con originali riletture di standard (‘Moon Rays’, ‘My Foolish Heart’, ‘Polka Dots’, ‘Maiden Voyage’, ‘Straight No Chaser’, una splendida ‘Moon Rays’) e di rappresentare l’anima musicale di Chicago. Non per niente il disco viene introdotto da una rielaborazione del tema dei Bulls, su cui viene annunciata la formazione al completo, da Makaya McCraven fino al leader. (Continua a leggere)
 A volte mi domando cosa sarebbe successo alla Cappella Sistina se il Buonarroti nel ricevere l’incarico di ridipingerla avesse dovuto subire dal suo finanziatore, Papa Giulio II, serie ingerenze su come svolgerlo. Ben si sa che il mecenatismo ha avuto un ruolo decisivo nella produzione della grande arte rinascimentale e il paragone, apparentemente paradossale, mi è venuto in mente mentre ascoltavo questo disco ben suonato ma inaspettatamente noioso di Avishai Cohen, trombettista israeliano ma operativo a New York, giustamente tra i più acclamati sulla scena jazzistica contemporanea e recentemente approdato alla scuderia ECM di Manfred Eicher. Il noto produttore tedesco sembra infatti avere la capacità di far suonare qualsiasi musicista che ingaggi allo stesso modo, secondo una estetica che sembra richiedere al musicista di turno più o meno volutamente, o semplicemente in forma indotta (non saprei stabilire precisamente in questo caso), di conformarsi ad un “suono” ben preciso, proprio della linea che identifica da anni la casa discografica stessa. (Continua a leggere)
A volte mi domando cosa sarebbe successo alla Cappella Sistina se il Buonarroti nel ricevere l’incarico di ridipingerla avesse dovuto subire dal suo finanziatore, Papa Giulio II, serie ingerenze su come svolgerlo. Ben si sa che il mecenatismo ha avuto un ruolo decisivo nella produzione della grande arte rinascimentale e il paragone, apparentemente paradossale, mi è venuto in mente mentre ascoltavo questo disco ben suonato ma inaspettatamente noioso di Avishai Cohen, trombettista israeliano ma operativo a New York, giustamente tra i più acclamati sulla scena jazzistica contemporanea e recentemente approdato alla scuderia ECM di Manfred Eicher. Il noto produttore tedesco sembra infatti avere la capacità di far suonare qualsiasi musicista che ingaggi allo stesso modo, secondo una estetica che sembra richiedere al musicista di turno più o meno volutamente, o semplicemente in forma indotta (non saprei stabilire precisamente in questo caso), di conformarsi ad un “suono” ben preciso, proprio della linea che identifica da anni la casa discografica stessa. (Continua a leggere)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Chiodi nella bara
- Wayne Shorter: il compositore
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz

