avant jazz's Articles
 Dall’ultimo ‘Vista Accumulation’ del 2015, Matt Mitchell non ha avuto un attimo di tregua. Ha suonato sui dischi pubblicati recentemente da Dan Weiss (il deludente ‘Sixteen: Drummers Suite’ del 2016), Steve Coleman (l’intrigante ‘Morphogenesis’, uscito quest’anno) e Tim Berne (‘Incidentals’, edito a settembre per ECM), tra gli altri; e solo a marzo pubblicava ‘FØRAGE’, una sua personale – ma prescindibile – rilettura in solo piano di alcune composizioni proprio di Tim Berne, volta ad omaggiare uno dei più importanti ascendenti sulla sua crescita musicale.
Dall’ultimo ‘Vista Accumulation’ del 2015, Matt Mitchell non ha avuto un attimo di tregua. Ha suonato sui dischi pubblicati recentemente da Dan Weiss (il deludente ‘Sixteen: Drummers Suite’ del 2016), Steve Coleman (l’intrigante ‘Morphogenesis’, uscito quest’anno) e Tim Berne (‘Incidentals’, edito a settembre per ECM), tra gli altri; e solo a marzo pubblicava ‘FØRAGE’, una sua personale – ma prescindibile – rilettura in solo piano di alcune composizioni proprio di Tim Berne, volta ad omaggiare uno dei più importanti ascendenti sulla sua crescita musicale.
A settembre Mitchell è tornato quindi con il suo terzo effettivo full-length da leader, come al solito edito dalla Pi, intitolato ‘A Pouting Grimace’. Distanziandosi dalle formazioni ridotte dei suoi lavori precedenti, Mitchell questa volta si circonda di alcuni dei più dotati musicisti della scena avant-jazz americana contemporanea – dai classici collaboratori Dan Weiss e Ches Smith a Sara Schoenbeck, Jon Irabagon e Anna Webber, scomodando anche Tyshawn Sorey (cui è affidato il prestigioso ruolo di direttore del complesso) –, organizzandoli in complessi dall’estensione variabile tra i cinque e i tredici elementi. (Continua a leggere)
STEVE LEHMAN – Sélébéyone (Pi Recordings, 2016)
 Che Steve Lehman fosse un artista estremamente eterodosso si era capito già da tempo: il suo passato come studente di Anthony Braxton e Jackie McLean, insieme a una mole di ascolti eterogenei che spaziano dagli A Tribe Called Quest a Harry Partch, l’hanno portato nell’ultimo decennio a coniare un idioma originale e innovativo che rielabora l’avant-jazz alla luce della sua personale teoria compositiva dell’M-base. A questo si era aggiunto, negli ultimi eccellenti ‘Travail, Transformation, and Flow’ (2009) e ‘Mise en Abîme’ (2014), uno studio sulle possibilità di adottare le tecniche compositive dello spettralismo alla musica jazz, con risultati ulteriormente esotici. (Continua a leggere)
Che Steve Lehman fosse un artista estremamente eterodosso si era capito già da tempo: il suo passato come studente di Anthony Braxton e Jackie McLean, insieme a una mole di ascolti eterogenei che spaziano dagli A Tribe Called Quest a Harry Partch, l’hanno portato nell’ultimo decennio a coniare un idioma originale e innovativo che rielabora l’avant-jazz alla luce della sua personale teoria compositiva dell’M-base. A questo si era aggiunto, negli ultimi eccellenti ‘Travail, Transformation, and Flow’ (2009) e ‘Mise en Abîme’ (2014), uno studio sulle possibilità di adottare le tecniche compositive dello spettralismo alla musica jazz, con risultati ulteriormente esotici. (Continua a leggere)
 Bellissimo lavoro dei Dissoi Logoi, formazione ormai storica dell’avanguardia musicale italiana che fa della commistione di linguaggi la propria cifra stilistica. Il titolo ‘Nyx’ significa “notte” in greco antico (Nύξ), inteso come divinità primordiale, madre degli Oneroi (Sogni), ma anche di Thanatos (Morte). Ed è proprio in un viaggio notturno, senza dimensione, che questi 12 brani ci accompagnano esplorando, narrando, improvvisando e mescolando, con sapienza e gusto, timbri, ritmi, citazioni, armonie e melodie. All’ascolto emergono alcune caratteristiche ricorrenti che connotano l’opera: una tendenza onirica, la capacità di tessere trame melodiche ben disegnate, giocando con contrappunti, imitazioni, improvvisazione, ostinati, un’ottima miscela di strumentazioni acustiche e elettroniche che propone ambientazioni sonore ben delineate, grazie anche a un intelligente modo di usare il live electronics e infine ritmo e metro, protagonisti di ogni traccia. (Continua a leggere)
Bellissimo lavoro dei Dissoi Logoi, formazione ormai storica dell’avanguardia musicale italiana che fa della commistione di linguaggi la propria cifra stilistica. Il titolo ‘Nyx’ significa “notte” in greco antico (Nύξ), inteso come divinità primordiale, madre degli Oneroi (Sogni), ma anche di Thanatos (Morte). Ed è proprio in un viaggio notturno, senza dimensione, che questi 12 brani ci accompagnano esplorando, narrando, improvvisando e mescolando, con sapienza e gusto, timbri, ritmi, citazioni, armonie e melodie. All’ascolto emergono alcune caratteristiche ricorrenti che connotano l’opera: una tendenza onirica, la capacità di tessere trame melodiche ben disegnate, giocando con contrappunti, imitazioni, improvvisazione, ostinati, un’ottima miscela di strumentazioni acustiche e elettroniche che propone ambientazioni sonore ben delineate, grazie anche a un intelligente modo di usare il live electronics e infine ritmo e metro, protagonisti di ogni traccia. (Continua a leggere)
 Matt Mitchell, nonostante abbia esordito solo nel 2013 con Fiction, pubblicato dalla Pi Recordings in duo con Ches Smith, è già da anni uno dei pianisti più celebrati e richiesti nella scena avant-jazz americana. Grazie a una notevole preparazione tecnica e accademica (tra i vari impegni, è anche insegnante in diverse scuole di New York come la School for Improvisational Music e la New School), sono diversi i musicisti che si sono avvalsi del suo talento: il suo curriculum vanta collaborazioni con personaggi come Tim Berne. Dave Douglas, Kenny Wheeler e David Torn, la partecipazione ad alcuni dei dischi più notevoli del jazz contemporaneo (come ‘Fourteen’ di Dan Weiss l’anno scorso e ‘Bird Calls‘ di Rudresh Mahanthappa, candidato fin dalla sua uscita a inizio anno ad essere una delle release jazz migliori del 2015), e perfino un fugace flirt con la band avant-prog Thinking Plague (con cui ha suonato su A History of Madness del 2003). Proprio per questo, stupisce relativamente che la sua seconda prova da leader con il doppio album ‘Vista Accumulation’ (pubblicato nel 2015 dalla Pi Recordings, che si conferma nuovamente come una delle label più importanti degli anni Dieci nell’ambito jazz) mostri una visione di insieme così ampia e profonda. (Continua a leggere)
Matt Mitchell, nonostante abbia esordito solo nel 2013 con Fiction, pubblicato dalla Pi Recordings in duo con Ches Smith, è già da anni uno dei pianisti più celebrati e richiesti nella scena avant-jazz americana. Grazie a una notevole preparazione tecnica e accademica (tra i vari impegni, è anche insegnante in diverse scuole di New York come la School for Improvisational Music e la New School), sono diversi i musicisti che si sono avvalsi del suo talento: il suo curriculum vanta collaborazioni con personaggi come Tim Berne. Dave Douglas, Kenny Wheeler e David Torn, la partecipazione ad alcuni dei dischi più notevoli del jazz contemporaneo (come ‘Fourteen’ di Dan Weiss l’anno scorso e ‘Bird Calls‘ di Rudresh Mahanthappa, candidato fin dalla sua uscita a inizio anno ad essere una delle release jazz migliori del 2015), e perfino un fugace flirt con la band avant-prog Thinking Plague (con cui ha suonato su A History of Madness del 2003). Proprio per questo, stupisce relativamente che la sua seconda prova da leader con il doppio album ‘Vista Accumulation’ (pubblicato nel 2015 dalla Pi Recordings, che si conferma nuovamente come una delle label più importanti degli anni Dieci nell’ambito jazz) mostri una visione di insieme così ampia e profonda. (Continua a leggere)

I più attenti ricorderanno che William Parker, assieme ad altri ospiti, ha già suonato con gli Udu Calls (alias il fiatista Daniele Cavallanti e il batterista Tiziano Tononi) in occasione di ‘Spirits Up Above’ del 2006. ‘The Vancouver Tapes’, che vede coinvolti solo i due musicisti nostrani e il bassista della Grande Mela, non rappresenta però il passo successivo a quella collaborazione, bensì una sorta di prequel. Le registrazioni risalgono infatti al Vancouver Jazz Festival del 1999, frutto di un DAT inaspettatamente ritrovato da Tononi. La qualità audio è, prevedibilmente, abbastanza cruda (ma comunque più che sufficiente), fattore che se da una parte potrebbe scoraggiare certi puristi del suono, dall’altra riesce a rendere bene l’idea dell’impatto e della “ruvidità” che il trio ha sprigionato sul palco quel giorno di Giugno di ormai quasi sedici anni fa. (Continua a leggere)
‘Conversations I’ parte e per un po’ non succede molto: solito free jazz sghembo, qualche strombazzata qui e lì, giusto un’altra tacca da aggiungere alla discografia di Roscoe Mitchell. Poi dopo 3 minuti i nostri partono per la tangente e ‘Knock’N'Roll’, questo il titolo della prima traccia, si trasforma in una specie di cataclisma: un muro del suono impressionante e gratuitamente violento che, a conti fatti, resta quasi l’unica cosa da ricordare. Non che siano i primi a tentare la carta dell’impatto, anzi, ma impressiona come in tre siano in grado di fare casino per trenta.
Per il resto il disco scorre via tra alti e bassi lasciando poche tracce: il sax di Mitchell preferisce mantenersi su atmosfere calme, giocando, come suo solito, con gli spazi, ma i risultati non incidono (i 15 soporiferi minuti di ‘Distant Radio Transmission’ sono qualcosa di insostenibile). (Continua a leggere)
WILD BREAD 17/05/2013 @Filanda Motta, Treviso

Ennesimo appuntamento di qualità alla Filanda Motta. La formazione dei Wild Bread (Daniele D’Agaro, clarinetti e sax tenore; Mauro Ottolini, trombone; Giovanni Maier, basso; Cristiano Calcagnile, batteria e percussioni) presenta una scaletta che varia da Ellington a composizioni più ricercate, riuscendo anche a coinvolgere i più restii col fascino delle musiche “difficili”. Da tali musicisti si pretenderebbe anche qualche volo più azzardato, ma comunque si è trattato di un concerto di buon livello anche per il feeling che si è venuto a creare con il pubblico, dovuto forse alla sana dose di ironia di Ottolini in contrasto con la “seriosità” di Maier. (Continua a leggere)
 Il merito principale dei Bad Uok, quartetto di base a Bologna, è la codifica di un linguaggio personalissimo, e la cosa non è affatto scontata, sia perché ‘Enter’ è il loro esordio assoluto, sia per l’età relativamente giovane dei musicisti (tutti under 30). La ricerca di un’impronta riconoscibile parte sin dalla configurazione della line-up, che decide di fare a meno del basso: nonostante ciò, ‘Enter’ è un disco in cui la ritmica e le basse frequenze giocano una parte importantissima, forse proprio perché il suddetto risultato viene cercato rimpiazzando il ruolo delle quattro corde con strumenti dal tono altrettanto “oscuro” come il trombone (suonato da Federico Pierantoni), il Fender Rhodes (a cura del pianista Andrea Calì), finanche, in alcuni episodi, la chitarra baritona di Leonardo Rizzi.
Il merito principale dei Bad Uok, quartetto di base a Bologna, è la codifica di un linguaggio personalissimo, e la cosa non è affatto scontata, sia perché ‘Enter’ è il loro esordio assoluto, sia per l’età relativamente giovane dei musicisti (tutti under 30). La ricerca di un’impronta riconoscibile parte sin dalla configurazione della line-up, che decide di fare a meno del basso: nonostante ciò, ‘Enter’ è un disco in cui la ritmica e le basse frequenze giocano una parte importantissima, forse proprio perché il suddetto risultato viene cercato rimpiazzando il ruolo delle quattro corde con strumenti dal tono altrettanto “oscuro” come il trombone (suonato da Federico Pierantoni), il Fender Rhodes (a cura del pianista Andrea Calì), finanche, in alcuni episodi, la chitarra baritona di Leonardo Rizzi.
Per convenienza potremmo definirli avant-jazz: quello dei Bad Uok è un melting pot stilistico in cui convivono passaggi ambient e momenti intimisti (l’intro pianistica che apre il disco, formula ripresa anche nella conclusiva title-track), scorie elettroniche, free jazz e improvvisazione pura, ma anche intricate ritmiche di stampo math rock (che non sfociano mai nel jazzcore vero e proprio) e atmosfere “cinematiche” (Continua a leggere)
Grazie all’instancabile Jacqueline, organizzatrice di queste serate dedicate agli artisti svizzeri, ho avuto la fortuna di ascoltare una delle più famose suonatrici di pipa (segaioli non pensate subito a quello!), uno strumento a corde della tradizione millenaria cinese. La Yang, che ha anche collaborato con Pierre Favre, noto improvvisatore svizzero, ha dato a questo strumento una nuova vita. Pensavo di andare ad ascoltare musica di sottofondo dei ristoranti cinesi, e invece la creatività dei due a dato luogo a un concerto dei più interessanti, tra quelli che ho seguito. Christy Doran, chitarrista con un passato tra rock, jazz, prog e chi più ne ha più ne metta, ha creato un perfetto interplay con la Yang, non sovrastandola con volumi di suono, ma accompagnandola in maniera discreta e sostanziosa. Una musica fondamentalmente rilassata, che prende spunto soprattutto dalla tradizione cinese, ma le variazioni create dai due la portano a livelli completamente differenti. (Continua a leggere)
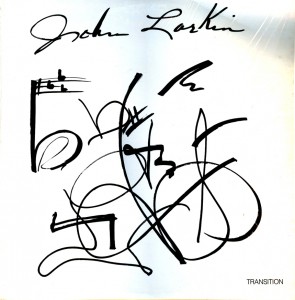 L’anno era il 1995. Forse l’ultimo della stagione d’oro della cosiddetta eurodance, che di lì a poco avrebbe sparato i fuochi conclusivi. In mezzo a tante canzoni che impazzavano tra radio, TV e discoteche ce n’era una in particolare che si distingueva dalle altre, e non c’è bisogno di chissà quale memoria per ricordarla. Non la cantavano ragazze dalla voce squillante né qualche nerboruto rapper: l’insolito interprete era un signore sulla cinquantina dall’aria simpatica, riconoscibilissimo per la Fedora alla Tom Landry sempre incollata sul cranio e il baffo pronunciato modello birra Moretti. Su quella base fatta su misura per le piste da ballo dell’epoca, costui si esibiva in attorciglianti scioglilingua in stile scat, e infatti si presentava con un nome che era tutto un programma: Scatman John. I milioni li fece con un ritornello martellante che per tutti era una cosa tipo bi bo bo bo bobò (scopro solo oggi che, a quanto pare, diceva ski ba bop ba dop dop. Potenza dell’internet), completato da un testo motivational (“Don’t let nothin’ hold you back / If the Scatman can do it so can you”) che spiegava come quel tipo di cantato jazz avesse aiutato lui, balbuziente, ad accettare quel difetto di pronuncia che per anni l’aveva condizionato, spingendolo persino a un passo dal baratro: “Avevo così tanta vergogna della mia balbuzie che per anni mi sono quasi ucciso con alcool e droghe”, rivelava in un’intervista. (Continua a leggere)
L’anno era il 1995. Forse l’ultimo della stagione d’oro della cosiddetta eurodance, che di lì a poco avrebbe sparato i fuochi conclusivi. In mezzo a tante canzoni che impazzavano tra radio, TV e discoteche ce n’era una in particolare che si distingueva dalle altre, e non c’è bisogno di chissà quale memoria per ricordarla. Non la cantavano ragazze dalla voce squillante né qualche nerboruto rapper: l’insolito interprete era un signore sulla cinquantina dall’aria simpatica, riconoscibilissimo per la Fedora alla Tom Landry sempre incollata sul cranio e il baffo pronunciato modello birra Moretti. Su quella base fatta su misura per le piste da ballo dell’epoca, costui si esibiva in attorciglianti scioglilingua in stile scat, e infatti si presentava con un nome che era tutto un programma: Scatman John. I milioni li fece con un ritornello martellante che per tutti era una cosa tipo bi bo bo bo bobò (scopro solo oggi che, a quanto pare, diceva ski ba bop ba dop dop. Potenza dell’internet), completato da un testo motivational (“Don’t let nothin’ hold you back / If the Scatman can do it so can you”) che spiegava come quel tipo di cantato jazz avesse aiutato lui, balbuziente, ad accettare quel difetto di pronuncia che per anni l’aveva condizionato, spingendolo persino a un passo dal baratro: “Avevo così tanta vergogna della mia balbuzie che per anni mi sono quasi ucciso con alcool e droghe”, rivelava in un’intervista. (Continua a leggere)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Chiodi nella bara
- Wayne Shorter: il compositore
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz


