vocal jazz's Articles
 Ne abbiamo parlato spesso: gente che si trova a un punto della carriera (artistica ma non necessariamente musicale) più o meno morto, e allora tenta la fatidica carta del disco jazz per “rifarsi una verginità”. Qualche volta la mossa riesce bene – penso a Lee Aaron o a Marla Gibbs – altre volte non brilla, ma neanche fa troppi danni (come il disco di Molly Ringwald di cui abbiamo parlato di recente), ma nella maggior parte dei casi ci troviamo davanti a schifezze senza possibilità di redenzione (non ultimo il buon Joe Jackson che si avventa sulla carcassa di Ellington). È sulla scia di questi che andiamo a ripescare dal passato recente un’iniziativa analoga come ‘Passing Strangers’.
Ne abbiamo parlato spesso: gente che si trova a un punto della carriera (artistica ma non necessariamente musicale) più o meno morto, e allora tenta la fatidica carta del disco jazz per “rifarsi una verginità”. Qualche volta la mossa riesce bene – penso a Lee Aaron o a Marla Gibbs – altre volte non brilla, ma neanche fa troppi danni (come il disco di Molly Ringwald di cui abbiamo parlato di recente), ma nella maggior parte dei casi ci troviamo davanti a schifezze senza possibilità di redenzione (non ultimo il buon Joe Jackson che si avventa sulla carcassa di Ellington). È sulla scia di questi che andiamo a ripescare dal passato recente un’iniziativa analoga come ‘Passing Strangers’.
La carriera di Tony Hadley comunque, almeno quella solista dopo i fantastilioni di copie venduti con gli Spandau Ballet, più che a un punto morto non era mai decollata: dell’uscita di ‘The State Of Play’, l’esordio in proprio, se ne accorse giusto qualcuno in Italia (paese dove, strano ma vero, gente come Spandau e Duran ha continuato a mantenere uno zoccolo durissimo anche quando il resto del mondo provava a seppellirli nell’oblio delle vecchie glorie con malcelato imbarazzo). (Continua a leggere)

Dell’interesse per il jazz dell’attrice americana Molly Ringwald avevamo già parlato, e ora che il suo album d’esordio arriva finalmente nei negozi possiamo anche dire che la nostra intuizione non era sbagliata: alla base dell’operazione c’è tanta passione. Un amore che trapela anche dalla selezione dei brani, che tributano il great american songbook senza fare scelte troppo ovvie, anzi, andando a scandagliare in profondità evitando “i soliti noti”. Un labor of love, direbbero gli inglesi, e per questo tanta stima per Molly, anche se purtroppo i buoni propositi non si traducono automaticamente in buoni dischi. E qui arrivano le note dolenti. Non perché la Ringwald non sappia cantare, anzi: la sua voce nasale e a tratti “sottile” non riscriverà la storia, ma di certo si dimostra tranquilla e a proprio agio, assolvendo più che bene il compito. Il problema vero, semmai, è l’eccessiva morigeratezza dell’insieme: la scaletta privilegia le ballad o pezzi comunque dal basso potenziale ritmico. (Continua a leggere)
YOUN SUN NAH – Lento (2013, ACT)
 “A Miracle”, “A great work of art”, “A world-class singer” – così venivano acclamati e osannati dalla critica internazionale ‘Voyge’ e ‘Same Girl’, quest’ultimo premiato nel 2011 con il Prix du Jazz Vocal in Francia e con l’ECHO in Germania. Youn Sun Nah, classe 1969, coreana di nascita, parigina d’adozione, non sbaglia un colpo. Ormai colonna portante del catalogo ACT (‘Same Girl’ vende 150.000 copie, numeri da far invidia anche all’industria pop, di questi tempi), può vantare una camaleontica capacità di intendere ed esprimere la musica senza confini geografici e stilistici. Carillon, musica tradizionale coreana, nujazz, fino ad arrivare ai Metallica (dei quali ha ripreso, su ‘Same Girl’, ‘Enter Sandman‘): Nah modella la voce, ora potente, ora calda, ora acuta e tagliente, portando il pubblico in un susseguirsi di sensazioni diverse per ogni pezzo, coinvolgendolo in una comunicazione commovente e potente allo stesso tempo. (Continua a leggere)
“A Miracle”, “A great work of art”, “A world-class singer” – così venivano acclamati e osannati dalla critica internazionale ‘Voyge’ e ‘Same Girl’, quest’ultimo premiato nel 2011 con il Prix du Jazz Vocal in Francia e con l’ECHO in Germania. Youn Sun Nah, classe 1969, coreana di nascita, parigina d’adozione, non sbaglia un colpo. Ormai colonna portante del catalogo ACT (‘Same Girl’ vende 150.000 copie, numeri da far invidia anche all’industria pop, di questi tempi), può vantare una camaleontica capacità di intendere ed esprimere la musica senza confini geografici e stilistici. Carillon, musica tradizionale coreana, nujazz, fino ad arrivare ai Metallica (dei quali ha ripreso, su ‘Same Girl’, ‘Enter Sandman‘): Nah modella la voce, ora potente, ora calda, ora acuta e tagliente, portando il pubblico in un susseguirsi di sensazioni diverse per ogni pezzo, coinvolgendolo in una comunicazione commovente e potente allo stesso tempo. (Continua a leggere)
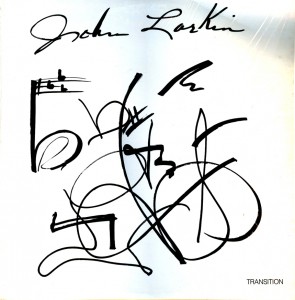 L’anno era il 1995. Forse l’ultimo della stagione d’oro della cosiddetta eurodance, che di lì a poco avrebbe sparato i fuochi conclusivi. In mezzo a tante canzoni che impazzavano tra radio, TV e discoteche ce n’era una in particolare che si distingueva dalle altre, e non c’è bisogno di chissà quale memoria per ricordarla. Non la cantavano ragazze dalla voce squillante né qualche nerboruto rapper: l’insolito interprete era un signore sulla cinquantina dall’aria simpatica, riconoscibilissimo per la Fedora alla Tom Landry sempre incollata sul cranio e il baffo pronunciato modello birra Moretti. Su quella base fatta su misura per le piste da ballo dell’epoca, costui si esibiva in attorciglianti scioglilingua in stile scat, e infatti si presentava con un nome che era tutto un programma: Scatman John. I milioni li fece con un ritornello martellante che per tutti era una cosa tipo bi bo bo bo bobò (scopro solo oggi che, a quanto pare, diceva ski ba bop ba dop dop. Potenza dell’internet), completato da un testo motivational (“Don’t let nothin’ hold you back / If the Scatman can do it so can you”) che spiegava come quel tipo di cantato jazz avesse aiutato lui, balbuziente, ad accettare quel difetto di pronuncia che per anni l’aveva condizionato, spingendolo persino a un passo dal baratro: “Avevo così tanta vergogna della mia balbuzie che per anni mi sono quasi ucciso con alcool e droghe”, rivelava in un’intervista. (Continua a leggere)
L’anno era il 1995. Forse l’ultimo della stagione d’oro della cosiddetta eurodance, che di lì a poco avrebbe sparato i fuochi conclusivi. In mezzo a tante canzoni che impazzavano tra radio, TV e discoteche ce n’era una in particolare che si distingueva dalle altre, e non c’è bisogno di chissà quale memoria per ricordarla. Non la cantavano ragazze dalla voce squillante né qualche nerboruto rapper: l’insolito interprete era un signore sulla cinquantina dall’aria simpatica, riconoscibilissimo per la Fedora alla Tom Landry sempre incollata sul cranio e il baffo pronunciato modello birra Moretti. Su quella base fatta su misura per le piste da ballo dell’epoca, costui si esibiva in attorciglianti scioglilingua in stile scat, e infatti si presentava con un nome che era tutto un programma: Scatman John. I milioni li fece con un ritornello martellante che per tutti era una cosa tipo bi bo bo bo bobò (scopro solo oggi che, a quanto pare, diceva ski ba bop ba dop dop. Potenza dell’internet), completato da un testo motivational (“Don’t let nothin’ hold you back / If the Scatman can do it so can you”) che spiegava come quel tipo di cantato jazz avesse aiutato lui, balbuziente, ad accettare quel difetto di pronuncia che per anni l’aveva condizionato, spingendolo persino a un passo dal baratro: “Avevo così tanta vergogna della mia balbuzie che per anni mi sono quasi ucciso con alcool e droghe”, rivelava in un’intervista. (Continua a leggere)
L’abbiamo apprezzata sul grande schermo in pilastri della nostra esistenza come ‘Breakfast Club’, ‘Pretty In Pink’ e ‘Sixteen Candles’ (di questi ultimi due lasciamo i titoli originali, che suonano di certo meglio di quelli adottati qui da noi), l’abbiamo stimata perchè se la faceva con AD Rock dei Beastie Boys, altro figuro degno di profondo rispetto, e da oggi per ammirarla abbiamo anche un motivo in più. “Sono cresciuta in una casa in cui girava tanta musica - dichiara l’attrice americana in un articolo riportato da All About Jazz – E ho apprezzato il jazz sin da tenera età perchè mio padre faceva il musicista e suonava proprio quel genere. Già da quando avevo tre anni iniziai a cantare con la sua band e sui suoi dischi, e da allora il jazz è rimasta una delle tre più grandi passioni della mia vita assieme alla recitazione e alla scrittura. Per me è come il ‘comfort food‘: è sempre al jazz che mi rivolgo, quando ho voglia di tornare alle origini”. (Continua a leggere)
Io, per motivi puramente anagrafici, Jula De Palma l’ho scoperta in netto ritardo. Di certo lei non mi ha “aiutato”, scomparendo letteralmente dalle scene a metà degli anni ’70, all’apice della maturità artistica. Non solo: a differenza di altri personaggi che, pur rinunciando alle apparizioni pubbliche, hanno mantenuto vivo l’interesse attorno al proprio nome continuando a produrre musica, il ritiro di Jula De Palma è stato quanto di più definitivo e “radicale” si possa immaginare. Insieme alla musica ha lasciato l’Italia in favore di una casetta in Canadà, dedicandosi per anni a un’attività imprenditoriale che con le sette note non c’entra neanche di striscio, senza cedere alle lusinghe di trasmissioni revivaliste e tricche tracche vari (e infatti quando accetta di tornare sullo schermo – qualche anno fa dall’incartapecorito Limiti – è più per un favore a un vecchio amico che per autocelebrazione). C’é poi da dire che la nostra oggi viene ricordata quasi esclusivamente per ‘Tua’, brano che a Sanremo ’59 fece scalpore in quanto troppo pruriginoso per le pudiche platee dei tempi, “scandalo” che le regalò le copertine di praticamente tutti i settimanali. Le partecipazioni a Sanremo, i successi nella musica più o meno leggera e la conduzione di programmi radiofonici e varietà televisivi la incoronarono come una delle donne di spettacolo più in vista dell’Italia anni ’50 e ’60, ma allo stesso tempo le impediscono oggi di ottenere la giusta considerazione agli occhi “puristi” degli appassionati di jazz. Ed è un peccato, perché Jula alle prese col jazz era una vera forza della natura. (Continua a leggere)
ESPERANZA SPALDING – Radio Music Society (2012, Heads Up)
 Quest’articolo avrebbe potuto uscire anche per la rubrica Filthy McNasty a titolo ‘Pròxima Estaciòn Esperanza’, ma a quel punto mi sarebbe toccato, a ragione, un lungo quarto d’ora di penitenza in ginocchio sui porcospini per aver iniziato il pezzo citando Manu Chao. Avrete già intuito che la metaforica stazione può essere una tra le tante che trasmetteranno i pezzi di ‘Radio Music Society’, nuovo album della bassista e cantante americana Esperanza Spalding, il quale, a neanche due settimane dall’uscita è già un caso diplomatico. Pomo della discordia è la sua categorizzazione, visto che in America viene “venduto” come contemporary jazz, etichetta peraltro talmente omnicomprensiva da aver smarrito qualunque barlume di significato.
Quest’articolo avrebbe potuto uscire anche per la rubrica Filthy McNasty a titolo ‘Pròxima Estaciòn Esperanza’, ma a quel punto mi sarebbe toccato, a ragione, un lungo quarto d’ora di penitenza in ginocchio sui porcospini per aver iniziato il pezzo citando Manu Chao. Avrete già intuito che la metaforica stazione può essere una tra le tante che trasmetteranno i pezzi di ‘Radio Music Society’, nuovo album della bassista e cantante americana Esperanza Spalding, il quale, a neanche due settimane dall’uscita è già un caso diplomatico. Pomo della discordia è la sua categorizzazione, visto che in America viene “venduto” come contemporary jazz, etichetta peraltro talmente omnicomprensiva da aver smarrito qualunque barlume di significato.
In realtà, più che la categorizzazione in se, a far discutere è l’“imbastardimento“ che, album dopo album (siamo ormai al quarto), ha portato la musica della Spalding verso derive senz’altro meno conservatrici. Il precedente ‘Chamber Music Society’ destò meno clamore: giocava (con risultati alterni, va detto) ad unire jazz e strumenti tipici della musica classica, cosa tutto sommato “tollerata” nell’ambiente. ‘Radio Music…’ invece tenta una sterzata più brusca, ammiccando sin dal titolo al mercato mainstream. (Continua a leggere)
Su Little Jimmy Scott avevo scritto un altro articolo. L’ho letto e riletto, ma non mi piaceva. Non lasciava trasparire bene il punto centrale della questione: la musica, quella di una delle voci più singolari del jazz. Magari limerò quello scritto e lo trasformerò in un 2.0, una sorta di compendio a queste righe. Non vi tedierò qui coi perché e i percome: per chi non è familiare col personaggio sia sufficiente sapere che la voce acuta e i tratti androgini sono imputabili a una malattia genetica, la Sindrome di Kalmann, che impedisce il completamento della pubertà. Né mi perderò in lunghe escursioni per spiegare i motivi per cui resta quasi due decadi lontano dai riflettori, sotto i quali viene riportato da David Lynch. È il 10 Giugno del 1991, il giorno dell’ultimo episodio di Twin Peaks. In quelli che probabilmente sono i 45 minuti più genuinamente “sbroccati” mai trasmessi dalla TV prime time, all’improvviso sbuca fuori Little Jimmy Scott in un’impressionante interpretazione di ‘Sycamore Trees’, testo del regista americano su musica del fido Angelo Badalamenti. Ricomincia tutto. (Continua a leggere)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- Chiodi nella bara
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Wayne Shorter: il compositore
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz



