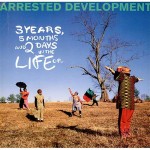hip hop's Articles
STEVE LEHMAN – Sélébéyone (Pi Recordings, 2016)
 Che Steve Lehman fosse un artista estremamente eterodosso si era capito già da tempo: il suo passato come studente di Anthony Braxton e Jackie McLean, insieme a una mole di ascolti eterogenei che spaziano dagli A Tribe Called Quest a Harry Partch, l’hanno portato nell’ultimo decennio a coniare un idioma originale e innovativo che rielabora l’avant-jazz alla luce della sua personale teoria compositiva dell’M-base. A questo si era aggiunto, negli ultimi eccellenti ‘Travail, Transformation, and Flow’ (2009) e ‘Mise en Abîme’ (2014), uno studio sulle possibilità di adottare le tecniche compositive dello spettralismo alla musica jazz, con risultati ulteriormente esotici. (Continua a leggere)
Che Steve Lehman fosse un artista estremamente eterodosso si era capito già da tempo: il suo passato come studente di Anthony Braxton e Jackie McLean, insieme a una mole di ascolti eterogenei che spaziano dagli A Tribe Called Quest a Harry Partch, l’hanno portato nell’ultimo decennio a coniare un idioma originale e innovativo che rielabora l’avant-jazz alla luce della sua personale teoria compositiva dell’M-base. A questo si era aggiunto, negli ultimi eccellenti ‘Travail, Transformation, and Flow’ (2009) e ‘Mise en Abîme’ (2014), uno studio sulle possibilità di adottare le tecniche compositive dello spettralismo alla musica jazz, con risultati ulteriormente esotici. (Continua a leggere)
HIP BOP 3.0: RED HOT & COOL
 Con un po’ di buona memoria di certo ricorderete la Red Hot Organization, associazione sin dai primi anni ’90 attiva nel raccogliere fondi per finanziare cause in legate alla lotta contro l’AIDS. In particolare, i proventi arrivano dalla pubblicazione di una serie di compilation a tema, contenenti materiale più o meno inedito di nomi abbastanza importanti, la cui qualità però negli anni è andata sfortunatamente scemando (agghiaccianti le uscite “latine”, per esempio). Agli inizi le cose erano di tutt’altro livello: si pensi alla terza raccolta, ‘No Alternative’, che, sfruttando il boom “alternativo” del periodo, riuniva sullo stesso disco Soundgarden e Beastie Boys, Soul Asylum e Sonic Youth, persino i Nirvana, con una strepitosa hidden track (‘Sappy’). Un anno dopo fu il momento di “sfruttare” a scopo benefico un altro filone particolarmente in voga, capace di garantire buoni proventi: l’ibrido tra hip hop e jazz.
Con un po’ di buona memoria di certo ricorderete la Red Hot Organization, associazione sin dai primi anni ’90 attiva nel raccogliere fondi per finanziare cause in legate alla lotta contro l’AIDS. In particolare, i proventi arrivano dalla pubblicazione di una serie di compilation a tema, contenenti materiale più o meno inedito di nomi abbastanza importanti, la cui qualità però negli anni è andata sfortunatamente scemando (agghiaccianti le uscite “latine”, per esempio). Agli inizi le cose erano di tutt’altro livello: si pensi alla terza raccolta, ‘No Alternative’, che, sfruttando il boom “alternativo” del periodo, riuniva sullo stesso disco Soundgarden e Beastie Boys, Soul Asylum e Sonic Youth, persino i Nirvana, con una strepitosa hidden track (‘Sappy’). Un anno dopo fu il momento di “sfruttare” a scopo benefico un altro filone particolarmente in voga, capace di garantire buoni proventi: l’ibrido tra hip hop e jazz.
‘Stolen Moments: Red Hot + Cool’ arriva dunque nel 1994, quando la fusione tra i due stili è all’apice della popolarità e la carica innovativa va inevitabilmente svanendo, cionondimeno offre tanto materiale nuovo (coi testi “in tema”) e una carrellata di accoppiamenti inediti. (Continua a leggere)
 Tra i musicisti della nuova generazione Robert Glasper si è già a più riprese segnalato come uno dei più interessanti: pianista tanto innamorato dei suoni più straight ahead quanto della contaminazione “intelligente”. Già il precedente ‘Double Booked’ aveva tratteggiato le due “facce” del musicista, tenendole però ben distinte: c’erano i momenti puramente jazz e c’erano quelli più elaborati. ‘Black Radio’ è il passo successivo, l’amalgama: un caleidoscopio di influenze che vanno oltre la mera somma delle parti, figlie di un’opera di sintesi eccellente che non suona mai, proprio mai forzata.
Tra i musicisti della nuova generazione Robert Glasper si è già a più riprese segnalato come uno dei più interessanti: pianista tanto innamorato dei suoni più straight ahead quanto della contaminazione “intelligente”. Già il precedente ‘Double Booked’ aveva tratteggiato le due “facce” del musicista, tenendole però ben distinte: c’erano i momenti puramente jazz e c’erano quelli più elaborati. ‘Black Radio’ è il passo successivo, l’amalgama: un caleidoscopio di influenze che vanno oltre la mera somma delle parti, figlie di un’opera di sintesi eccellente che non suona mai, proprio mai forzata.
In realtà sulla carta qualche dubbio potrebbe sorgere: il quartetto base (Glasper, il sassofonista Casey Benjamin, il bassista Derrick Hodge, il batterista Chris ‘Daddy’ Dave) è rimpolpato da un’infinita schiera di ospiti e tra i pezzi non originali figurano alcune scelte che potrebbero lasciare quantomeno perplessi. Basta un ascolto però per rendersi conto che mai come stavolta i pregiudizi non hanno ragion d’essere: tutti gli “intrusi” si mettono al servizio dei brani e ne diventano spesso il valore aggiunto, evitando che il tutto sembri una specie di compilation. E infatti l’atmosfera generale segue un discorso unitario che unisce jazz e hip hop, elettronica e R&B, funk e neo soul, privilegiando atmosfere “notturne” e rilassate. (Continua a leggere)
L’avevamo già anticipato nel pezzo su Guru: nella manica c’era pronto un piccolo compendio della golden age del cosiddetto jazz rap. Grossomodo un quinquennio (’88 – ’93) in cui iniziano a germogliare i semi gettati anni prima dai vari precursori (dal Miles di ‘On The Corner’ a Gil Scott-Heron, la lista è ben nota) e l’hip hop apre le sue vedute non solo al jazz, ma alle contaminazioni più disparate. Un matrimonio che, una volta celebrato, resisterà anche quando gli anni delle maggiori fortune commerciali saranno storia vecchia, sfornando proposte interessanti su entrambe le sponde “della barricata” (vi abbiamo già parlato di Russell Gunn, per esempio). Intanto godetevi questa piccola selezione di dischi focalizzata sui cinque anni fondamentali: quasi ognuno di questi titoli meriterebbe un più approfondito articolo a parte, il che però ci porterebbe eccessivamente fuori tema, considerando che ci troviamo sulle pagine di un sito jazz. Non è escluso che possa arrivare più avanti una terza puntata, comunque. (Continua a leggere)
“L’hip hop è il figlio del be bop”: a propugnare la teoria con queste parole fu un pezzo da novanta come Max Roach, non certo uno qualunque. In ambito jazz però non furono in molti a condividerne il pensiero. Certo, il senso delle sue parole non era letterale, voleva semmai evidenziare quella linea, immaginaria ma facilmente individuabile, che parte dagli spoken word su base intrisa di jazz di Gil Scott Heron , passa per l’Herbie Hancock electro-funk di ‘Rockit’ e arriva a precursori come i rapper Gang Starr, che all’esordio stupivano campionando ‘Night In Tunisia’ per la loro ‘Words I Manifest’, che spianava la strada agli exploit dei vari A Tribe Called Quest, De La Soul o Digable Planets, che pure imbottirono i loro album di campionamenti presi a prestito dal jazz con risultati freschi ed entusiasmanti, dimostrando come la sintesi tra i due generi fosse tutt’altro che inattuabile. Proprio durante il momento di massima popolarità di questi ultimi nomi il discorso compirà un’ulteriore, decisiva sterzata grazie all’intuito di uno dei suoi primi teorizzatori. (Continua a leggere)
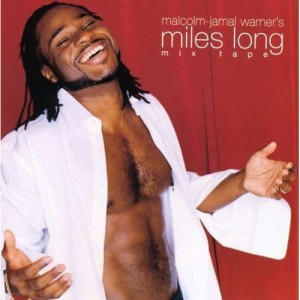 ‘L’album dei Robinson’ è il titolo con cui, mi pare, a metà degli anni ’90 venivano trasmesse in TV le repliche del ben noto telefilm di Bill Cosby. L’album che interessa a noi, però, è qualcosa di più letterale: un disco vero. Che la serie avesse un legame particolare col jazz è risaputo: guest star come Dizzy Gillespie e Nancy Wilson, riferimenti plurimi nelle trame di numerosi episodi, per non parlare della sigla dell’ultima stagione, interpretata da Lester Bowie. Le premesse sarebbero persino buone, resta però un fatto quasi incontestabile: ogni volta che un personaggio più o meno noto, sia esso un attore, uno sportivo o quel che volete, si gioca la carta della musica, i risultati sono da hall of shame. L’elenco è lungo e agghiacciante: da Brian Austin Green (il David di Beverly Hills 90210) e Macho Man Randy Savage che giocano a fare i rapper, al tremebondo pop-rock latino di Abel Balbo, fino ad arrivare al re dei re, l’immarcescibile David Hasselhoff. Ci fermiamo qui per non sconfinare troppo, ma vi basti sapere che scavare in acque ancor più torbide è possibile. (Continua a leggere)
‘L’album dei Robinson’ è il titolo con cui, mi pare, a metà degli anni ’90 venivano trasmesse in TV le repliche del ben noto telefilm di Bill Cosby. L’album che interessa a noi, però, è qualcosa di più letterale: un disco vero. Che la serie avesse un legame particolare col jazz è risaputo: guest star come Dizzy Gillespie e Nancy Wilson, riferimenti plurimi nelle trame di numerosi episodi, per non parlare della sigla dell’ultima stagione, interpretata da Lester Bowie. Le premesse sarebbero persino buone, resta però un fatto quasi incontestabile: ogni volta che un personaggio più o meno noto, sia esso un attore, uno sportivo o quel che volete, si gioca la carta della musica, i risultati sono da hall of shame. L’elenco è lungo e agghiacciante: da Brian Austin Green (il David di Beverly Hills 90210) e Macho Man Randy Savage che giocano a fare i rapper, al tremebondo pop-rock latino di Abel Balbo, fino ad arrivare al re dei re, l’immarcescibile David Hasselhoff. Ci fermiamo qui per non sconfinare troppo, ma vi basti sapere che scavare in acque ancor più torbide è possibile. (Continua a leggere)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- Chiodi nella bara
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Wayne Shorter: il compositore
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz