Recensioni's Articles
 Il successo, seguito in Italia da assurde polemiche, del sassofonosta losangeleno Kamasi Washington ha portato all’attenzione del pubblico il West Coast Get Down, un collettivo di musicisti attivo sulla costa californiana e in studio per vari grandi nomi del soul e dell’hip-hop. Il pianista Cameron Graves, naturalmente, fa parte di questo collettivo e con ‘Planetary Prince’ pubblica il suo primo album direttamente per Mack Avenue. Alla guida di un sestetto con basso elettrico ed espressiva frontline (Philip Dizack alla tromba, Ryan Porter al trombone, Kamasi Washington al sax), Graves si mette mostra innanzitutto per uno stile barocco, esagerato, percussivo e frastornante che porta all’eccesso la lezione di McCoy Tyner, Chick Corea, Don Pullen e Keith Jarrett. (Continua a leggere)
Il successo, seguito in Italia da assurde polemiche, del sassofonosta losangeleno Kamasi Washington ha portato all’attenzione del pubblico il West Coast Get Down, un collettivo di musicisti attivo sulla costa californiana e in studio per vari grandi nomi del soul e dell’hip-hop. Il pianista Cameron Graves, naturalmente, fa parte di questo collettivo e con ‘Planetary Prince’ pubblica il suo primo album direttamente per Mack Avenue. Alla guida di un sestetto con basso elettrico ed espressiva frontline (Philip Dizack alla tromba, Ryan Porter al trombone, Kamasi Washington al sax), Graves si mette mostra innanzitutto per uno stile barocco, esagerato, percussivo e frastornante che porta all’eccesso la lezione di McCoy Tyner, Chick Corea, Don Pullen e Keith Jarrett. (Continua a leggere)
 Il 2017 è appena nato ed esce, pubblicato dalla JandoMusic/ViaVenetoJazz, “A beautiful Story”, ultima fatica di Rosario Bonaccorso che, con il suo quartetto (D.Rubino, E.Zanisi e A. Paternesi), ci offre 12 sue inedite composizioni. Atmosfere delicate, sonorità dolci, sono il leit motiv di quest’opera che presenta, da subito, peculiarità e scelte stilistiche molto precise. I temi sono molto semplici, a volte leggeri e sovente malinconici, hanno il ruolo di colorare timbricamente momenti in cui il quartetto è pensato come un’orchestra novecentesca. Ricorrono, in tutto il CD, espedienti motivici poco sviluppati, ma funzionali alla resa sonora collettiva. Quest’attitudine condiziona anche gli assoli che sviluppano poco l’aspetto ritmico/melodico per rimanere ancorati alla visione d’insieme. C’è un netto rifiuto del virtuosismo in favore di un’essenzialità, sia in fase compositiva che nella prassi. (Continua a leggere)
Il 2017 è appena nato ed esce, pubblicato dalla JandoMusic/ViaVenetoJazz, “A beautiful Story”, ultima fatica di Rosario Bonaccorso che, con il suo quartetto (D.Rubino, E.Zanisi e A. Paternesi), ci offre 12 sue inedite composizioni. Atmosfere delicate, sonorità dolci, sono il leit motiv di quest’opera che presenta, da subito, peculiarità e scelte stilistiche molto precise. I temi sono molto semplici, a volte leggeri e sovente malinconici, hanno il ruolo di colorare timbricamente momenti in cui il quartetto è pensato come un’orchestra novecentesca. Ricorrono, in tutto il CD, espedienti motivici poco sviluppati, ma funzionali alla resa sonora collettiva. Quest’attitudine condiziona anche gli assoli che sviluppano poco l’aspetto ritmico/melodico per rimanere ancorati alla visione d’insieme. C’è un netto rifiuto del virtuosismo in favore di un’essenzialità, sia in fase compositiva che nella prassi. (Continua a leggere)
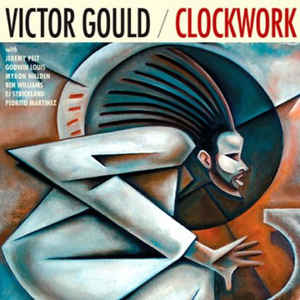 Esordio in grande stile per Victor Gould, giovane pianista con un curriculum da accompagnatore già di tutto rispetto. Alla guida di una formazione variabile che gira attorno ad una sezione ritmica deluxe, completata da Ben Williams (basso) e EJ Strickland (batteria), Gould si mette alla prova come compositore, arrangiatore e ovviamente improvvisatore. ‘Clockwork’ significa ingranaggio, ed è un termine appropriato per descrivere un gruppo in cui ogni musicista trova la perfetta collocazione nel sound d’insieme, ed un album attentamente studiato nel suo percorso narrativo e sonoro, al punto che a tratti sembra quasi di ascoltare un’unica suite.Una frontline mozzafiato (Jeremy Pelt, Myron Walden, Godwin Louis), l’aggiunta del percussionista Pedrito Martinez, di un flauto (Anne Drummond) e di un quartetto d’archi caratterizzano in modo diverso le complesse composizioni dell’album. (Continua a leggere)
Esordio in grande stile per Victor Gould, giovane pianista con un curriculum da accompagnatore già di tutto rispetto. Alla guida di una formazione variabile che gira attorno ad una sezione ritmica deluxe, completata da Ben Williams (basso) e EJ Strickland (batteria), Gould si mette alla prova come compositore, arrangiatore e ovviamente improvvisatore. ‘Clockwork’ significa ingranaggio, ed è un termine appropriato per descrivere un gruppo in cui ogni musicista trova la perfetta collocazione nel sound d’insieme, ed un album attentamente studiato nel suo percorso narrativo e sonoro, al punto che a tratti sembra quasi di ascoltare un’unica suite.Una frontline mozzafiato (Jeremy Pelt, Myron Walden, Godwin Louis), l’aggiunta del percussionista Pedrito Martinez, di un flauto (Anne Drummond) e di un quartetto d’archi caratterizzano in modo diverso le complesse composizioni dell’album. (Continua a leggere)
 Stando a quanto affermato da Nels Cline nell’intervista comparsa su Musica Jazz del settembre dello scorso anno, il progetto che stiamo per commentare era allo studio del chitarrista californiano di Los Angeles già da molto tempo, nientemeno che da un quarto di secolo. Il che già di per sé dà l’idea di quanto lavoro di approfondimento deve esserci stato dietro la sua stesura definitiva, sebbene ciò non basti a definirne l’implicita riuscita, senza cioè tener conto della sua realizzazione finale. Sta di fatto che Cline ha per davvero realizzato un’opera pregevole sotto vari punti di vista. Si tratta di un lavoro importante, tra i migliori che mi sia capitato di ascoltare di recente, considerata anche la produzione media odierna tracciata su CD intorno al jazz e alla musica improvvisata, spesso non così curata. (Continua a leggere)
Stando a quanto affermato da Nels Cline nell’intervista comparsa su Musica Jazz del settembre dello scorso anno, il progetto che stiamo per commentare era allo studio del chitarrista californiano di Los Angeles già da molto tempo, nientemeno che da un quarto di secolo. Il che già di per sé dà l’idea di quanto lavoro di approfondimento deve esserci stato dietro la sua stesura definitiva, sebbene ciò non basti a definirne l’implicita riuscita, senza cioè tener conto della sua realizzazione finale. Sta di fatto che Cline ha per davvero realizzato un’opera pregevole sotto vari punti di vista. Si tratta di un lavoro importante, tra i migliori che mi sia capitato di ascoltare di recente, considerata anche la produzione media odierna tracciata su CD intorno al jazz e alla musica improvvisata, spesso non così curata. (Continua a leggere)

Ci sono radici musicali che sanno “parlare” americano come poche altre e che probabilmente solo i musicisti americani sanno affrontare con adeguata idiomaticità e consapevolezza culturale. Ciò in barba a certe diffuse tesi critiche odierne che fanno della supposta universalità del linguaggio musicale improvvisato una delle loro basi. Ossia, si lascerebbe intendere che qualunque musicista sparso per il mondo possa approcciare certo peculiare materiale musicale con la medesima abilità e proprietà linguistica di chi può frequentarlo alla fonte, per identità culturale e condivisione geografica. Eppure si potrebbe invitare chiunque all’ascolto di un gospel o un blues, solo ad esempio, per cogliere le notevoli differenze tra quelli interpretati da un europeo piuttosto che da un afro-americano. (Continua a leggere)
 Qualche anno fa ‘Injuries’, esordio degli svedesi Angles 9, aveva attirato l’attenzione di diversi tra gli addetti ai lavori che si erano sprecati in elogi e in paragoni altisonanti (tra gli altri: Duke Ellington, Charles Mingus e Carla Bley) per via di una originale declinazione in chiave moderna e post-free della musica per big band. Su queste pagine avevamo corretto il tiro: non si trattava di un miracolo di orchestrazione per ensemble allargato di musica jazz contemporanea, bensì di un amatoriale quanto fallimentare tentativo di estendere le forme della scuola avant-jazz europea a un combo di nove elementi (due sassofoni, una cornetta, una tromba, un trombone, un pianoforte, un basso, una batteria e un vibrafono).
Qualche anno fa ‘Injuries’, esordio degli svedesi Angles 9, aveva attirato l’attenzione di diversi tra gli addetti ai lavori che si erano sprecati in elogi e in paragoni altisonanti (tra gli altri: Duke Ellington, Charles Mingus e Carla Bley) per via di una originale declinazione in chiave moderna e post-free della musica per big band. Su queste pagine avevamo corretto il tiro: non si trattava di un miracolo di orchestrazione per ensemble allargato di musica jazz contemporanea, bensì di un amatoriale quanto fallimentare tentativo di estendere le forme della scuola avant-jazz europea a un combo di nove elementi (due sassofoni, una cornetta, una tromba, un trombone, un pianoforte, un basso, una batteria e un vibrafono).
Quest’anno è la volta di ‘Disappeared Behind the Sun’, pubblicato il 17 gennaio ancora una volta dalla Clean Feed (il cui catalogo troppo spesso vanta discutibili esperimenti eseguiti con pochissima competenza e creatività), e ancora una volta i limiti della musica degli Angles 9 (la cui line up è rimasta invariata dai tempi di ‘Injuries’) si rivelano invalicabili. L’idea di fondo è molto semplice: mentre pianoforte, basso e batteria procedono su un sostenuto passo jazz-funk, abbellito dagli arrangiamenti del vibrafono, i cinque fiati ora tessono le idee melodiche portanti dei brani, ora si cimentano in lunghe sezioni solistiche corali. (Continua a leggere)
 Fra i più interessanti pianisti contemporanei, Luis Perdomo si è distinto innanzitutto per il suo lavoro al fianco di Miguel Zenon (e altri). Meno per una carriera solista di tutto rilievo, caratterizzata da una visione musicale in cui l’aspetto latino assume più i connotati di passione ed intensità espressiva, prima ancora che di intrecci ritmici e melodie particolari. Aspetti che non mancano, sia chiaro, ma in maniera quasi subliminale. ‘Spirits And Warriors’, quarta uscita per Criss Cross, vede il venezuelano alla guida di un quintetto eccezionale in cui svettano la potenza ritmica e l’inventiva del veterano batterista Billy Hart e una frontline senza confini: la liquida tromba di Alex Sipiagin e il poderoso sax di Mark Shim sono un vero e proprio torrente di soluzioni inventive e originali, senza mai perdere d’occhio l’orecchiabilità di fondo e un ideale rispetto fra le proporzioni (altre caratteristiche tipiche della produzione di Perdomo). (Continua a leggere)
Fra i più interessanti pianisti contemporanei, Luis Perdomo si è distinto innanzitutto per il suo lavoro al fianco di Miguel Zenon (e altri). Meno per una carriera solista di tutto rilievo, caratterizzata da una visione musicale in cui l’aspetto latino assume più i connotati di passione ed intensità espressiva, prima ancora che di intrecci ritmici e melodie particolari. Aspetti che non mancano, sia chiaro, ma in maniera quasi subliminale. ‘Spirits And Warriors’, quarta uscita per Criss Cross, vede il venezuelano alla guida di un quintetto eccezionale in cui svettano la potenza ritmica e l’inventiva del veterano batterista Billy Hart e una frontline senza confini: la liquida tromba di Alex Sipiagin e il poderoso sax di Mark Shim sono un vero e proprio torrente di soluzioni inventive e originali, senza mai perdere d’occhio l’orecchiabilità di fondo e un ideale rispetto fra le proporzioni (altre caratteristiche tipiche della produzione di Perdomo). (Continua a leggere)
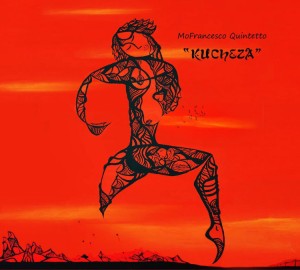 ‘Kucheza’ di MoFrancesco Quintetto è un disco ben fatto e pieno di fantasia, pubblicato nel 2016 dalla portoghese Sintoma Records. Musica che naviga seguendo la corrente sempre viva del jazz “etnico”, ormai una sorta di mainstream euromediterraneo. Nulla di nuovo, direte voi, ma in fondo chi lo impone questo imperativo del “famolo strano” ad ogni costo? ‘Kucheza’ è certamente un lavoro apprezzabile e mai noioso, belli i temi sempre diversi eppure coerenti dal punto di vista compositivo (nonostante i brani non portino tutti la stessa firma), interessanti i ritmi e le scelte timbriche, forse qualche ingenuità strutturale sparsa qua e la. Tutto è abbastanza curato senza mai risultare artificiale, anzi l’atmosfera è di grande ispirazione. (Continua a leggere)
‘Kucheza’ di MoFrancesco Quintetto è un disco ben fatto e pieno di fantasia, pubblicato nel 2016 dalla portoghese Sintoma Records. Musica che naviga seguendo la corrente sempre viva del jazz “etnico”, ormai una sorta di mainstream euromediterraneo. Nulla di nuovo, direte voi, ma in fondo chi lo impone questo imperativo del “famolo strano” ad ogni costo? ‘Kucheza’ è certamente un lavoro apprezzabile e mai noioso, belli i temi sempre diversi eppure coerenti dal punto di vista compositivo (nonostante i brani non portino tutti la stessa firma), interessanti i ritmi e le scelte timbriche, forse qualche ingenuità strutturale sparsa qua e la. Tutto è abbastanza curato senza mai risultare artificiale, anzi l’atmosfera è di grande ispirazione. (Continua a leggere)
 Uscita quasi in contemporanea di questi due dischi. Il primo, Duets 71977 (ICTUS 178) è rimasto nei cassetti per quasi 40 anni, rappresenta uno dei periodi più creativi dell’improvvisazione europea. Come riporta anche John Zorn dalle note di copertina, quegli anni furono eccitanti per la possibilità di incontro tra musicisti di qua e di là dell’oceano. Inglesi, tedeschi, olandesi, italiani ma anche americani, giapponesi e canadesi, avevano grandi possibilità di interscambio non solo musicale ma anche culturale, cose che naturalmente venivano assorbite dalla musica. (Continua a leggere)
Uscita quasi in contemporanea di questi due dischi. Il primo, Duets 71977 (ICTUS 178) è rimasto nei cassetti per quasi 40 anni, rappresenta uno dei periodi più creativi dell’improvvisazione europea. Come riporta anche John Zorn dalle note di copertina, quegli anni furono eccitanti per la possibilità di incontro tra musicisti di qua e di là dell’oceano. Inglesi, tedeschi, olandesi, italiani ma anche americani, giapponesi e canadesi, avevano grandi possibilità di interscambio non solo musicale ma anche culturale, cose che naturalmente venivano assorbite dalla musica. (Continua a leggere)
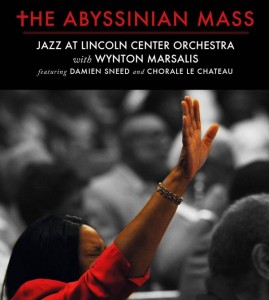 Ci sono luoghi comuni nella critica jazz nostrana che paiono servire più a farsi accettare dal “branco” che a qualificarsi per competenze in materia. Ciò succede per diverse ragioni che qui non possiamo seriamente analizzare, ma la principale delle quali pare andare oltre il jazz ed essere legata alla diffusa abitudine nel nostro paese di conformarsi a certo sentire comune, se non ad un vero e proprio pensiero unico. Curioso atteggiamento questo da mostrare verso una musica che ha fatto storicamente dell’anticonformismo una sua ragion d’essere. La radice autentica del problema temo però che sia da ricercare in un ambiente intorno a questa musica decisamente invecchiato, divenuto troppo ristretto, autoreferenziale e fermo a schemi critici che paiono ormai abbondantemente superati e sostanzialmente fallaci, nonostante si pretenda di farli sembrare ancora “aggiornati”. (Continua a leggere)
Ci sono luoghi comuni nella critica jazz nostrana che paiono servire più a farsi accettare dal “branco” che a qualificarsi per competenze in materia. Ciò succede per diverse ragioni che qui non possiamo seriamente analizzare, ma la principale delle quali pare andare oltre il jazz ed essere legata alla diffusa abitudine nel nostro paese di conformarsi a certo sentire comune, se non ad un vero e proprio pensiero unico. Curioso atteggiamento questo da mostrare verso una musica che ha fatto storicamente dell’anticonformismo una sua ragion d’essere. La radice autentica del problema temo però che sia da ricercare in un ambiente intorno a questa musica decisamente invecchiato, divenuto troppo ristretto, autoreferenziale e fermo a schemi critici che paiono ormai abbondantemente superati e sostanzialmente fallaci, nonostante si pretenda di farli sembrare ancora “aggiornati”. (Continua a leggere)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- Wayne Shorter: il compositore
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Chiodi nella bara
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
- Riceviamo & pubblichiamo: Rich Doub...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz
