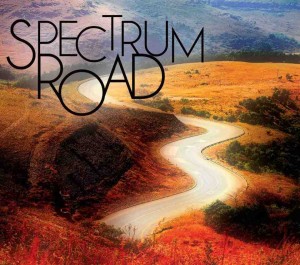Fusion's Articles
Fusion, jazz-funk e jazz-rock, lo sterco del Demonio
Questo breve testo nasce da una serie di incomplete annotazioni sull’accoglienza riservata ad alcune strutture linguistiche nate in seno al jazz ma annoverate e criticate come spurie. Trattasi, perciò, di nient’altro che spunti e frammenti che verranno approfonditi in altro scritto.
Mi sono di recente trovato a rileggere un lontano scritto di Franco Pecori pubblicato da Jazz From Italy nella sua pagina Facebook: Nessun’arte, e nemmeno la musica, è mai pura; questo è un equivoco idealistico. Altrimenti, non si capirebbe la nascita e la relativa fioritura della dodecafonia proprio nella Vienna degli anni tra le due guerre; e neanche si capirebbe l’esplosione del free negli anni Sessanta, in un tipo di società impostata sull’imperialismo economico, seriamente minata dall’alienazione dei consumi e lacerata da profondi contrasti razziali. Mi ha provocato non poche perplessità l’idea di “inevitabilità” (un sotto-prodotto del progresso in senso marxiano), come se, in fondo, esista un Fato (o una giustizia storica o una qualsiasi logica ferrea e stringente) che cerchi di controbilanciare con le sue azioni altre azioni ancora, prodotte da se stesso o da un altro Fato avverso, o da altra logica umana o cosmica. (Continua a leggere)
(Continua a leggere)
Quando Al Jarreau sale sul palco zoppicante, aiutato non solo da un bastone ma anche da un paio di assistenti, il primo pensiero è che il tempo non sia stato troppo clemente con lui. Vederlo muoversi con fatica, non sappiamo se come strascico dei problemi di salute di qualche anno fa o per qualche infortunio dell’ultimo minuto, è uno spettacolo ai limiti dello struggente. Per un attimo il pubblico (piuttosto numeroso invero) si chiede se valga la pena insistere così, se a 75 anni e con un fisico piuttosto provato non sia meglio restare a casa e godersi attività meno spossanti di un tour in giro per il mondo (sarà in Europa per tutto Luglio, poi date a intermittenza negli Stati Uniti fissate fino a Novembre. Persino una capatina in Brasile al Rock In Rio!). Il buon Al, coppola alla Brian Johnson in testa e cravatta a fantasia viola al collo, ci mette poco però a zittirci (Continua a leggere)
Someday my PRINCE will come
Tutto sommato è facile parlare di Prince: tiri fuori uno dei tanti dischi belli e via in quarta con elogi e superlativi. Una produzione multiforme e composita la sua, che tra funk, rock, soul e r&b di tanto in tanto porta a galla anche qualche legame con la musica che trattiamo su queste pagine: inevitabile, verrebbe da pensare, visto che suo padre, John L. Nelson, era un pianista jazz e, da buon classe 1915, alla guida del Prince Rogers Trio si è goduto tutta l’epoca d’oro del genere, pur senza mai riuscire a ritagliarsi un posto davvero importante, nemmeno in seconda fila.
La prima volta che il principe di Minneapolis incrocia seriamente la strada del jazz, le circostanze sono abbastanza clamorose e lo vedono in coppia nientemeno che con Miles Davis. Il pezzo si chiama ‘Can I Play With U’: dovrebbe finire su quello che diventerà il non esattamente eccelso ‘Tutu’, ma viene escluso dalla scaletta finale. È un ottimo, vigoroso electro-funk arricchito con naturalezza dalla tromba di Miles, e non avrebbe sfigurato sul di poco successivo ‘Sign O’ The Times’: a ragione, Prince lo ritiene non in linea con il blocco di pezzi preparati da Marcus Miller per il disco di Davis e chiede la sua esclusione. Vedrà la luce solo su un popolare bootleg intitolato ‘Crucial’, ma avrebbe meritato sorte migliore. (Continua a leggere)
SPECTRUM ROAD – Spectrum Road (2012, Palmetto)
Per “protesta” non userò più di 200 parole.
Mi sta benissimo che qualcuno cerchi di rendere omaggio a Tony Williams, uno dei primi a voler sfumare la linea di confine tra due generi allora ritenuti antipodici come jazz e rock, ma che negli anni è stato talvolta ingenerosamente (e superficialmente) liquidato come Billy Cobham del discount.
Ancora meglio se negli Spectrum Road troviamo uno che con Williams ha scritto pagine importanti, Jack Bruce, e gente degna di stima e devozione come Vernon Reid e Cindy Blackman (il cui ‘Telepathy’ resta per me una delle migliori espressioni post-bop degli anni ‘90), che – con il tastierista John Medeski a chiudere il quadrilatero – si cimentano con un repertorio che attinge dai Tony Williams Lifetime.
Le nuove versioni suonano “gonfiate”, c’è “più tutto”: più volume, più note (autentiche cascate: Vernon Reid, brutto dirlo, a tratti sembra voler fare a gara a chi la fa più lontano con gli originali di McLaughlin), più elettricità. ‘Spectrum Road’, in sostanza, sembra un disco fusion virato prog metal, roba buona per fare colpo su ascoltatori facilmente impressionabili e affascinati dal numero ad effetto.
Qualcosa di piacevole si trova pure, il punto è che spesso less is more. Loro però fanno gli gnorri. (Nico Toscani)
Che le influenze musicali di Robert Trujillo, da circa dieci anni bassista dei Metallica, andassero oltre i classici del rock era già intuibile dallo stile virtuoso e funky adottato in progetti precedenti come gli immensi Infectious Grooves. Ciò non toglie che sia curioso e singolare apprendere da USA Today che il bassista americano è il finanziatore di un imminente documentario sulla vita di Jaco Pastorious. L’articolo originale (scritto da Petras Makulas) è visibile qui, ma come al solito ve ne offriamo anche una pronta traduzione di seguito:
SAN RAFAEL, Calif. – Se vi suona strano che una star del metal stia finanziando un film su un virtuoso del jazz, allora ci sono un paio di cose che dovete imparare su Robert Trujillo dei Metallica e sul compianto bassista Jaco Pastorious.
“Quando ero un ragazzino - racconta Trujillo - Jaco era il mio idolo. Ascoltarlo era come sentire per la prima volta Eddie Van Halen suonare ‘Eruption’. Stai lì e pensi: ‘Che razza di strumento è?” (Continua a leggere)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Chiodi nella bara
- Wayne Shorter: il compositore
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz