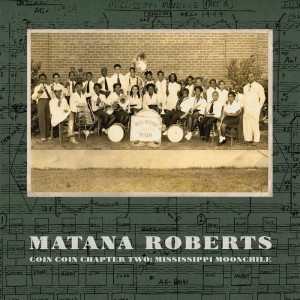New York's Articles
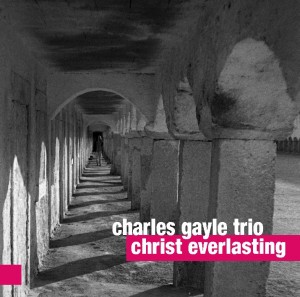
Quando esce un nuovo disco di Charles Gayle il rischio è di finire a ripetere sempre le stesse cose, dagli anni vissuti suonando per strada a New York alle esibizioni truccato da Streets il clown, magari ignorando che negli ultimi anni il musicista (e probabilmente anche l’uomo) è passato attraverso numerosi cambiamenti. È importante sottolinearlo, perché lavori come ‘Streets’ (2012) o il nuovo ‘Christ Everlasting’ sono frutto proprio delle metamorfosi di cui sopra. Figli di un Gayle che si stacca dai parossismi che hanno segnato i suoi dischi degli anni 90 (su tutti, ‘Repent’, ‘Touchin’ On Trane’ e ‘Consecration’), di un Gayle che sempre più spesso inizia ad alternare il sax tenore con il piano (suo strumento d’origine), di un Gayle che inizia ad esplorare gli standard jazzistici. (Continua a leggere)
Sul pur ottimo ‘Coin Coin Part One’ avevamo espresso qualche perplessità, soprattutto per una sintesi a tratti trascurata in favore dell’integrità dell’ambizioso concept, presentato peraltro come opera in ben dodici atti (che, lavorando di accetta, possiamo riassumere come incentrata sulla schiavitù e la condizione afroamericana nell’anteguerra, argomento che l’autrice approfondisce con tanto di ricerche nel proprio albero genealogico). Per il secondo volume l’altosassofonista di Chicago decide di cambiare le carte in tavola quasi a tutti i livelli, dimostrando ancora una volta di non amare le ripetizioni. Non si tratta di un mutamento di rotta fine a sé stesso: le frecce al proprio arco sono tante e le idee sono abbastanza fresche da giustificare la sterzata. (Continua a leggere)
Che siate fan terminali dell’uomo o semplici appassionati di jazz in generale, il museo dedicato a Louis Armstrong a New York (a Corona, frazione nel nord del quartiere Queens, per la precisione) resta una meta imperdibile, seppur non dietro l’angolo, per il miglior “turismo musicale”.
Allestito nella casa di mattoni in cui per 28 anni, dal 1943 al 1971, il trombettista ha vissuto con la moglie Lucille, il museo esibisce una gran quantità di memorabilia e al contempo lascia intatti gli interni, evitando di modificare l’arredamento e la configurazione delle stanze (la cucina color turchese che vi proponiamo qui sopra resta forse l’immagine più famosa). (Continua a leggere)
Introdotta durante gli anni del proibizionismo, la cabaret card era un espediente delle autorità newyorkesi per controllare chiunque (musicisti inclusi) avesse intenzione di lavorare nei night club della Grande Mela. In pratica, i titolari venivano schedati in cambio della suddetta licenza, la quale poteva essere revocata a discrezione del dipartimento di polizia locale. Qualcuno rifiutò di piegarsi all’imposizione (Frank Sinatra ad esempio pare abbia evitato di esibirsi a New York fino all’abolizione della card nel 1967), tanti altri la accettarono, e alcuni, come Charlie Parker o J. J. Johnson, dovettero anche combattere dopo essersela vista revocare. (Continua a leggere)
 Gli americani il nuovo album di Charles Gayle (musicista che abbiamo già approfondito in precedenza) lo definirebbero return to form. La “forma”, nel dettaglio, sarebbe grossomodo quella che lo ha reso famoso. Il sassofonista newyorkese torna dunque a muoversi in territori free jazz dopo una fase straight (in cui è tornato anche al piano, suo strumento d’origine) un po’ a corrente alternata, che col senno di poi sembra più un modo per dire “guardate, sono bravo anche a fare la roba più calma” che figlia di una precisa urgenza espressiva, ma tant’è. Seppure non manchino momenti durissimi (si veda la corrosiva ‘Tribulations’), rispetto al passato ‘Streets’ (come le strade della grande mela in cui Gayle ha a lungo vissuto, ma anche come Streets The Clown, il mimo che talvolta egli stesso porta in scena) suona meno caustico, di certo non “radicale” quanto un ‘Repent’ o come i pezzi più lunghi di ‘Touchin’ On Trane’; anche la durata dei singoli brani resta più o meno contenuta, assestandosi attorno a una media di 7/8 minuti. (Continua a leggere)
Gli americani il nuovo album di Charles Gayle (musicista che abbiamo già approfondito in precedenza) lo definirebbero return to form. La “forma”, nel dettaglio, sarebbe grossomodo quella che lo ha reso famoso. Il sassofonista newyorkese torna dunque a muoversi in territori free jazz dopo una fase straight (in cui è tornato anche al piano, suo strumento d’origine) un po’ a corrente alternata, che col senno di poi sembra più un modo per dire “guardate, sono bravo anche a fare la roba più calma” che figlia di una precisa urgenza espressiva, ma tant’è. Seppure non manchino momenti durissimi (si veda la corrosiva ‘Tribulations’), rispetto al passato ‘Streets’ (come le strade della grande mela in cui Gayle ha a lungo vissuto, ma anche come Streets The Clown, il mimo che talvolta egli stesso porta in scena) suona meno caustico, di certo non “radicale” quanto un ‘Repent’ o come i pezzi più lunghi di ‘Touchin’ On Trane’; anche la durata dei singoli brani resta più o meno contenuta, assestandosi attorno a una media di 7/8 minuti. (Continua a leggere)
DAVID S. WARE in his own words

‘Planetary Unknown’ è stata una delle note più liete dell’anno appena trascorso. Non solo dal punto di vista musicale, per l’ennesima buona prova di musicisti che ormai da tempo sono garanzia di qualità, quanto anche per la gioia di rivedere con un sassofono tra le labbra il leader di quella formazione, David S. Ware, reduce da un delicato trapianto di rene. Che della sua musica ne avremmo riparlato a fondo l’avevamo promesso al tempo del suo documentario ‘A World Of Music’, e dunque quale migliore occasione di un’approfondita intervista? Per chi non fosse particolarmente familiare con la sua proposta, possiamo innanzitutto dire che Ware va inquadrato in quel gruppo di musicisti che hanno animato la scena free newyorkese tra la fine degli anni ’60 e il decennio successivo, differenziandosi però da molti colleghi per una ricerca sonora che non perde mai troppo di vista l’amore per la melodia. Collaborazioni importanti con Cecil Taylor e Andrew Cyrille hanno contribuito a forgiarne quello stile personale e riconoscibilissimo sbocciato poi definitivamente nei lavori pubblicati a suo nome. Inizialmente in trio, è col quartetto che Ware trova infine la quadratura del cerchio: a fargli (più o meno regolarmente) compagnia pezzi da novanta come il fido William Parker al basso e il pianista Matthew Shipp, più uno stuolo di batteristi tra i quali Susie Ibarra e Muhammad Ali, per dirne solo due. È forse ‘Flight Of I’ del 1992 il più rappresentativo di una discografia ricca di titoli di qualità, la quale, come egli stesso ribadisce durante l’intervista, resta prova concreta di come free jazz e tradizione siano concetti tutt’altro che antipodici.
Cos’è per te, il jazz?
Un modo per esprimere sé stessi attraverso uno strumento musicale in maniera armoniosa, ma anche molto creativa. La creatività ne è la parte più grande: per quanto possibile, uno dovrebbe cercare di non ripetersi. È qualcosa di universale, il jazz. Può elevare il tuo spirito.
È per questo che la spiritualità è un tema così ricorrente nella tua musica come in quella di molti altri jazzisti, da Coltrane a Sanders, passando per Ayler e Sun Ra?
La spiritualità si manifesta attraverso ognuno, indistintamente, magari non sempre allo stesso modo. I musicisti non fanno eccezione, chiaro. E poi dà un senso ad ogni cosa: senza di essa, nulla ha significato. È la base di tutto. (Continua a leggere)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Chiodi nella bara
- Wayne Shorter: il compositore
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz