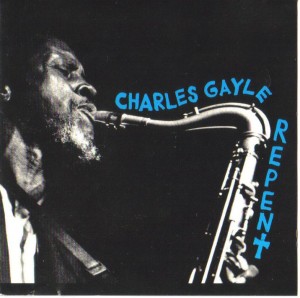Charles Gayle's Articles
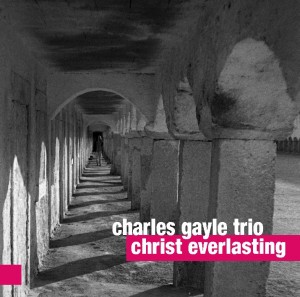
Quando esce un nuovo disco di Charles Gayle il rischio è di finire a ripetere sempre le stesse cose, dagli anni vissuti suonando per strada a New York alle esibizioni truccato da Streets il clown, magari ignorando che negli ultimi anni il musicista (e probabilmente anche l’uomo) è passato attraverso numerosi cambiamenti. È importante sottolinearlo, perché lavori come ‘Streets’ (2012) o il nuovo ‘Christ Everlasting’ sono frutto proprio delle metamorfosi di cui sopra. Figli di un Gayle che si stacca dai parossismi che hanno segnato i suoi dischi degli anni 90 (su tutti, ‘Repent’, ‘Touchin’ On Trane’ e ‘Consecration’), di un Gayle che sempre più spesso inizia ad alternare il sax tenore con il piano (suo strumento d’origine), di un Gayle che inizia ad esplorare gli standard jazzistici. (Continua a leggere)
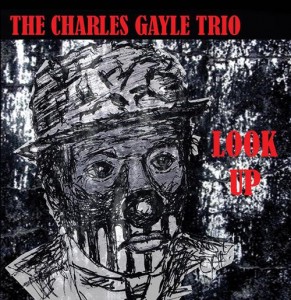 Innanzitutto un’esortazione che mi pare doverosa, altrimenti la mia coscienza non mi lascerebbe in pace: attenzione. Fate MOLTA attenzione. Quando vi approcciate all’ascolto di questo disco, assicuratevi di non tenere il volume troppo alto pigiando play: si apre a tradimento con uno strepito di sax che pare una via di mezzo tra unghie che strisciano su una lavagna e la sgommata apocalittica di una corsa clandestina. Io non lo sapevo, e premere quel fatidico play mi ha estorto blasfemie. In verità qualche blasfemia me l’ha strappata anche il resto dell’ascolto, ma procediamo con ordine.
Innanzitutto un’esortazione che mi pare doverosa, altrimenti la mia coscienza non mi lascerebbe in pace: attenzione. Fate MOLTA attenzione. Quando vi approcciate all’ascolto di questo disco, assicuratevi di non tenere il volume troppo alto pigiando play: si apre a tradimento con uno strepito di sax che pare una via di mezzo tra unghie che strisciano su una lavagna e la sgommata apocalittica di una corsa clandestina. Io non lo sapevo, e premere quel fatidico play mi ha estorto blasfemie. In verità qualche blasfemia me l’ha strappata anche il resto dell’ascolto, ma procediamo con ordine.
La storia vuole che Gayle si vide sfumare, nei lontani anni ’60, la possibilità di incidere un disco per la ESP nel momento in cui l’etichetta era la principale ambasciatrice del free jazz nel suo periodo di massimo splendore. Oggi, quasi 50 anni dopo, un disco del sassofonista newyorkese su quella etichetta esce per davvero, ma chi si aspettava una buona replica all’ottimo ‘Streets’ di qualche mese fa è destinato a rimanere deluso. ‘Look Up’ contiene materiale risalente al 1994, con ogni probabilità il miglior periodo della carriera di Gayle, il problema vero è la registrazione completamente amatoriale che rende l’ascolto arduo anche per le orecchie più audaci. (Continua a leggere)
 Gli americani il nuovo album di Charles Gayle (musicista che abbiamo già approfondito in precedenza) lo definirebbero return to form. La “forma”, nel dettaglio, sarebbe grossomodo quella che lo ha reso famoso. Il sassofonista newyorkese torna dunque a muoversi in territori free jazz dopo una fase straight (in cui è tornato anche al piano, suo strumento d’origine) un po’ a corrente alternata, che col senno di poi sembra più un modo per dire “guardate, sono bravo anche a fare la roba più calma” che figlia di una precisa urgenza espressiva, ma tant’è. Seppure non manchino momenti durissimi (si veda la corrosiva ‘Tribulations’), rispetto al passato ‘Streets’ (come le strade della grande mela in cui Gayle ha a lungo vissuto, ma anche come Streets The Clown, il mimo che talvolta egli stesso porta in scena) suona meno caustico, di certo non “radicale” quanto un ‘Repent’ o come i pezzi più lunghi di ‘Touchin’ On Trane’; anche la durata dei singoli brani resta più o meno contenuta, assestandosi attorno a una media di 7/8 minuti. (Continua a leggere)
Gli americani il nuovo album di Charles Gayle (musicista che abbiamo già approfondito in precedenza) lo definirebbero return to form. La “forma”, nel dettaglio, sarebbe grossomodo quella che lo ha reso famoso. Il sassofonista newyorkese torna dunque a muoversi in territori free jazz dopo una fase straight (in cui è tornato anche al piano, suo strumento d’origine) un po’ a corrente alternata, che col senno di poi sembra più un modo per dire “guardate, sono bravo anche a fare la roba più calma” che figlia di una precisa urgenza espressiva, ma tant’è. Seppure non manchino momenti durissimi (si veda la corrosiva ‘Tribulations’), rispetto al passato ‘Streets’ (come le strade della grande mela in cui Gayle ha a lungo vissuto, ma anche come Streets The Clown, il mimo che talvolta egli stesso porta in scena) suona meno caustico, di certo non “radicale” quanto un ‘Repent’ o come i pezzi più lunghi di ‘Touchin’ On Trane’; anche la durata dei singoli brani resta più o meno contenuta, assestandosi attorno a una media di 7/8 minuti. (Continua a leggere)
 Se sulle nostre pagine dovesse campeggiare un Rollins sarebbe quasi scontato pensare allo storico Sonny, decisamente più in tema rispetto all’incazzoso Henry, la cui Rollins Band non ha comunque mai nascosto il proprio amore per jazz e dintorni (ingaggiando pure l’ex Defunkt Melvin Gibbs al basso). Presto verrà anche il momento di parlare del “Saxophone Colossus”, per ora accontentatevi del suo omonimo più muscoloso e tatuato: non tanto per ribadire l’importanza dei suoi gruppi (Black Flag e, appunto, Rollins Band) per il rock degli ultimi 30 anni (discorso sacrosanto, ma che ci porterebbe fuori tema), quanto per approfondire il suo legame con la musica di cui leggete (si spera, eh) da queste parti. Un legame traducibile fondamentalmente in un nome e un cognome: Charles Gayle. Quando ho scritto il precedente articolo su quest’ultimo tra l’altro non avevo idea che ce ne sarebbe stata una seconda puntata, ma una volta deciso di voler approfondire questa joint venture la scelta è stata naturale conseguenza. (Continua a leggere)
Se sulle nostre pagine dovesse campeggiare un Rollins sarebbe quasi scontato pensare allo storico Sonny, decisamente più in tema rispetto all’incazzoso Henry, la cui Rollins Band non ha comunque mai nascosto il proprio amore per jazz e dintorni (ingaggiando pure l’ex Defunkt Melvin Gibbs al basso). Presto verrà anche il momento di parlare del “Saxophone Colossus”, per ora accontentatevi del suo omonimo più muscoloso e tatuato: non tanto per ribadire l’importanza dei suoi gruppi (Black Flag e, appunto, Rollins Band) per il rock degli ultimi 30 anni (discorso sacrosanto, ma che ci porterebbe fuori tema), quanto per approfondire il suo legame con la musica di cui leggete (si spera, eh) da queste parti. Un legame traducibile fondamentalmente in un nome e un cognome: Charles Gayle. Quando ho scritto il precedente articolo su quest’ultimo tra l’altro non avevo idea che ce ne sarebbe stata una seconda puntata, ma una volta deciso di voler approfondire questa joint venture la scelta è stata naturale conseguenza. (Continua a leggere)
Per i miei padiglioni, distratti da terrorismi sonori ben più assordanti, il jazz era sempre stata musica innocua, annacquata; roba per cui poteva esaltarsi Cliff Robinson, tutt’al più. A “indottrinarmi” alla materia ci provò un collega di mio padre, una specie di ex fricchettone in fissa col sud-est asiatico che collezionava bustine di zucchero da bar. Aveva una libreria musicale (vinili e cassette soprattutto) eclettica e sterminata, in cui era un piacere scavare e scoprire autentiche chicche nelle quali altrimenti chissà se e quando mi sarei mai imbattuto. D’altronde a quei tempi internet era ancora un termine semi-fantascientifico su cui si ricamavano voli pindarici dopo aver letto che in America gli Aerosmith avevano caricato un brano inedito in rete. La mia rete, o almeno parte di essa, era invece quella collezione di dischi, difatti abbastanza di frequente mi ritrovavo a scambiare materiale col succitato ex fricchettone. Una delle sue passioni era il jazz, e ben ricordo quando, appurato il mio apprezzamento per ‘Rockit’, si offrì di prestarmi un CD di Herbie Hancock (neanche ricordo più quale), che però cassai con fretta e sdegno: non c’entrava nulla con quel pezzo e il suo surreale videoclip. (Continua a leggere)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Wayne Shorter: il compositore
- Chiodi nella bara
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz