KEITH JARRETT- Creation (2015, ECM)
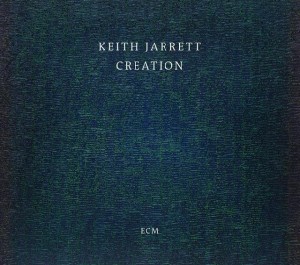 Keith Jarrett scrive un altro capitolo della sua ormai lunga storia dedicata al piano solo improvvisato, inaugurata sin dai primi anni ’70, con questo Creation da poco pubblicato da ECM. Molto tempo è passato da allora e naturalmente la sua musica è cambiata, esattamente come è cambiato il mondo attorno all’artista, oggi settantenne, seguendone perciò l’evoluzione temporale. Il suo approccio allo strumento evidentemente non può (e non vuole) essere più lo stesso di quei primi anni. In qualche modo la musica, passo dopo passo, rispecchia e fotografa lo stato del musicista stesso, tanto più in questa formula dell’esibizione in solo, così coinvolgente ed individuale, che più di altre ne mette a nudo lo stato mentale, spirituale e, non ultimo per importanza, quello fisico. Jarrett inevitabilmente non manifesta più la forza, la freschezza e il virtuosismo digitale di un tempo, ma ha guadagnato progressivamente in profondità e in capacità di sintesi, spostando il suo virtuosismo più sul versante compositivo della musica che improvvisativo. Un’altra particolarità del disco è che stavolta è costruito con criterio del tutto diverso dalle precedenti occasioni. Infatti, Jarrett non ha fatto pubblicare come suo costume un intero concerto, ma si è esercitato in una cernita di brani estratti da diverse esibizioni effettuate nel tour dello scorso anno in diverse parti del mondo, tra cui sono presenti anche ben tre improvvisazioni registrate all’Auditorium del Parco della Musica in Roma. Come egli stesso ha voluto precisare nella bella intervista pubblicata nel numero di giugno di Musica Jazz, Jarrett si è impegnato a selezionare i brani lavorando su un cospicuo materiale messo a disposizione di circa 18 ore di musica scegliendo non necessariamente quelli che più gli piacevano, ma ricercandone l’integrità e un filo conduttore. Pertanto, i nove brani complessivi, provenienti da sei concerti differenti, evidenziano continuità e una loro coerenza interna, per quanto costruita, ma d’altro canto anche una certa fastidiosa uniformità espressiva che solitamente è evitata nei concerti per naturale maggiore varietà musicale. Ne esce un risultato abbastanza diverso dalle ultime performances pubblicate e soprattutto manca stavolta pressoché totalmente il jazz e in particolare la componente afro-americana. Per quanto si sappia come questo genere di improvvisazioni non debba essere inquadrato in quell’ambito idiomatico, non si può non notare la totale mancanza di certi ostinati, di melodie simil-gospel, del blues o di qualche standard nei bis, per chiara ed evidente volontà dell’artista. Pertanto il lavoro discografico si presenta complessivamente più cupo ed introverso, avvicinandosi più a lavori del passato come Dark Intervals o a Radiance piuttosto che ai più recenti Testament o Rio. La selezione ha privilegiato improvvisazioni dal tono classicamente più austero e solenne, o dal tratto innodico, con enunciazione di melodie anche affascinanti, ma compassate e ritmicamente abbastanza piatte, che occasionalmente inglobano frammenti di materiali noti.
Keith Jarrett scrive un altro capitolo della sua ormai lunga storia dedicata al piano solo improvvisato, inaugurata sin dai primi anni ’70, con questo Creation da poco pubblicato da ECM. Molto tempo è passato da allora e naturalmente la sua musica è cambiata, esattamente come è cambiato il mondo attorno all’artista, oggi settantenne, seguendone perciò l’evoluzione temporale. Il suo approccio allo strumento evidentemente non può (e non vuole) essere più lo stesso di quei primi anni. In qualche modo la musica, passo dopo passo, rispecchia e fotografa lo stato del musicista stesso, tanto più in questa formula dell’esibizione in solo, così coinvolgente ed individuale, che più di altre ne mette a nudo lo stato mentale, spirituale e, non ultimo per importanza, quello fisico. Jarrett inevitabilmente non manifesta più la forza, la freschezza e il virtuosismo digitale di un tempo, ma ha guadagnato progressivamente in profondità e in capacità di sintesi, spostando il suo virtuosismo più sul versante compositivo della musica che improvvisativo. Un’altra particolarità del disco è che stavolta è costruito con criterio del tutto diverso dalle precedenti occasioni. Infatti, Jarrett non ha fatto pubblicare come suo costume un intero concerto, ma si è esercitato in una cernita di brani estratti da diverse esibizioni effettuate nel tour dello scorso anno in diverse parti del mondo, tra cui sono presenti anche ben tre improvvisazioni registrate all’Auditorium del Parco della Musica in Roma. Come egli stesso ha voluto precisare nella bella intervista pubblicata nel numero di giugno di Musica Jazz, Jarrett si è impegnato a selezionare i brani lavorando su un cospicuo materiale messo a disposizione di circa 18 ore di musica scegliendo non necessariamente quelli che più gli piacevano, ma ricercandone l’integrità e un filo conduttore. Pertanto, i nove brani complessivi, provenienti da sei concerti differenti, evidenziano continuità e una loro coerenza interna, per quanto costruita, ma d’altro canto anche una certa fastidiosa uniformità espressiva che solitamente è evitata nei concerti per naturale maggiore varietà musicale. Ne esce un risultato abbastanza diverso dalle ultime performances pubblicate e soprattutto manca stavolta pressoché totalmente il jazz e in particolare la componente afro-americana. Per quanto si sappia come questo genere di improvvisazioni non debba essere inquadrato in quell’ambito idiomatico, non si può non notare la totale mancanza di certi ostinati, di melodie simil-gospel, del blues o di qualche standard nei bis, per chiara ed evidente volontà dell’artista. Pertanto il lavoro discografico si presenta complessivamente più cupo ed introverso, avvicinandosi più a lavori del passato come Dark Intervals o a Radiance piuttosto che ai più recenti Testament o Rio. La selezione ha privilegiato improvvisazioni dal tono classicamente più austero e solenne, o dal tratto innodico, con enunciazione di melodie anche affascinanti, ma compassate e ritmicamente abbastanza piatte, che occasionalmente inglobano frammenti di materiali noti.
Il risultato è rigoroso, onesto e tutto sommato ancora eccellente, ma stavolta privo di momenti entusiasmanti, impegnando e trascinando l’ascoltatore ad entrare in profondità nel mood prescelto dall’autore, che potrà essere eventualmente apprezzato dopo ripetuti ascolti. Forse era proprio questo lo scopo che l’artista voleva raggiungere.
(Riccardo Facchi)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- Chiodi nella bara
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Wayne Shorter: il compositore
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz



