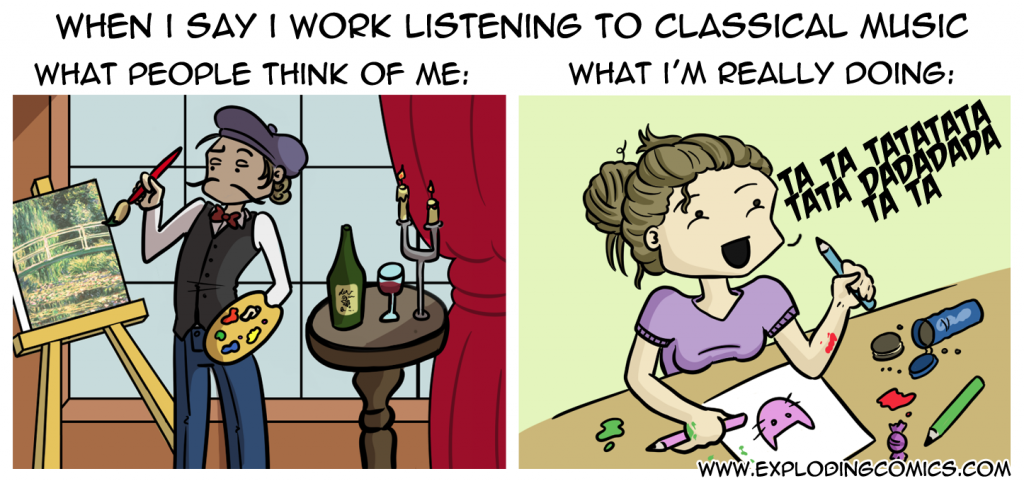Di tradizioni, accademie e rivoluzioni
Quale tipo di patrimonio culturale costituisca la tradizione musicale accademica occidentale è dato noto più o meno a tutti, anche a coloro che non la frequentano abitualmente. In Italia si accusa spesso il contesto accademico di essere centripeto se non addirittura retrivo, di essere poco incline a capire, accettare o valutare tutto ciò che gli appare esotico, eccentrico, esogeno, tutto ciò che non rientra nel Canone. Vi è sicuramente del vero. Uno dei dati più interessanti, ad esempio, è verificare non tanto la conoscenza di altre culture e linguaggi musicali, ma il gradimento che ricevono: interrogati in materia, alcuni fra i più sofisticati e sensibili esponenti accademici farebbero inarcare molte sopracciglia. Attratti dal dato artigianale del professionismo in una materia a loro sconosciuta, sicuramente indicherebbero più facilmente Diana Krall come esempio di artista capace che non Woody Shaw, Anthony Braxton o Brian Wilson. Miles Davis li attrae, ma per fattori inerenti un’aura prodotta da un coacervo di fattori, pochi dei quali strettamente musicali. Pochi di loro avvertirebbero artisti attivi in altri contesti musicali come loro “pari” o “colleghi”. Per una pletora di motivi (personali, ideologici e post-ideologici, culturali, caratteriali) l’esplorazione dell’alterità non è facilmente frequentata, da autori come interpreti.
Intellettuali come, che so, Carlo Boccadoro o Alexander Lonquich, capaci, cioè, di affrontare e leggere la diversità con acume e profondità e senza preconcetti non sono frequenti da noi anzi, rimangono mosche bianche, peraltro guardate talvolta con perplessità o addirittura con un certo sospetto. Ci si aspetterebbe, perciò, che in altre sponde si riscontrasse quella prontezza, quell’apertura mentale la cui mancanza si lamenta nell’accademia nostrana. Si andrebbe incontro a una cocente delusione. Prendiamo il caso del jazz, che molti presentano come “la” musica “classica” del Novecento, soprattutto perché non hanno gli strumenti per approfondire l’esperienza accademica: il jazz fa da “succedaneo”, passa per linguaggio da intellettuali raffinati, per quanto a corrente alternata è spesso di moda, quanto meno è perennemente “trendy” e, come la curcuma, può speziare qualsiasi piatto (di recente si è persino letto che l’influenza di Ornette Coleman è avvertibile anche nell’opera di Jovanotti). Per essere “trendy”, dunque costantemente “sul pezzo”, i divulgatori, i giornalisti, i soi disant critici musicali, i soi disant musicologi, fatte salve alcune eccezioni, avvertono forte non il bisogno di essere “updated” ma di essere “up-to-date”: non si aggiorna una conoscenza accumulata in anni di studio, si cerca – assai più comodamente – di essere sempre “au pair” e “à la page”, in una frenetica rincorsa con la contemporaneità.
Nessun musicologo o semplice melomane penserebbe, bene o male, di poter prescindere dalla conoscenza di determinati “capisaldi”, da Palestrina a Stockhausen. Nel jazz è norma, invece, il gap generazionale: la storia del jazz inizia, nel migliore dei casi, con la propria generazione. A leggere anche dei ponderosi testi della musicologia nostrana, parrebbe, ad esempio, che il mondo dell’improvvisazione odierna si riduca a una manciata di nomi, quasi tutti settantenni e quasi tutti provenienti da Chicago (la cui reale inflenza sulla musica improvvisata contemporanea, salvo eccezioni, è, in realtà, tutta da verificare). Tutto ciò che non rispecchia i canoni di certo avanguardismo fumoso o, peggio, male interpretato, viene considerato passé e indegno di essere approfondito. Tutto ciò che è legato alla tradizione africano-americana, come il mainstream (che è la corrente che punta a saldare le acquisizioni della contemporaneità con la logica e la conoscenza accumulata dalla tradizione), è reputato insignificante se non addirittura reazionario (esattamente l’opposto della realtà).
L’artigianato musicale non viene considerato (anche perché molti non hanno la cultura o la tecnica per valutarlo). Si procede con una storiografia banale, che vive di picchi, di “rivoluzioni” (che nel jazz africano-americano non esistono, non esistono “strappi” con la tradizione, esistono costantemente nuove letture e riletture di essa: il concetto di “rivoluzione” è europeo, appartiene in questo caso a una cattiva digestione di tomi post-marxiani e post-marxisti non letti), s’ignora troppo della storia degli Stati Uniti e degli africano-americani, s’ignorano la cultura americana e quella africano-americana, s’ignorano i loro contesti storici, sociali, politici. Si fa un tutt’uno, che oggi non è più praticabile, di “jazz” e “improvvisazione”. Il termine “jazz” è utilizzato come una sorta di sticker nobilitante, senza alcun approfondimento del Canone o senza alcuna sua conoscenza addirittura (l’improvvisazione ha oggi una sua esistenza varia, estremamente “glocal”, in cui il jazz può fare la nobile parte del progenitore). Decenni e decenni di storia, di cultura, di musica vengono così cancellate o affidate a un’accozzaglia di stereotipi o di sentenze senza senso (la fusion degli anni Settanta e Ottanta, ad esempio, spacciata via senza tanti riguardi come solo un fenomeno meramente commerciale: una vera improprietà, carente sotto il profilo sociologico almeno). Pochi fra i melomani che frequentano oggi la musica africano-americana e i suoi derivati (naturalmente, al di fuori del jazz, tutto ciò che è “popular”, della più diversa estrazione, dal song di Broadway al R&B al “pop song”, viene scartato indifferentemente, senza minimamente rendersi conto delle connessioni esistenti fra certi materiali all’interno della cultura africano-americana e della cultura americana, e come certi modelli abbiano influenzato un intero contesto culturale delle Americhe. Quanti sono, oggi, ad esempio, che vedono le connessioni fra Saumell, Gottschalk, Cervantes, Lecuona fino a Roldàn e Caturla?) hanno una conoscenza accettabile dei primi sessant’anni di storia del jazz (non dico della cultura musicale africano-americana). Peggio, non pochi sono coloro che, privi di adeguati strumenti di conoscenza e afflitti da neo-colonialismo, cercano di spacciare il jazz per una mera costola esotica della tradizione europea (di recente ho letto su Internet che Ellington di nero aveva solo la pelle, tutta la sua musica essendo di derivazione europea…!).
Naturalmente, sul contributo delle varie minoranze americane si getta facilmente discredito secondo teorie bislacche o consunte: da Paul Whiteman a Benny Goodman, da Dave Brubeck a Stan Getz, è tutto un biancore da condannare in toto, con le motivazioni più risibili (per quanto sia difficilmente negabile l’identificazione completa fra jazz e cultura africano-americana). Così come si disconosce l’opera di decine non di epigoni, ma di autori e interpreti il cui contributo non si può ignorare. Credo difficile che esista un melomane frequentatore della musica accademica che pretenda di vantare conoscenza senza avere mai udito le Sinfonie di Beethoven, le Cantate e le Passioni di Bach, le Sinfonie di Brahms, Mendelssohn, Schubert o Mahler, tanto per citare a caso. Nel jazz non è fatto inconsueto che vi sia chi discetta senza avere ascoltato una nota di Louis Armstrong o di Lester Young, di Hot Lips Page come di Benny Goodman, di Leo Parker come di Lawrence Brown. E quelli che, invece, discettano di jazz europeo, magari sproloquiando sull’improvvisazione nordica, ne ignorano in massima parte il contesto, i lineamenti artistici e storici, limitandosi a una contemporaneità della quale, per l’appunto, non conoscono il passato, si tratti di Albert Mangelsdorff o di Wolfgang Dauner, di Jean-Louis Chautemps come di Jutta Hipp o Alan Skidmore o André Hodeir o Zbigniew Seifert o Alexandre Stellio. Della stessa contemporaneità viene fatto strame, se non risponde ai criteri del trend in voga, con artificiose e manichee suddivisioni basate sui parametri di un’incultura.
A questo stato di cose ha contribuito certamente il nostro costante ritardo culturale, aggravatosi nel corso della prima metà del XX secolo, ma non solo. Negli ultimi trent’anni, con tutte le dovute eccezioni, un impasto poco gradevole di musicologia spicciola o pretenziosa, di giornalismo flebile o troppo prosaicamente interessato, di direzioni artistiche impreparate, velleitarie, ignave o altrettanto prosaiche, di agenzie musicali impreparate a tutto fuorché a vendere senza alcun criterio se non il guadagno immediato, di artisti più interessati a un carrierismo di basso livello, al compromesso e al successo sociale hanno condizionato una parte non trascurabile della nostra vita concertistica, già di molto danneggiata da un sistema culturale (fra editoria, scuole, università, conservatori, radio e televisioni) centripeto, miope, inquinato. A narrare tutto ciò si farà pure la figura del Grillo Parlante o dell’emulo di Bartali (L’è tutto da rifare…), però…
(Gianni Morelenbaum Gualberto)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- Chiodi nella bara
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Wayne Shorter: il compositore
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz