Il canto solitario del pianoforte di Keith Jarrett
Scoprire nel 2015 e all’alba dei suoi 70 anni, che il personaggio Jarrett faccia ancora discutere più del musicista fa abbastanza sorridere. Frasi come: “Sono contro Jarrett”, o persino, “Odio Jarrett”, che ci è capitato recentemente di leggere sui social della rete, lasciano come minimo perplessi, specie se pronunciate da chi il musicista lo fa di professione e magari con risultati artistici difficilmente paragonabili. Peraltro, è ben curioso che certe invettive rivelino tra le righe scarsa conoscenza della sua musica. Mi pare che certi termini siano più conformi a luoghi come le curve degli stadi che riservabili ad un dibattito sulla musica, magari con pretese “colte” e peraltro l’odio è sentimento che affonda solitamente le proprie radici nell’ignoranza.
Recentemente qualcuno mi ha detto che, avendo avuto a che fare con Ornette Coleman e tanti altri grandi musicisti, non ricorda di averne mai conosciuto uno come lui che sistematicamente si rifiutasse di parlar male di chicchessia, men che meno dei colleghi. Una persona straordinaria a quanto pare, oltre che un genio della musica, guarda caso.
In occasione del compleanno di Mr. Jarrett, abbiamo deciso di fargli omaggio, ripubblicando un mio scritto messo qualche tempo fa sul portale degli amici di Tracce di Jazz, arricchendolo in questo caso anche di link musicali, utili come riferimento alla lettura. Ovviamente manca l’analisi dell’ultimo lavoro in piano solo che è giusto in uscita in questo periodo.
Riccardo Facchi
Raramente un fenomeno musicale ha fatto discutere, dibattere ed accapigliare quanto il pianoforte improvvisato di Keith Jarrett, coinvolgendo trasversalmente strati di un uditorio di appassionati, critici e musicologi tra i più vasti e disparati, generando vere e proprie schiere di fan e altrettanti convinti detrattori, contrapposte tra loro in modo a volte curiosamente e discutibilmente fazioso.
 Eppure, (o forse proprio per questa ragione), a distanza di più di quarant’anni dalla pubblicazione del suo primo lavoro in piano solo, l’ormai storico Facing you, una analisi dell’opera discografica e concertistica del minuto pianista di Allentown sembra ancora lungi dall’essere stata effettuata. Ciò non è probabilmente un caso, poiché l’inconsapevole tendenza dei più a trattarlo come “personaggio”, in modo spesso pregiudiziale e superficiale, impedisce una valutazione critica sul vasto corpus discografico di questo che invece andrebbe considerato come uno dei musicisti americani più importanti comparsi nella seconda metà del Novecento.
Eppure, (o forse proprio per questa ragione), a distanza di più di quarant’anni dalla pubblicazione del suo primo lavoro in piano solo, l’ormai storico Facing you, una analisi dell’opera discografica e concertistica del minuto pianista di Allentown sembra ancora lungi dall’essere stata effettuata. Ciò non è probabilmente un caso, poiché l’inconsapevole tendenza dei più a trattarlo come “personaggio”, in modo spesso pregiudiziale e superficiale, impedisce una valutazione critica sul vasto corpus discografico di questo che invece andrebbe considerato come uno dei musicisti americani più importanti comparsi nella seconda metà del Novecento.
In realtà, non è questa però l’unica e un po’ semplicistica ragione a causare un distorto approccio critico. Ve n’è, infatti, una ben più profonda e precisa, strettamente legata al caratteristico e caleidoscopico mondo jarrettiano, fatto di una molteplicità di materiali e riferimenti culturali, sia più propriamente musicali, ma anche, e non subordinatamente, extra musicali, attingendo in maniera non particolarmente sistematica a fonti d’ispirazione che per provenienza geografica, culturale, sociale e non ultima, religiosa, spaziano in modo peculiarmente eterogeneo ed eterodosso. Un modo che è tipico di un’ “americanità” da lui in fondo così ben rappresentata (1). Questo quasi enciclopedico ed eclettico attingere, per così dire, all’enorme bacino culturale del mondo sembra cioè essere la causa primaria, non solo della sua ispirazione e creatività musicale, ma anche paradossalmente la ragione della grande difficoltà di collocazione stilistica e di metodologia interpretativa in cui viene a trovarsi chiunque tenti di attribuire un giudizio critico organico alla sua opera pianistica, sviluppata in circa quattro decenni di personale percorso musicale.
Chiariamo infatti e da subito un punto essenziale: per valutare Jarrett e la sua musica il critico, il musicologo, sia esso di estrazione accademica o jazzistica, ma anche il semplice ascoltatore appassionato, deve sforzarsi di operare cercando di abbandonare schemi precostituiti in fatto di musica, da qualsiasi direzione culturale egli provenga. In altre parole, occorre per un attimo saper dimenticare non solo le proprie preferenze musicali, ma anche rinunciare a voler inquadrare forzatamente la sua opera in un preciso ambito stilistico: il Jazz, piuttosto che la musica accademica, la New Age piuttosto che la World Music, o tanto altro ancora. Tutto questo pur potendo tranquillamente rintracciare i diversi elementi esplicati nella sua musica. Altrimenti si rischia di andare incontro a valutazioni critiche non perfettamente a fuoco. Non a caso musicologi ed esperti di chiara fama, come Piero Rattalino (2) e Marcello Piras (3), pur provenendo da campi musicologici agli antipodi tra loro (l’uno accademico, l’altro prettamente jazzistico), sono incorsi entrambi in giudizi negativi sul Nostro che letti oggi risultano essere dettati da filtri pregiudiziali poco idonei al contesto metodologico utilizzato da Jarrett.
In particolare, ciò che veniva sottolineato in negativo dei suoi concerti in solo piano era ed è ancora oggi la loro scarsa coerenza formale, il loro procedere “a tentoni”, l’assenza di equilibrio e sintesi, difetti tali da farli apparire come una sorta di lunga e illogica sonata cui però manca il rigore e il senso formale della forma-sonata. Il che è giudizio ben sorprendente e di dubbio senso, in quanto pone un preambolo formale a giudizio di una musica improvvisata, quasi da cima a fondo, confrontandola inconsciamente con la perfezione formale di opere costruite e pianificate a tavolino, se non totalmente scritte. Si vorrebbe imporre, cioè, ad una musica totalmente improvvisata, un criterio di valutazione generale, riferito ad un contesto musicale metodologicamente del tutto diverso e che il musicista volutamente e concettualmente mostra di voler abbandonare, puntando più su ispirazione e creazione istantanea insita nella generazione improvvisata del flusso sonoro. Con tale criterio l’intera opera di piano solo “live” di Jarrett andrebbe inevitabilmente a priori scartata, senza peraltro essere colti dal dubbio del perché mai un musicista di tale talento e provata integrità artistica abbia voluto sprecare così tante energie intorno ad un progetto musicale così evidentemente fallimentare.
D’altro canto, sarebbe però erroneo valutare l’opera di Jarrett, specie quella pianistica, sotto la sola ottica della musica improvvisata afro-americana. Il fatto è che raramente un musicista ha saputo essere interprete del suo tempo come Jarrett. Un’epoca in cui lo scambio culturale interplanetario, sospinto anche dall’enorme sviluppo dei mezzi tecnologici di trasporto e telecomunicazione ha permesso un sempre più rapido contatto tra genti e culture assai diverse tra loro, favorendo un processo di scambio globale anche in campo artistico e musicale, identificabile, a mo’ di splendido esempio, nella sintesi artistica del nostro.
Questo scritto vorrebbe quindi dare un modesto contributo, cercando di analizzare, in modo più o meno cronologico, le tematiche musicali, etiche ed estetiche sviluppate da Keith Jarrett nell’ambito della sua imponente discografia ufficiale in piano solo.
Come si diceva, fin dal suo primo tentativo inciso ufficialmente, “Facing you”, Jarrett fece scalpore e, nell’ambiente jazzistico (dal quale egli indiscutibilmente proveniva, creando successivamente clamorose incomprensioni della sua opera in piano solo), più d’uno gridò al miracolo e salutò con facile preveggenza la nascita di una nuova stella nel firmamento jazzistico.
Ai tempi di questa incisione (Novembre ’71), era in corso un vero e proprio boom per il Rock e per i suoni elettrificati (piano fender rhodes, tastiere varie, ecc.) e prevaleva anche tra i jazzisti l’utilizzo delle nuove sonorità elettriche su quelle acustiche. Inoltre sia sul versante Jazz-Rock che su quello Free (le due estetiche in voga in quegli anni tra la maggioranza dei jazzisti) prevaleva una esigenza di frammentazione e ridiscussione iconoclastica di tutte le forme e le strutture di riferimento sino a quel momento utilizzate. Jarrett con questo disco sembra invece voler andare controcorrente, pur essendo nel periodo coinvolto nei progetti di “black music fusion” di Miles Davis, esprimendo un’estetica apparentemente “reazionaria”, totalmente acustica, con un forte recupero della componente melodica in musica, e quindi in qualche modo inattuale, ma che invece si rivelerà anticipatrice dei tempi a venire (4). Inoltre, sino a quel momento, non erano stati ancora molti i pianisti jazz moderni ad aver già proposto opere in solo di nuova concezione, che non fossero cioè una raccolta o medley di standards (5), anche se in parecchi si apprestavano a farlo. Tra questi vi erano sicuramente Paul Bley (con “Open to love” e “Alone again”) e Cecil Taylor (con “Praxis”, del 1968 ma pubblicato solo nel 1982, “Spring of two blue J’s”, “Indent” e altre opere del periodo), pianisti non a caso assolutamente apprezzati e di riferimento per Jarrett, dai quali presto egli si affrancherà piuttosto nettamente, ma con i quali condividerà sempre il gusto per la melodia (Bley) e l’idea di una improvvisazione totale (Taylor). Presto l’incisione in piano solo sarebbe esplosa come una delle tante mode dell’epoca, forse proprio a causa di Jarrett, facendo anche discutibili proseliti.
E’ incredibile constatare come un’opera così nuova, libera e ben concepita sia stata registrata solo in poche ore da Jarrett, negli studi di Oslo della ECM, in un giorno libero concesso durante lo svolgimento della tournée europea del Miles Davis Group, di cui Jarrett faceva parte in quel periodo. In un contesto generale ricettivo della cultura pianistica occidentale, tra Romanticismo e Impressionismo, a cavallo tra Ottocento e Novecento, Jarrett si rende protagonista di una fulminante sintesi di tutto il pianismo jazz evolutosi sino a quel momento. L’ascolto di “In Front”, in particolare, meglio di ogni altro brano conferma questo concetto. In poco più di dieci minuti di musica, Jarrett sintetizza, in modo molto originale, tutti gli elementi portanti della storia del piano jazz: dal Ragtime al Pop-Rock, allora di moda, passando attraverso Boogie woogie, Gospel-Soul, R&B e la tradizione pianistica classica europea. Egli riesce oltretutto a dar giusta forma a un così vasto e impegnativo contenuto musicale, il tutto condito con una tecnica pianistica prodigiosa . “Ritooria” e “Lalene” sono invece due ottimi brani esplicativi dei due lati in qualche modo opposti della sua estetica, ampiamente sviluppati poi nei suoi successivi e colossali concerti “live” in piano solo. Il primo ci rivela l’aspetto più positivamente accademico della sua musica, il secondo quello più solare e melodico, legato alla musica popolare americana, più che afro-americana, per l’appunto. Tra gli altri brani del disco, comunque privo di concessioni e di impegnativo ascolto, si distinguono inoltre sue notevoli composizioni come “Starbright” e l’intimista “My Lady, My Child”, di chiara dedica familiare.
Pur essendo Facing you un capolavoro riconosciuto dai più ancora oggi, paradossalmente esso si dimostrerà ben presto una eccezione e per certi versi un disco poco rappresentativo della successiva produzione in piano solo di Jarrett, il quale introdurrà diverse novità essenziali di approccio alla materia musicale e di metodo esecutivo nella propria estetica, anche se non sempre, per la verità, in modo sistematico e coerente, ma dando ad ogni nuova avventura concertistica o discografica una concezione ed un “colore” del tutto peculiari e avendo nel contempo ben chiare in mente solo alcune direttive generali e di massima da seguire. Tutto il resto sarà libera improvvisazione, mandando letteralmente in “tilt” il giudizio della maggioranza dei critici e degli appassionati del jazz, così bellamente privati dei classici schemi di riferimento.
 Con i “Losanna/Bremen concerts”, di quasi due anni successivi, Jarrett e Manfred Eicher sembrano dunque voler dare una svolta “rischiosa” e innovativa, alla musica il primo, alla produzione discografica, il secondo. Dopo il clamoroso successo di Facing you si passa, infatti, alla pubblicazione esclusiva di lunghe esibizioni solistiche dal vivo, che comportano per il giovane produttore anche la pubblicazione di ingombranti e dispendiose edizioni discografiche in cofanetto che sembrano essere, per entrambi, una temeraria sfida al già difficile mercato discografico jazzistico.
Con i “Losanna/Bremen concerts”, di quasi due anni successivi, Jarrett e Manfred Eicher sembrano dunque voler dare una svolta “rischiosa” e innovativa, alla musica il primo, alla produzione discografica, il secondo. Dopo il clamoroso successo di Facing you si passa, infatti, alla pubblicazione esclusiva di lunghe esibizioni solistiche dal vivo, che comportano per il giovane produttore anche la pubblicazione di ingombranti e dispendiose edizioni discografiche in cofanetto che sembrano essere, per entrambi, una temeraria sfida al già difficile mercato discografico jazzistico.
Jarrett in particolare focalizza ed espande in questi concerti due concetti fondamentali da sempre in intrinseca connessione tra loro nell’ambito dell’evoluzione della musica afro-americana: sviluppo melodico e composizione istantanea. Tuttavia, egli li interpreta qui in modo totalmente nuovo rispetto al jazz più propriamente inteso, poiché “la melodia, in Keith Jarrett, è anche il metodo stesso del comporre istantaneo. E’ il punto cui tendere e il modello da mai riprodurre identico. Nel pianoforte di Jarrett non esiste il ritornello, la ripetizione non è contemplata. Nulla è concluso senza melodia, ma tutto ne è in fuga, verso un’altra melodia” (6). Inoltre, come afferma l’inglese Timothy Hill “Il contributo fondamentale che il jazz ha portato nel campo musicale è che la sua essenza è l’improvvisazione. Questo significa che il musicista è costretto a rischiare costantemente, andando oltre ciò che già conosce. Il musicista deve affinare la sua capacità di ascolto, in modo da poter entrare spontaneamente nel processo sonoro, diventare se stesso attraverso la musica; questa è la cosa più importante” (7). Tutto questo a voler rimarcare il fatto che, altrimenti e ad esempio, certi momenti di iterazione melodica e di apparente noiosa staticità armonica nei suoi concerti fiume, quanto mai a lui utili e necessari per generare successiva creatività melodica, non possono essere minimamente compresi e quindi possano essere giudicati con stroncanti e semplicistici giudizi critici.
In altre parole, Jarrett costringe ad un necessario mutamento di approccio nell’ascolto, scevro dal canone usuale di valutazione, che fa dell’equilibrio formale, del rigore strutturale e della logica nello sviluppo melodico-armonico elementi irrinunciabili di valutazione estetica, enfatizzando, senza ovviamente dimenticare i precedenti, la creazione istantanea e il valore della spontaneità nell’esperienza del suonare, ossia valori forse non propriamente intellettuali, ma certamente più idonei a valutare la musica improvvisata (8). Non a caso Jarrett afferma nel suo “Desiderio feroce”: “Io non mi sento esattamente un musicista. Quando mi ascolto suonare, ci sono momenti in cui realizzo che non si tratta solo di musica”. Per Jarrett non esiste infatti un confine tra musica e vita: per lui il musicista è qualcuno che è trasformato da quello che sente e da quello che suona.
D’altro canto, curiosamente egli non potrebbe essere nemmeno giudicato con i criteri propri della musica afro-americana, nonostante sia e sia sempre stato un musicista di chiara estrazione jazzistica. Da questi concerti, infatti, Jarrett comincia a far intravedere sempre più chiaramente che il jazz è solo una (forse la principale, ma non certamente l’unica) delle fonti d’ispirazione cui attingere, in un coacervo fatto di molteplici elementi: dalla canzone popolare alla new age, dagli inni sacri e profani sino alla musica classica europea e americana (a lui ben note sin dall’infanzia) e molto altro ancora, portandolo a rientrare, come sostiene acutamente Gianni M. Gualberto, più nell’ambito della cosiddetta “Americana” che in quello del Jazz (9).
Pur tenendo presente tutti questi elementi nell’ascolto del cofanetto, si deve tuttavia ammettere che i due concerti, specie il primo, quello di Losanna del Marzo 1973, non possono ancora dirsi opere del tutto compiute, che comunque non tarderanno ad arrivare di lì a pochi anni. Entrambi i concerti contengono validi spunti musicali, con note di eccellenza per il concerto di Brema, che sembra essere complessivamente il più organico, ispirato e riuscito dei due. Eccellente anche il breve bis al concerto (“Encore”), un brano di difficile esecuzione tecnica, contenente una sua superlativa improvvisazione, che Jarrett riproporrà brillantemente in altre circostanze concertistiche (Tokyo ’84, ad esempio).
 Il Köln Concert, registrato all’inizio del 1975, rappresenterà in breve e un po’ inaspettatamente per Jarrett, il vertice del suo successo discografico, il raggiungimento di una fama e una popolarità che riuscirà ad andare oltre il normale target di appassionati cui fino a quel momento si era rivolto e inevitabilmente darà una conseguente svolta alla sua carriera artistica e professionale. Eppure, guardando quel concerto a distanza di tempo, alla luce degli eventi successivi e con il necessario distacco, si deve paradossalmente considerare un caso a se stante nel panorama discografico jarrettiano e, tutto sommato, una delle sue prove musicalmente meno consistenti realizzate in tutta la sua carriera. Si tratta, come è noto dalle sue biografie, di un concerto sostanzialmente anomalo per svariate ragioni personali e negative circostanze organizzative, che tuttavia non impedirono a Jarrett di tirar fuori comunque il meglio compatibilmente con le circostanze. Un’esperienza questa che confermerà al suo autore come spesso la creazione artistica nasca più da situazioni di difficoltà, disarmonia e sofferenza piuttosto che dal benessere psico-fisico e che avrà modo di ripetere non infrequentemente negli anni a venire.
Il Köln Concert, registrato all’inizio del 1975, rappresenterà in breve e un po’ inaspettatamente per Jarrett, il vertice del suo successo discografico, il raggiungimento di una fama e una popolarità che riuscirà ad andare oltre il normale target di appassionati cui fino a quel momento si era rivolto e inevitabilmente darà una conseguente svolta alla sua carriera artistica e professionale. Eppure, guardando quel concerto a distanza di tempo, alla luce degli eventi successivi e con il necessario distacco, si deve paradossalmente considerare un caso a se stante nel panorama discografico jarrettiano e, tutto sommato, una delle sue prove musicalmente meno consistenti realizzate in tutta la sua carriera. Si tratta, come è noto dalle sue biografie, di un concerto sostanzialmente anomalo per svariate ragioni personali e negative circostanze organizzative, che tuttavia non impedirono a Jarrett di tirar fuori comunque il meglio compatibilmente con le circostanze. Un’esperienza questa che confermerà al suo autore come spesso la creazione artistica nasca più da situazioni di difficoltà, disarmonia e sofferenza piuttosto che dal benessere psico-fisico e che avrà modo di ripetere non infrequentemente negli anni a venire.
Le ragioni del successo senza precedenti di questo disco-concerto sono svariate e sono già state ben analizzate da altri (10), ma mi sembra siano legate, principalmente, da un lato ad una forma di ritualità nel gesto del suonare, dall’altro all’emozionalità della sua musica, magari esplicata in modo a tratti un po’ epidermico, ma che risulta alla fine essere assai diretta ed estremamente coinvolgente per l’ascoltatore-spettatore, che coglie così la sensazione di assistere e compartecipare ad un evento, piuttosto che ad una semplice ed usuale esibizione musicale.
Quel che è certo è che Jarrett con questo concerto ha avvicinato intere schiere di nuovi adepti non solo nel mondo della sua musica, ma anche indirettamente a quello del jazz e della musica improvvisata americana tout court. Un merito certo non trascurabile, che, in questo senso, lo accomuna ad un grande maestro-predecessore che aveva recentemente contribuito al suo lancio, il mitico Miles Davis, ma anche ad altre figure musicalmente trasversali e storiche del jazz, come un Louis Armstrong o un Benny Goodman.
Musicalmente invece il Köln Concert è sicuramente criticabile in più punti. Certe lungaggini e iterazioni contenute nelle parti IIa e IIb del concerto, anche se parzialmente giustificate dalla situazione contingente e dal suo credo estetico, sono in realtà un po’ banali e noiose e compromettono in parte la riuscita estetica del disco. In compenso, la notevole part I e il bis finale, part IIc (che peraltro è probabilmente un brano già suonato “live” da Jarrett qualche anno prima dal titolo “Memories of Tomorrow”) sono apprezzabili esecuzioni che possono mettere d’accordo un po’ tutti.
In realtà, certa emozionalità un po’ epidermica, nonostante l’indiscutibile successo del disco, sarà presto abbandonata da Jarrett che dimostrerà, come sempre nella sua carriera, rigore musicale e scarsissima propensione alla concessione commerciale ed all’ammiccamento, cosa che non si potrà certo dire di tanti altri affermati e validissimi pianisti coevi, come Chick Corea e Herbie Hancock, in fondo jazzisticamente assai meno discussi e curiosamente più accettati dall’establishment jazzistico, nonostante le numerose scivolate nel kitsch più inverecondo.
Il 1976 si rivelerà un anno decisivo e di svolta per le esibizioni in piano solo di Jarrett, con la produzione di alcune delle sue opere più mature, come “Staircase”, e soprattutto con l’opulenta e assieme ardita pubblicazione contemporanea di cinque concerti dell’autunnale tournée giapponese, che personalmente considero la sua opera concertistica più rappresentativa di piano solo improvvisato: “Sun bear concerts”.
Staircase, di qualche mese precedente è disco particolarmente calibrato e risulterà nella sua ricca discografia come uno dei rarissimi lavori di piano solo pensati e registrati in studio. Si tratta, di un’opera formalmente compiuta, già molto diversa e in definitiva assai più profonda rispetto al concerto di Colonia. Registrata al Davout Studio di Parigi nel Maggio di quell’anno, sempre d’opera improvvisata trattasi, ma questa volta pensata e strutturata organicamente in quattro parti distinte: “Staircase”, appunto, “Hourglass”, “Sundial” e “Sand”, ognuna delle quali sembra possedere motivazioni ispiratrici diverse e, in definitiva anche emozioni diverse. Si segnala in particolare per bellezza melodica e ispirazione la seconda parte, “Hourglass”. Decisamente una riuscita prova musicale che, pur affrancandosi notevolmente dalle concezioni jazzistiche più ortodosse, sembra fatta apposta per contraddire le già numerose critiche provenienti dalla critica jazz più rigida ed intransigente dell’epoca, dopo il successo del concerto di Colonia.
 Ma è con i Sun bear concerts che Jarrett tocca forse la vetta più alta ed innovativa della sua idea di pianoforte solo improvvisato, basata sul concetto, portato alle estreme conseguenze, di libera improvvisazione, così ben sviluppata nell’evoluzione della musica afro-americana e alla quale anche Jarrett fa indubbiamente riferimento (11). Un’improvvisazione che potremmo definire “totale” e che, se da un lato non parte solo e semplicemente prendendo spunto da un tema base, o da una struttura armonica, come normalmente viene intesa, dall’altro non richiede nemmeno la distruzione e la frammentazione dei suoi elementi costituenti per raggiungere quel grado di libertà così fortemente ricercato da grandi personaggi di riferimento jazzistico nel periodo, come Cecil Taylor, in qualche modo da considerarsi, nell’estetica, un suo stimato alter-ego. La libertà che cerca Jarrett, pur avendo alcuni punti in comune è, infatti, una libertà diversa, priva di iconoclastie, che rifugge di principio qualsiasi genere o momento di cacofonia e che si ripropone di elevare al massimo grado il potenziale espressivo e creativo dell’artista nell’atto del suonare.
Ma è con i Sun bear concerts che Jarrett tocca forse la vetta più alta ed innovativa della sua idea di pianoforte solo improvvisato, basata sul concetto, portato alle estreme conseguenze, di libera improvvisazione, così ben sviluppata nell’evoluzione della musica afro-americana e alla quale anche Jarrett fa indubbiamente riferimento (11). Un’improvvisazione che potremmo definire “totale” e che, se da un lato non parte solo e semplicemente prendendo spunto da un tema base, o da una struttura armonica, come normalmente viene intesa, dall’altro non richiede nemmeno la distruzione e la frammentazione dei suoi elementi costituenti per raggiungere quel grado di libertà così fortemente ricercato da grandi personaggi di riferimento jazzistico nel periodo, come Cecil Taylor, in qualche modo da considerarsi, nell’estetica, un suo stimato alter-ego. La libertà che cerca Jarrett, pur avendo alcuni punti in comune è, infatti, una libertà diversa, priva di iconoclastie, che rifugge di principio qualsiasi genere o momento di cacofonia e che si ripropone di elevare al massimo grado il potenziale espressivo e creativo dell’artista nell’atto del suonare.
La musica che sgorga dalle mani di Jarrett è dunque un flusso sonoro, espressione spontanea dell’attimo stesso in cui viene eseguita: forme, strutture, ritmi, melodie, colori, timbri e moods espressivi, vengono elaborati al momento, nell’incontro spazio-temporale espresso dall’esibizione concertistica, basandosi su una semplice idea tematica iniziale, una struttura ritmica o accordale, confidando sul proprio bagaglio di conoscenze, sulla propria consapevolezza di musicista e avendo massima fiducia sulle proprie risorse tecnico-espressive, tramutando l’esecuzione musicale in una vera e propria esperienza vitale, totalmente coinvolgente per se stesso e per chi ascolta. Si tratta, più che altro, di un’innovazione nell’approccio alla musica, di carattere pressoché mistico e che non può essere compresa senza un altrettanto orecchio mistico (12). Argomentazione questa che ha sempre stentato ad essere accettata dalla critica più ortodossa e tradizionale, diffidente a considerare certe componenti extra-musicali e che tende invece ad attribuire alla gestualità scomposta ed apparentemente eccessiva del pianista un atteggiamento puerilmente esibizionistico ed una manifestazione dell’ego. Si tratta probabilmente del suo esatto contrario, poiché Jarrett mette invece al centro la (sua) musica e non se stesso, mentre il giudizio critico sulla musica è spesso distorto e “distratto” visivamente dalle movenze del suo esecutore.(13)
Sta di fatto che le profonde implicazioni filosofiche e spirituali che Jarrett sembra suggerire col suo innovativo approccio sembrano non essere state prese seriamente in considerazione, soprattutto da chi poco conosce certe discipline mistiche, cui Jarrett fa direttamente o indirettamente riferimento e che peraltro sono state più volte citate nelle biografie e su svariate note discografiche che accompagnano i suoi CD (14).
Tutto quanto detto può essere meglio compreso ascoltando uno qualsiasi dei cinque concerti (tutti diversi tra loro e praticamente eseguiti ogni due giorni e questo la dice lunga sull’onestà del procedimento creativo seguito) tenuti da Jarrett nelle grandi città del Giappone nel Novembre del ’76 e che ne ospitavano gli eventi, cui i concerti sono intitolati: Kyoto, Osaka, Nagoya, Tokyo e Sapporo. In particolare la procedura esplicata si avverte nei concerti di Kyoto, Nagoya e Sapporo, certamente tra i più riusciti ed ispirati della serie, ma un po’ tutti i concerti contengono spunti eccelsi di grande musica, mostrando uno standard medio di creatività ed ispirazione estremamente alto, raramente toccato da Jarrett in carriera.
Dopo un Vermont solo del 1977 pubblicato prima in video e poi in CD (bootleg), dal dubbio esito, Jarrett sembra passare un periodo di involuzione nella proposta al piano solo improvvisato, in parte abbandonandolo e virando, da buon eclettico qual egli è ed è sempre stato, verso una concezione più di stampo accademico-europeo che prossima al jazz, realizzando in studio, nel 1980, una specie d’ibrido tra improvvisazione e composizione dal titolo “The Moth and the flame”. Un lavoro forse più rigoroso e strutturato rispetto ai precedenti, apprezzato in ambienti accademici, ma contraddittorio nell’estetica, volto a riconoscere, ancora una volta, il primato musicale del Novecento alla musica accademica più che a quella improvvisata, jazz in testa. Un’opera da considerarsi sostanzialmente come eccezione nella discografia jarrettiana e che personalmente stento a considerare nelle sue incisioni di pianoforte improvvisato. Curioso constatare come un tale lavoro abbia invece riscosso un certo riscontro (vincendo il Premio della Critica Musicale Italiana, Sez. Musica Classica-1982) proprio da quella critica accademica che in fondo dimostra, premiando questo disco, quanta poca conoscenza vi sia di Jarrett, del jazz e della musica improvvisata più in generale. (15)
Occorrerà attendere l’anno successivo (discograficamente il 1982) per poter rivedere Jarrett spontaneamente all’opera al piano solo, nei concerti di Bregenz e Monaco, pubblicati da ECM nell’ennesimo cofanetto, composto di 3LP. Tuttavia, come rileva giustamente Franco D’Andrea in una sua autorevole recensione del periodo (16) , i concerti sembrano risentire fortemente di un certo accademismo, in particolare, dell’influenza classico-romantica e neo-classica. Il concerto di Bregenz, pur avendo un inizio ispiratissimo (una decina di minuti circa) complessivamente non soddisfa appieno, mentre quello di Monaco, più complesso e ardito, pare più interessante anche grazie a due meravigliosi bis al concerto che, seppur trattati in modo più tradizionale, segnalano ancora una volta l’enorme talento melodico di Jarrett, specialmente nella spettacolosa interpretazione su “Mon Coeur est rouge”.
A parte un bel “Keith Jarrett Last Solo” del 1984 registrato a Tokyo in video, occorrerà attendere ben sei anni prima di risentire in piano solo Jarrett, con due opere assai diverse tra loro ma entrambe molto significative, come “Dark Intervals” e “Solo Tribute” (edizione questa in realtà distribuita ancora in video), registrate alla Suntory Hall di Tokyo rispettivamente l’11 e il 14 Aprile 1987. Principalmente il motivo di un così ampio arco di tempo nelle pubblicazioni credo sia da ricercare nel fatto che in quegli anni egli fosse particolarmente coinvolto e concentrato sullo sviluppo del progetto in Trio sugli standards, a carattere prettamente jazzistico. In questo senso, non prenderemo pertanto qui in considerazione l’analisi di Solo Tribute che, seppur registrato in solo e di notevole livello, rientra sostanzialmente nella concezione interpretativa già sviluppata in parallelo con Gary Peacock e Jack De Johnette, con l’eccezione del brano “Sound”, molto simile a quanto sviluppato in “Dark Intervals”, nel concerto di qualche giorno antecedente.
Oltre a questo, vi è comunque un altro elemento comune ai due concerti da rilevare (ma estendibile a tutte le sue esibizioni di quel 1987), e cioè l’alto livello di ispirazione, quasi mistica, raggiunto in entrambi i concerti. La sua musica sembra essersi fatta ancor più profonda, in un discorso musicale sempre più disancorato dai canoni jazzistici più ortodossi e sempre più impegnato invece ad espandere l’esperienza vitale nel suonare. Non è ormai più un mistero che Jarrett gradisca esibirsi nel Paese del Sol levante, ove, guarda caso, riesce quasi sempre a raggiungere le migliori performance concertistiche, specie in piano solo, e conseguentemente a produrre un gran quantitativo di materiale utile alle incisioni discografiche. Le ragioni sono intimamente connesse sia alle già accennate modalità d’approccio, sia al peculiare background culturale e filosofico cui Jarrett fa riferimento, entrambi elementi perfettamente a conoscenza della sensibilità di un pubblico giapponese che, secondo Jarrett, evidentemente contribuisce e compartecipa al meglio alla nascita dell’atto creativo (17).
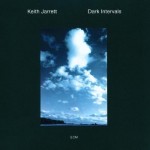 In questo senso Dark Intervals costituisce uno dei suoi concerti più significativi, anche se all’apparenza un po’ lugubre e che farà da riferimento per tutte le successive pubblicazioni concertistiche. Un’esibizione in cui Jarrett abbandona il criterio di flusso creativo continuo e sembra voler sviluppare in musica il concetto di silenzio (18), in varie forme e modalità, riferendosi in particolare ad una sua precisa forma: la pausa musicale. Una pausa (con la quale si sottintende il dark intervals del titolo) spesso breve, infinitesimale, in cui il pensiero e le mani “meditano” allo scopo di decidere la direzione da dare ai suoni successivi. Impressiona, anche se forse esteticamente può lasciare perplessi, un brano come “Opening” in cui, d’altro canto, Jarrett sembra esplicare in musica quel concetto di ricerca “feroce” dell’energia creativa che è in fondo la radice prima di ogni sua buona improvvisazione. “Hymn”, “Americana” e “Ritual Prayer” sono brani invece apprezzabili anche dal punto di vista strettamente musicale, soprattutto in virtù delle belle sequenze melodiche presenti, tipiche del miglior Jarrett.
In questo senso Dark Intervals costituisce uno dei suoi concerti più significativi, anche se all’apparenza un po’ lugubre e che farà da riferimento per tutte le successive pubblicazioni concertistiche. Un’esibizione in cui Jarrett abbandona il criterio di flusso creativo continuo e sembra voler sviluppare in musica il concetto di silenzio (18), in varie forme e modalità, riferendosi in particolare ad una sua precisa forma: la pausa musicale. Una pausa (con la quale si sottintende il dark intervals del titolo) spesso breve, infinitesimale, in cui il pensiero e le mani “meditano” allo scopo di decidere la direzione da dare ai suoni successivi. Impressiona, anche se forse esteticamente può lasciare perplessi, un brano come “Opening” in cui, d’altro canto, Jarrett sembra esplicare in musica quel concetto di ricerca “feroce” dell’energia creativa che è in fondo la radice prima di ogni sua buona improvvisazione. “Hymn”, “Americana” e “Ritual Prayer” sono brani invece apprezzabili anche dal punto di vista strettamente musicale, soprattutto in virtù delle belle sequenze melodiche presenti, tipiche del miglior Jarrett.
Con il “Paris concert”, del 1988, Jarrett compie un ulteriore passo avanti verso l’approfondimento mistico in musica (19) introducendo qualcosa di fortemente “bachiano” nelle sue performances. “Quando voi ascoltate Bach, vedete nascere Dio. La sua opera è generatrice di divinità. Dopo un oratorio, una cantata o una Passione, è necessario che Egli esista. Altrimenti tutta l’opera del Cantor sarebbe una straziante illusione. E pensare che tanti teologi hanno perso giornate e notti a cercare le prove dell’esistenza di Dio, dimenticando l’unica”. Questa citazione di Cioran, meglio di ogni altra esprime a parole la perfezione universale, pressoché cosmica, della musica di J.S. Bach, autore che più di ogni altro sembra avvicinarsi con la sua arte all’entità suprema.
Nella lunga introduzione al brano semplicemente intitolato “17 Ottobre 1988”, Jarrett è pronto a cogliere e ad assimilare perfettamente, nel suo eloquio, la componente trascendente nella musica del suo illustre predecessore. Non a caso proprio in quel periodo Keith studia e approfondisce la lezione del grande maestro tedesco, pubblicando le sue interpretazioni del Clavicembalo Ben Temperato. L’approfondimento si coglie del resto anche nell’ambito delle contemporanee pubblicazioni in Trio (si veda ad esempio Autumn leaves, in “Still Live” o l’introduzione di All the things you are, in “Tribute” o l’esecuzione a due voci di Woodyn You, in “The Cure”), dove le sue improvvisazioni più “jazzistiche” acquisiscono un evidente carattere “bachiano” e una bellissima tendenza allo sviluppo fugato e polifonico del discorso musicale.
Paris concert non si distingue tuttavia solo per il lungo brano citato, in fondo da considerare una prosecuzione del discorso iniziato con Dark Intervals. Esso riporta, infatti, due bellissimi brani di estrazione più propriamente jazzistica, mai totalmente abbandonata da Jarrett in carriera, rispolverando un brano come “The Wind”, del misconosciuto pianista West Coast anni ’50 Russ Freeman e una sua notevole improvvisazione su blues. Un’alternanza di proposte che ripeterà sempre più spesso nei concerti successivi e che dimostra ancora una volta la sua grande cultura jazzistica.
Il “Vienna concert”, pubblicato nel 1993 ma registrato nel 1991, prosegue (purtroppo dal punto di vista del sottoscritto) sulla strada già tracciata, di progressivo allontanamento dal jazz ed è sicuramente un altro episodio che documenta una delle performance in piano solo improvvisato di Jarrett più d’ispirazione classica. Gli elementi afro-americani qui sono infatti volutamente ridotti all’osso, ma la sua consapevolezza di musicista maturo e personale sembra ormai emergere in modo quasi carismatico, producendo comunque sintesi musicali interessanti e confermando capacità di generare momenti musicali di rara bellezza. “Ormai, quando un pianista si scopre disposto a uscire dalle griglie del jazz o della tradizione colta per entrare in un terreno che sia di tante o di tutte le culture, si dice che suona a la Jarrett. Il modello è lui, non perché oggetto consapevole di imitazione, ma perché il suo modo di suonare ha già esplorato infinite sintesi possibili. Ormai, suonare il pianoforte cosiddetto di confine rende tutti, ineluttabilmente, epigoni di Jarrett”(20)
 Considero il concerto del 13 febbraio 1995 al Teatro alla Scala il suo in piano solo più riuscito dai tempi dei Sun Bear Concerts. Si tratta di un concerto dallo sviluppo affascinante, per la presenza di momenti sofferti ed estatici dopo il quale, con l’eccezione del particolare “The melody at night with you”, un disco crepuscolare ed intimista registrato in casa nel periodo della nota lunga malattia, ma fatto in sostanza di soli standards, Jarrett non ha più inciso in questo tipo di situazione sino al 2002. E’ questo un concerto in cui si trova di tutto, dalle influenze orientali, alla musica accademica, dallo standard, all’atonalità jazzistica, in un’esibizione che lascio alla bella e adatta descrizione contenuta nella cronaca dell’epoca di Franco Fayenz: “E’ il momento dunque. Il pianista ha un attimo di esitazione davanti alla tastiera, poi ecco un ricciolo di note che subito ne richiama un altro e prende quota su un tempo medio-lento. Chi se ne intende capisce che il seme è buono. Il flusso è postromantico, di grande poesia. La gestualità di Jarrett è la solita: si alza in piedi, ondeggia davanti allo strumento, si china sino a sfiorare la tastiera con la fronte alla maniera di Bill Evans. Ogni tanto mugola o canticchia, abbandona il pedale, picchia il pavimento col piede destro. Il clima quasi chopiniano cede insensibilmente il luogo a un motivo orientale. Poi i suoni tendono a dare segni d’incertezza e perfino a spegnersi. E’ il momento in cui l’improvvisazione brancola alla ricerca di un nuovo nucleo. Jarrett lo trova, inventa un ritmo fosco e ostinato, accenna a melodie poi negate, attinge a depositi della memoria e frantuma assieme Bill Evans e ragas indiano, Stephen Foster e Chopin, Liszt e Bud Powell. Il pubblico segue rapito, attonito. E quando dopo tre quarti d’ora, Jarrett rientra fra le quinte, scatta in un applauso impressionante e lo richiama per cinque volte. Prendo nota che la Scala ha ottenuto l’intervallo che il nostro, di regola, nega. Adesso per lui è come se cominciasse un secondo concerto. Capisco che il seme è di nuovo fecondo, ma porta da tutt’altra parte, verso la contemporaneità e verso un linguaggio più conciso e sicuro, fitto di riferimenti alle sue esperienze classiche. Un interludio romantico conduce a un epilogo informale stranamente dolce, esposto a mani incrociate, che termina con un “alt” brusco e inatteso, stupendo. E’ trascorsa un’altra mezz’ora, la sala esplode. Le chiamate non si contano, i bis sono quattro: un blues, il vecchio “Danny boy” reinventato, un flamenco, il delizioso “Over the rainbow”. Jarrett trasforma lo standard nell’adagio di una sonata, ed è il trionfo”(21).
Considero il concerto del 13 febbraio 1995 al Teatro alla Scala il suo in piano solo più riuscito dai tempi dei Sun Bear Concerts. Si tratta di un concerto dallo sviluppo affascinante, per la presenza di momenti sofferti ed estatici dopo il quale, con l’eccezione del particolare “The melody at night with you”, un disco crepuscolare ed intimista registrato in casa nel periodo della nota lunga malattia, ma fatto in sostanza di soli standards, Jarrett non ha più inciso in questo tipo di situazione sino al 2002. E’ questo un concerto in cui si trova di tutto, dalle influenze orientali, alla musica accademica, dallo standard, all’atonalità jazzistica, in un’esibizione che lascio alla bella e adatta descrizione contenuta nella cronaca dell’epoca di Franco Fayenz: “E’ il momento dunque. Il pianista ha un attimo di esitazione davanti alla tastiera, poi ecco un ricciolo di note che subito ne richiama un altro e prende quota su un tempo medio-lento. Chi se ne intende capisce che il seme è buono. Il flusso è postromantico, di grande poesia. La gestualità di Jarrett è la solita: si alza in piedi, ondeggia davanti allo strumento, si china sino a sfiorare la tastiera con la fronte alla maniera di Bill Evans. Ogni tanto mugola o canticchia, abbandona il pedale, picchia il pavimento col piede destro. Il clima quasi chopiniano cede insensibilmente il luogo a un motivo orientale. Poi i suoni tendono a dare segni d’incertezza e perfino a spegnersi. E’ il momento in cui l’improvvisazione brancola alla ricerca di un nuovo nucleo. Jarrett lo trova, inventa un ritmo fosco e ostinato, accenna a melodie poi negate, attinge a depositi della memoria e frantuma assieme Bill Evans e ragas indiano, Stephen Foster e Chopin, Liszt e Bud Powell. Il pubblico segue rapito, attonito. E quando dopo tre quarti d’ora, Jarrett rientra fra le quinte, scatta in un applauso impressionante e lo richiama per cinque volte. Prendo nota che la Scala ha ottenuto l’intervallo che il nostro, di regola, nega. Adesso per lui è come se cominciasse un secondo concerto. Capisco che il seme è di nuovo fecondo, ma porta da tutt’altra parte, verso la contemporaneità e verso un linguaggio più conciso e sicuro, fitto di riferimenti alle sue esperienze classiche. Un interludio romantico conduce a un epilogo informale stranamente dolce, esposto a mani incrociate, che termina con un “alt” brusco e inatteso, stupendo. E’ trascorsa un’altra mezz’ora, la sala esplode. Le chiamate non si contano, i bis sono quattro: un blues, il vecchio “Danny boy” reinventato, un flamenco, il delizioso “Over the rainbow”. Jarrett trasforma lo standard nell’adagio di una sonata, ed è il trionfo”(21).
Tra “La Scala” del febbraio 1995 e il successivo “Radiance” dell’ottobre 2002, ci sta di mezzo, come noto, la sua malattia diagnosticata come “sindrome da affaticamento cronico” che lo ha tenuto dall’autunno 1996 a tutto il 1998 lontano da concerti e studi di incisione, riprendendosi nel 1999 prima solo con il Trio e permettendosi evidentemente faticosi concerti live solo appunto dal 2002.
A distanza di anni non ci si può nascondere che dopo quell’evento qualcosa è cambiato, a mio modo di vedere in peggio per Jarrett, soprattutto a livello creativo e di energie, evidenziando la necessità di rimodellare le proprie esibizioni su pretese psico-fisiche più ragionevoli e consone al quadro sanitario complessivo. Non a caso i suoi concerti non sono più avvicinabili dal punto di vista creativo a quegli estenuanti continuum musicali di oltre 40 minuti per tempo con i quali si proponeva negli anni ’70 e ‘80. I nuovi concerti sono più che altro una sequenza di brani più brevi, dell’ordine al massimo della decina di minuti o poco più, a volte notevoli, dai moods differenti, ma alternati in modo che appare abbastanza pianificato: un brano free si alterna ad uno più melodico-innodico, uno di stampo più accademico ad un brano di ispirazione modale o post bop. Un paio di bis a base di deliziosi standards o blues concludono immancabilmente i suoi concerti. Tutto diventa più prevedibile, seppur a volte con esecuzioni ed interpretazioni eccezionali, ma l’impatto emotivo ed innovativo di un tempo sembra ormai perso per sempre. Il tutto in un quadro complessivo delle sue proposte che sembra ormai cristallizzarsi in una sorta di perfetto neoclassicismo (jazzistico nel caso del Trio Standards) dal quale Jarrett sembra però non voler più uscire. Prova ne sia che, di fatto, da almeno un paio di decenni non esce più alcuna concreta novità, sia in termini di progetti musicali che a livello di composizione scritta (arte nella quale in passato ha dimostrato di non essere da meno rispetto a quella istantanea improvvisata, di cui è maestro).
In questo quadro generale, i concerti ad oggi pubblicati, quasi integralmente, sono nell’ordine: “Radiance” del 2002, “Carnegie Hall Solo Concert” del 2005, “Paris/London- Testament” di fine 2008, “Rio” dell’aprile 2011 e il recente “Creation” del 2015.
 “ Radiance” è un disco ricavato dai concerti di Osaka e Tokyo della fine di ottobre, in occasione del suo 150° concerto in Giappone e so essere molto apprezzato dai fan di Jarrett che provengono più da conoscenze classiche che jazzistiche, ma che a mio avviso è, a distanza di tempo, da valutare come un disco sopravvalutato e troppo intriso, specie per quanto concerne il concerto di Tokyo, di un neoclassicismo di stampo accademico abbastanza stantio. Gli elementi jazz sono praticamente e inspiegabilmente del tutto depurati, cosa che forse avrà fatto la gioia di ECM e del suo produttore, ma che in realtà rendono già vecchia e appiattita su canoni già noti una musica improvvisata che pretenderebbe di risultare “nuova”. Il che non impedisce comunque a Jarrett di scovare e suonare ancora stupende melodie, alternate a brani più astratti che, più che seguire il modello “free” a la Cecil Taylor, paiono influenzati dalle idee di compositori accademici americani del Novecento, quali ad esempio Charles Ives e Elliot Carter. D’altronde il talento quando indubbiamente c’è e rimane, come nel suo caso, riesce sempre ad offrire qualcosa di buono, se non addirittura di eccelso.
“ Radiance” è un disco ricavato dai concerti di Osaka e Tokyo della fine di ottobre, in occasione del suo 150° concerto in Giappone e so essere molto apprezzato dai fan di Jarrett che provengono più da conoscenze classiche che jazzistiche, ma che a mio avviso è, a distanza di tempo, da valutare come un disco sopravvalutato e troppo intriso, specie per quanto concerne il concerto di Tokyo, di un neoclassicismo di stampo accademico abbastanza stantio. Gli elementi jazz sono praticamente e inspiegabilmente del tutto depurati, cosa che forse avrà fatto la gioia di ECM e del suo produttore, ma che in realtà rendono già vecchia e appiattita su canoni già noti una musica improvvisata che pretenderebbe di risultare “nuova”. Il che non impedisce comunque a Jarrett di scovare e suonare ancora stupende melodie, alternate a brani più astratti che, più che seguire il modello “free” a la Cecil Taylor, paiono influenzati dalle idee di compositori accademici americani del Novecento, quali ad esempio Charles Ives e Elliot Carter. D’altronde il talento quando indubbiamente c’è e rimane, come nel suo caso, riesce sempre ad offrire qualcosa di buono, se non addirittura di eccelso.
Il concerto alla Carnegie Hall, per quanto concerne la prima parte è come impostazione simile a “Radiance”, ma propone una seconda parte molto più vivace, coinvolgendo l’ascoltatore in una sorta di celebrazione di sé stesso e del proprio glorioso passato, con la riproposizione di diversi brani noti di Jarrett come “Mon Coeur est rouge” (che non rieseguiva da tempo immemore. Forse proprio da Monaco ’81), “My Song” e uno standard conclusivo. Brani certo notevoli, ma che a mio avviso, se confrontati con le versioni del passato, mostrano ad un attento ascolto molta minor freschezza ed energia esecutiva. Una specie di monumento a se stesso che francamente documenta in modo latente una discreta carenza di nuove idee.
Considero invece i due concerti di Parigi e Londra del 2008, raccolti in “Testament” davvero una sorta di suo lascito creativo e una sua prova concertistica maiuscola, nettamente la più riuscita dell’ultimo periodo, molto ispirata e musicalmente decisamente più varia, soprattutto per la presenza stavolta non occasionale della componente più propriamente jazzistica e un ritorno al Jarrett più sapido dei primi dischi in solo. Il concerto di Parigi, più teso, sofferto e cupo (Jarrett si era da pochissimo lasciato dalla moglie) rispetto a quello più sereno e meditabondo di Londra, contiene un paio di brani eccezionali, sia dal punto di vista della tecnica pianistica che musicale: l’iterativa Part II CD1, che sembra una sorta di Turkish Mambo di Lennie Tristano in versione “live” e la strepitosa Part VI CD1, dalla travolgente pronuncia ritmica jazzistica. Quello di Londra, complessivamente più compatto ed equilibrato, eccelle in particolare nel CD3 che a tratti ricorda il miglior Jarrett anni ‘70.
Inferiore a livello di reale ispirazione e creatività è invece a mi avviso “Rio”, che, seppur di analoga struttura e ideazione rispetto al precedente, ha goduto di grande riscontro per una abile e astuta operazione di marketing da parte di ECM, presentandolo come opera capolavoro scelta e imposta per la pubblicazione dallo stesso autore. In realtà si tratta solo di un ottimo concerto, che propone però a tratti, nella suddetta programmata alternanza di brani, un melodismo abbastanza semplice ed ammiccante, e alcuni stereotipi jarrettiani dell’ultimo periodo, certo ben presentati, ma forse privi di quella verace ispirazione tale da farlo considerare un autentico capolavoro.
Note
1 “Jarrett è un Christian Zionist (il fenomeno del Sionismo Cristiano, nei suoi rapporti sia con il Sionismo che con la tradizione ebraica e con il desiderio della riunificazione delle dodici tribù di Israele, è assai diffuso in certe aree degli Stati Uniti) nato in Pennsylvania da famiglia rigorosamente praticante la fede definita Christian Science (la “Church of Christ, Scientist” venne fondata da Mary Baker Eddy nel 1879 a Boston: essa predica che Dio e la sua creazione sono le uniche realtà possibili. Dio è dunque Verità, Vita Infinita, Mente, Spirito e Principio. Il mondo materiale, con tutte le sue sofferenze e miserie,non è che una percezione distorta del piano divino. Attraverso la miracolosa guarigione degli infermi, secondo i Christian Scientist, si prova che anche ai nostri giorni l’efficacia del piano divino è immutata così come lo era ai tempi di Cristo. I praticanti di tale setta si affidano perciò alla legge e alla pietà divina nei momenti di malattia, rifiutando perciò le cure mediche convenzionali come stabilisce il testo principale della Eddy, “Science and Health with Key to the Scriptures” , il che, come per i Testimoni di Geova, ha portato a numerosi scontri legali, soprattutto nel caso della tutela della salute di minori); tale primitivismo cristiano di stampo chiaramente monistico, con la sua tradizione miracolistica, ha avuto da sempre rapporti estremamente eterodossi con la cultura americana, assimilandone molteplici fonti in modo non particolarmente sistematico, e cogliendone, ad esempio, in ambito musicale, il tratto innodico a più livelli, che è tratto caratteristico, tanto per citare, dell’arte di Jarrett. Allo stesso modo, i Christian Scientist praticano il sermone in forme varie, il che non ha creato una separazione nei confronti della religiosità africana-americana. Jarrett elabora molteplici elementi di tale tradizione, e con grande idiomaticità, pur corrispondendovi solo spiritualmente, non per derivazione etnica” – G. M. Gualberto ↑
2 Vedi “Invenzione e quotidianità per ritrovare un ruolo perduto” Musica Viva, Marzo 1982 – di Piero Rattalino. ↑
3 Vedi “Il caso Jarrett: Quelle cattedrali sono di cartone…” Musica Jazz, Novembre 1983 – di Marcello Piras. ↑
4 “L’arte di scrivere melodie se n’è volata via” lamentava Jarrett ancora a Joshua Rosembaum. “Perché la melodia è morta? Ci sono forse un migliaio di risposte. Quando Dio è morto, la melodia è morta. Quando siamo diventati dubbiosi, il dubbio ha cominciato a regnare. La melodia non lascia spazio al dubbio. La melodia parla direttamente. Non dice mai “non sono sicuro”. Ma in assenza di un credo, non puoi lasciare che la melodia ti entri nel cuore…Non credo che la nostra cultura meriti la melodia, ora. La melodia è emozione. La melodia è una sorta di fluido. In un epoca scandita dagli impulsi dell’immagine, la melodia diventa una possibilità più remota, perché non abbiamo la concentrazione per ascoltare la melodia nella sua interezza”. Jarrett parla di sé e della sua inattualità. Mai come nel secondo dopoguerra la musica ha nutrito tanta diffidenza nei confronti della melodia e dell’emozione. Tutta la cosiddetta avanguardia storica, discesa per i rami della Nuova Scuola di Vienna, scivolata lungo il tronco di Webern e poi dispersasi in cento direzioni attraverso i prati di Darmstadt, ha per quarant’anni instillato nell’estetica contemporanea in chi fa e in chi ascolta una infettiva allergia melodica, di cui solo da poco sta scemando la contagiosità. Si sono costruiti sistemi in cui la melodia era completamente assente, accuratamente evitata, dichiarata inesistente, anzi dannosa. Il dominio post-serialista ha sentenziato che contemporaneo e melodico erano contraddizioni di termini. Un musicista come Keith Jarrett, che, a parte i giorni delle tastiere elettriche nel supergruppo di Miles, ha sempre pensato melodicamente, non poteva che vivere questa condizione come inattualità. Che a sua volta, se lucida e coerente, è lo stato di un’attualità a venire. Tratta da “il mio desiderio feroce”, Novembre 1994 – Prefazione di Carlo Maria Cella. ↑
5 Tra questi sono certamente da segnalare Dollar Brand, con opere significative ed antecedenti come “African Piano” e Chick Corea con le “Piano Improvisations”, appena incise nella primavera dello stesso anno per la medesima nascente casa discografica ECM. ↑
6 da “il mio desiderio feroce”, Novembre 1994 – Prefazione di Carlo Maria Cella. ↑
7 da “il mio desiderio feroce”, Novembre 1994 – Prefazione all’edizione inglese di Timothy Hill. ↑
8 ”Chi si lascia sedurre dalle sue maratone pianistiche, deve fare i conti con marce forzate, con lunghi ostinati, con piani sonori irresoluti e sospesi, vere e proprie nebbie dalle quali solo lentamente si sviluppa il motivo che costituirà la fase successiva: una serie di accordi, un frammento melodico o anche solo una figura ritmica”. da “The changes of the changeless”, Novembre 1994 – Saggio di Peter Rüedi. ↑
9 Sempre per rimanere in ambito di “Americana”, Jarrett sembra possedere con il jazz e con il vasto spettro della cultura africana-americana, lo stesso rapporto che Aaron Copland aveva con la cultura tradizionale del Midwest e del West: vi intravede, insomma, la chiave di lettura della propria più profonda identità culturale, senza però avere con essa un rapporto diretto, di nascita naturale. Da lì, direi, quell’enciclopedismo stilistico presente in Jarrett. Da lì quel concetto estremamente rielaborativo di una vastissima messe di materiale, che conferisce a certe esecuzioni di Jarrett una sorta di narratività quasi “biblica” nel partire dalle origini per giungere ad un’affermazione contemporanea dopo avere esibito e attraversato apparentemente l’intero scibile del pianismo americano e africano-americano improvvisato. ….Certamente, nella sua eterodossia, egli è uno fra i più originali e personali artisti, americani ma non solo, ad emergere nell’ultimo cinquantennio, e il suo contributo alla divulgazione e alla comprensione dell’improvvisazione è marcatissimo, per certi versi ben più che semplicemente significativo. La sua eterodossia ne fa un esempio artistico a se stante, senza possibili riferimenti a un unico ambito musicale: più che al jazz in sé, Jarrett ha fatto fare un grande balzo in avanti alla cosiddetta “Americana”, impresa riuscita a pochissimi jazzisti presi singolarmente. D’altronde, in questa enciclopedica, spesso eclettica eterodossia, è impresa improba voler vagliare i risultati solo alla luce dell’improvvisazione jazzistica, che nell’estetica di Jarrett, per quanto importante, non è l’unico elemento fondamentale, sottolineando ancora una volta il dinamismo di una cultura, quella del Nuovo Mondo, capace di un’assimilazionismo rielaborativo di straordinaria rilevanza, un vero modello per l’evolversi di futuri cicli culturali. – G. M. Gualberto. ↑
10 “Le esibizioni solistiche di Keith Jarrett hanno attirato in tutto il mondo un pubblico che è del tutto inusuale, non solo per il jazz, ma per la musica improvvisata in genere. La comunità jarrettiana è qualcosa di più di un incontro tra amanti della musica; i suoi concerti sono più che manifestazioni artistiche. Sono un rito, un avvenimento spirituale, si potrebbe dire trip collettivi, durante i quali uno stregone della musica trasporta i suoi seguaci dal silenzio, via via, attraverso gli spazi della sua immaginazione, e di nuovo al silenzio.” Da “The changes of the changeless”, Novembre 1994 – Saggio di Peter Rüedi. ↑
11 “Il jazz è per se stesso improvvisazione. Ogni momento storico della musica nera ne è segnato. Improvvisavano Scott Joplin e Eubie Blake, improvvisavano Ellington, Monk, Peterson; improvvisatori sono Paul Bley e Cecil Taylor. Ma l’improvvisazione di Keith Jarrett ha qualcosa di diverso, di religioso e di più universale. E’ musica fatta di mille musiche e s’impone asceticamente di inventare ogni volta tutto: lo stile, la forma, il contenitore stesso. L’improvvisazione di Jarrett è un free climbing che affida alla prensilità delle dita, alla flessibilità del corpo, alla concentrazione del pensiero, non solo la strada e la meta, ma la sua stessa vita….Pochi, forse nessun pianista può vantarsi di dare ogni volta forma e architettura convincenti a un attraversamento così lungo di stili e di forme, dal ragtime al free, dal clavicembalo a Webern. L’improvvisazione di Jarrett travalica quella degli afroamericani e degli europei (questa praticamente estinta) per aver trovato un supercodice capace di muoversi nel più grande affollamento di musiche e codici che il pianoforte abbia finora conosciuto”. Da “il mio desiderio feroce”. Novembre 1994 – Prefazione di Carlo Maria Cella. ↑
12 “Anche il più distratto degli spettatori, solo che sia sensibile ai segni, davanti a un’improvvisazione di Keith Jarrett non può fare a meno di avvertire l’alone di un rito sciamanico, il corpo che geme, si inarca e si flette sul pianoforte quasi a possederlo, tende ad annullare le distanze della materia, in uno stato di possessione, attraverso la musica, simile e opposto a quello dei sufi. Nell’improvvisazione di Jarrett si usa il corpo per generare musica; nella danza cosmica dei dervisci la musica è la scala per l’estasi. In entrambi i casi si tratta di uscire di sé”. Da “il mio desiderio feroce”. Novembre 1994 – Prefazione di Carlo Maria Cella. ↑
13 “Chi guarda agli assoli di Jarrett come a semplici concerti-esibizione, senza nemmeno essere sfiorato dalla dimensione arcana del suo Ricercare – e intere generazioni di jazz fan l’ hanno fatto e ancora lo fanno – avverte con fastidio il corporale dell’improvvisazione di Jarrett. Il rock è venuto ad esaltarla come un ingrediente del grande rito voodoo, ma nella tradizione classica e ancora nel jazz, la fisicità è sempre vista come una colpa del suonare: i veri concertisti sono tenuti a reprimerla e anche gli invasati del sax sono preferiti se in grado di nasconderla”. Da “il mio desiderio feroce”. Novembre 1994 – Prefazione di Carlo Maria Cella. ↑
14 a tal proposito si leggano ad esempio le note interne di Changeless – ECM 1987. E’ nota, inoltre, la profonda conoscenza di Jarrett delle teorie filosofiche applicate alla musica di Georgei Ivanovic Gurdjieff (1872-1949). “… Un personaggio misterioso, un greco del Caucaso che fu il primo a parlare in Occidente della Quarta Via – un metodo eminentemente pratico per la conoscenza e lo sviluppo dell’essere umano attraverso un lavoro integrato sui suoi tre centri (fisico, emozionale e intellettuale) – e a fondare vicino Parigi, all’inizio degli anni ’20, un “Istituto per lo sviluppo armonico dell’uomo”, che ebbe poi delle diramazioni soprattutto negli Stati Uniti. Anche se, in effetti, i principi dell’insegnamento di Gurdjieff sono legati molto più all’esoterismo che alla filosofia New Age, le sue teorie sulla musica oggettiva rimangono molto interessanti nella prospettiva di recupero della dimensione spirituale della musica caratteristica della Nuova Era. Nel suo libro originalissimo ed appassionante “romanzo” I racconti di Belzebù al suo piccolo nipote (L’Ottava), Gurdjieff spiega che, sin dai tempi di Pitagora, la musica, come altre forme artistiche quali il teatro o la danza, veniva utilizzata da un gruppo di iniziati, gli “Aderenti al Legominismo”, per trasmettere la conoscenza attraverso messaggi sonori che gli iniziati del futuro avrebbero potuto decifrare. Tale musica, comunque, sarebbe stata in grado di provocare degli effetti oggettivi su qualsiasi ascoltatore. Si dice, infatti, che proprio Pitagora avesse inventato una musica capace di curare le malattie. E lo stesso Gurdjieff, in un altro suo romanzo autobiografico intitolato” Incontri con uomini straordinari” (Adelphi), racconta gli effetti della musica sugli uomini e su tutti gli esseri viventi. Gurdjieff era dunque convinto che la musica, attraverso le sue vibrazioni, producesse sugli uomini delle impressioni che agivano in qualche modo sulle vibrazioni energetiche dei nostri corpi non soltanto fisici. E lo dimostrò in diverse occasioni. Una volta, per esempio, riuscì a far cadere in trance una ragazza che aveva appena visto suonando un particolare accordo sulla tastiera del pianoforte…”. Tratto da “G.I. Gurdjieff e la musica oggettiva” – Giampiero Cara. ↑
15 si veda a tal proposito sempre “Invenzione e quotidianità per ritrovare un ruolo perduto” Musica Viva, Marzo 1982 – di Piero Rattalino. ↑
16 “Keith Jarrett: Europa , o cara….” Musica Jazz, 1982 – di Franco D’Andrea. ↑
17 Jarrett sembra infatti far riferimento, tra le altre, anche all’esperienza della “meditazione trascendentale”, sviluppata da discipline mistiche orientali (come Zen, Buddhismo, Tantra ecc.), che egli cerca in qualche modo di applicare alla musica che produce, in una sorta di personale e peculiare forma di misticismo. Questo genere di meditazione richiede principalmente lo svuotamento mentale prima di operare. Jarrett ritiene, proprio come i maestri illuminati d’Oriente, che la creatività non nasca dalla mente (“Non ho nemmeno un seme quando comincio. E’ come partire da zero”, afferma), ma dalla totalità della propria essenza, in un processo esistenziale di interscambio e trasformazione energetica. In pratica egli applica tecniche meditative, o stati di “non mente” nell’atto del suonare, tentando in tal modo di far sgorgare al meglio la creatività, utile in improvvisazione. Jarrett, nelle sue biografie od interviste, parla spesso di “svuotamento mentale” prima di un concerto e di interazione energetica tra lui e il pubblico in sala “necessaria” alla creazione della musica. Questa cosa, di comprensibile dubbia credibilità, potrebbe spiegare, oltre all’acclarato caratteraccio, anche certe sue premure prima dei concerti e l’attenzione che dedica ai flash dei fotografi e a quant’altro possa infastidirlo durante le sue esibizioni, suscitando le ire di vasti strati di pubblico. Per questa ragione a volte sospende il concerto quando viene disturbato e per questo spesso afferma che per la riuscita del concerto sono importanti le prime note che suona. Perlomeno da “Sunbear concerts” sino a “La Scala”, egli ha cominciato ad utilizzare a tappeto questo genere di approccio, tentandolo anche in dischi in trio come “Changeless” (con ancor superiori difficoltà, perché si deve essere in sintonia meditativa collettiva) e andando oltre l’approccio musicale più ortodosso ed usuale. Ecco perché nei suoi concerti si sentono quei momenti definibili come “statici” o “noiosi” in cui Jarrett ferma il pensiero musicale, iterando con approccio minimalista ritmo e note. Gli servono come mantra meditativo, per arrivare a creare nuova materia musicale che emerge successivamente. ↑
18 Prima di Jarrett c’è soprattutto il silenzio. Il silenzio è più importante della musica, e anche più potente, dice. Affermazione in apparenza sorprendente in un musicista che crede nella comunicazione, che si impone di muovere con un altamente formalizzato fare il suo e il nostro mondo di emozioni. Il silenzio è per lo più celebrato come un’assenza (di suoni, di note, di affermazioni). In musica, il silenzio più famoso – 4’33” di John Cage – entrò con passo rivelatosi presto tutt’altro che felpato. Celebrando nel 1951 il rito di un concerto non suonato, Cage sembrava alzare su un intero mondo musicale la lama del boia. Molti, in buona e malafede, presero l’abbaglio: 4’33” intendeva dichiarare la morte della tradizione, della musica eseguita ed interpretata, del passato, della Musica stessa. Il Silenzio di Cage era dunque provocatorio, rivoluzionario, giacobino, crudele, sadico, nichilista. Comunque laico. Dunque diametralmente opposto a tutto ciò cui Jarrett crede. Ma Cage faceva suonare un altro concerto dentro il concerto sospeso: quello della natura, nella quale l’assoluta assenza di suoni non esiste….Il Silenzio di Cage suonava la musica non scritta da nessuno e non suonata da alcuno strumento, ma che quando qualcuno scrive e uno strumento suona, continua a muoversi come voce sommersa nel contrappunto; mai fuori tonalità. Come tutti i veri rivoluzionari, Cage faceva filosofia in forma di musica. Con la stessa minimizzatrice nonchalance con cui Satie faceva musica a forma di pera. Come tutti i gesti davvero radicali, il Silenzio di Cage conteneva qualcosa di rivelatore, dunque di religioso. A ben vedere, nessun silenzio è laico. Da “il mio desiderio feroce”. Novembre 1994 – Prefazione di Carlo Maria Cella. ↑
19 Fin da Plotino la musica, più indicibile fra le emanazioni divine, ha meritato il posto più vicino a Dio. E mai l’ha perduto lungo la storia del pensiero. Nelle sue categorie dell’arte, Kant diede alla musica il gradino più alto, sempre perché la meno compromessa con le necessità e le miserie della materia. La musica è sempre stata arte prediletta dai filosofi, per il suo vivere nel tempo e direttamente nell’uomo, vibrando più a lungo nella memoria e più a fondo nella psiche. Schopenhauer, riprendendo Leibniz, diceva della musica: Un esercizio inconsapevole di metafisica, durante il quale lo spirito non sa che sta facendo filosofia. La musica parla dell’essere, dice ancora Schopenhauer, mentre altre arti ne rappresentano soltanto l’ombra”. Da “il mio desiderio feroce”. Novembre 1994 – Prefazione di Carlo Maria Cella. ↑
20 Da “il mio desiderio feroce”. Novembre 1994 – Prefazione di Carlo Maria Cella. ↑
21 Tratto dal mensile “Jazz” – Annata 1995. ↑
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Riceviamo & pubblichiamo: SF JAZZ C...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- Chiodi nella bara
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Wayne Shorter: il compositore
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz




