Oldies's Articles
 L’ottetto di David Murray è una delle espressioni più felici del jazz degli anni ’80. Superficialmente, persino una stranezza: Murray si era distinto per la sua militanza nel World Saxophone Quartet ed uno stile, almeno inizialmente, in linea con Archie Sheep e Albert Ayler. Il suo ottetto, forte di innovativi musicisti come George Lewis (trombone), Henry Threadgill (sax, flauto) e Butch Morris (cornetta) sembrava invece molto più “normale”. In realtà con questa formazione Murray ha potuto mettere in mostra tutto il suo talento di leader, compositore, arrangiatore… e storico. Se già in passato il sax di Murray era avanti guardando indietro (gli echi di Ben Webster e Paul Gonsalves sono sempre stati ben presenti nel suo modo di suonare), la cosa si fa ora più profonda e trasversale. (Continua a leggere)
L’ottetto di David Murray è una delle espressioni più felici del jazz degli anni ’80. Superficialmente, persino una stranezza: Murray si era distinto per la sua militanza nel World Saxophone Quartet ed uno stile, almeno inizialmente, in linea con Archie Sheep e Albert Ayler. Il suo ottetto, forte di innovativi musicisti come George Lewis (trombone), Henry Threadgill (sax, flauto) e Butch Morris (cornetta) sembrava invece molto più “normale”. In realtà con questa formazione Murray ha potuto mettere in mostra tutto il suo talento di leader, compositore, arrangiatore… e storico. Se già in passato il sax di Murray era avanti guardando indietro (gli echi di Ben Webster e Paul Gonsalves sono sempre stati ben presenti nel suo modo di suonare), la cosa si fa ora più profonda e trasversale. (Continua a leggere)
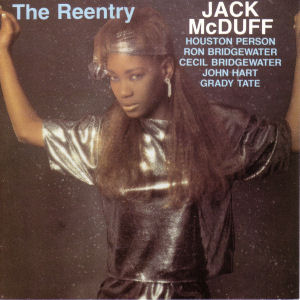
Di Jack McDuff è facilissimo ricordare la selva di classici sfornati su Prestige nei primi anni ’60 (ottimo ‘Brother Jack Meets The Boss’, in compagnia del grande Gene Ammons), che lo hanno consacrato come uno dei più importanti organisti soul jazz, dallo stile quadrato e innervato di blues. Il ripescaggio che andiamo a proporvi è decisamente meno noto e richiede un balzo in avanti di almeno 25 anni: è infatti il 1988 quando, dopo un periodo di assenza piuttosto prolungato (sorte in quel periodo comune a quasi tutti i campioni degli anni ’50 e ’60), “Brother” Jack decide di ribattezzarsi “Captain” e tornare sulle scene con un nuovo disco. La buona notizia è che ‘The Reentry’, programmaticamente intitolato, del periodo in cui esce non ha nulla, se non la produzione piuttosto cristallina (caratteristica peraltro comune a quasi tutte le produzioni della Muse, etichetta che patrocina questo nuovo capitolo): niente riferimenti fusion (genere a cui negli anni ’70 l’organista aveva strizzato l’occhio con risultati da dimenticare), niente tastiere plasticose, niente sassofoni smooth. (Continua a leggere)
 La figura di Duke Pearson è un’altra di quelle che ancora attendono la giusta rivalutazione critica. Pianista hard bop ineccepibile, dallo stile elegante ed essenziale figlio di Hank Jones e Teddy Wilson, ebbe anche un ruolo di eminenza grigia dietro a tanto jazz degli anni ’60, visto il suo incarico di a&r, produttore e orchestratore presso la Blue Note. Queste grandi qualità naturalmente si facevano sentire pure nei suoi dischi, in particolare quelli con formazioni allargate che gli permettevano di mettere in mostra il suo talento per la composizione e l’arrangiamento. ‘The Prairie Dog’ uscì su Atlantic, graziato da una magnifica copertina western che in realtà non si riflette granché nell’album, a parte il brano omonimo: se i “prairie dog” sono roditori simili a marmotte che abitano le praterie del nordamerdica, la title track è una fanfara blues indolente cui gli strumenti (contralto, tenore, chitarra) danno un appropriato colore country. (Continua a leggere)
La figura di Duke Pearson è un’altra di quelle che ancora attendono la giusta rivalutazione critica. Pianista hard bop ineccepibile, dallo stile elegante ed essenziale figlio di Hank Jones e Teddy Wilson, ebbe anche un ruolo di eminenza grigia dietro a tanto jazz degli anni ’60, visto il suo incarico di a&r, produttore e orchestratore presso la Blue Note. Queste grandi qualità naturalmente si facevano sentire pure nei suoi dischi, in particolare quelli con formazioni allargate che gli permettevano di mettere in mostra il suo talento per la composizione e l’arrangiamento. ‘The Prairie Dog’ uscì su Atlantic, graziato da una magnifica copertina western che in realtà non si riflette granché nell’album, a parte il brano omonimo: se i “prairie dog” sono roditori simili a marmotte che abitano le praterie del nordamerdica, la title track è una fanfara blues indolente cui gli strumenti (contralto, tenore, chitarra) danno un appropriato colore country. (Continua a leggere)
 Nella seconda metà degli anni ’50 le orchestre jazz sono una specie in via di estinzione, a causa degli alti cosi di mantenimento. Duke Ellington, forse l’unico, riesce a superare la crisi senza dover mai sciogliere la sua big band, mentre gli altri non furono così fortunati. Nemmeno Dizzy Gillespie, uno dei volti più noti e amati del jazz, innovatore tanto del linguaggio trombettistico come di quello orchestrale, e grande comunicatore. In attesa di momenti più propizi, Dizzy pensa ad una formazione estesa e chiama due dei più talentuosi compositori e arrangiatori per piccoli ensemble: Benny Golson e Gigi Gryce. Con altri due fiati (il baritono di Pee Wee Moore e il trombone di Henry Coker), una sezione ritmica swingante e compatta (Ray Bryant al piano, Tommy Bryant al basso e Charlie Persip alla batteria) e un repertorio di brani originali scritti dai due sassofonisti, l’ottetto dà vita ad una nuvola di suono vellutato, non dissimile dai coevi esperimenti di Gryce con Art Farmer e Donald Byrd. (Continua a leggere)
Nella seconda metà degli anni ’50 le orchestre jazz sono una specie in via di estinzione, a causa degli alti cosi di mantenimento. Duke Ellington, forse l’unico, riesce a superare la crisi senza dover mai sciogliere la sua big band, mentre gli altri non furono così fortunati. Nemmeno Dizzy Gillespie, uno dei volti più noti e amati del jazz, innovatore tanto del linguaggio trombettistico come di quello orchestrale, e grande comunicatore. In attesa di momenti più propizi, Dizzy pensa ad una formazione estesa e chiama due dei più talentuosi compositori e arrangiatori per piccoli ensemble: Benny Golson e Gigi Gryce. Con altri due fiati (il baritono di Pee Wee Moore e il trombone di Henry Coker), una sezione ritmica swingante e compatta (Ray Bryant al piano, Tommy Bryant al basso e Charlie Persip alla batteria) e un repertorio di brani originali scritti dai due sassofonisti, l’ottetto dà vita ad una nuvola di suono vellutato, non dissimile dai coevi esperimenti di Gryce con Art Farmer e Donald Byrd. (Continua a leggere)
CHARLES LLOYD – Forest Flower (1966, Atlantic)
 Si sono dette molte cose sul conto di Charles Lloyd, spesso nemmeno lusinghiere, prima fra tutte l’accusa di essere un furbacchione in cerca dei consensi del grande pubblico. Al secondo posto, quella di esser solo bravo a cercarsi i musicisti giusti e lasciar fare tutto a loro. La realtà, probabilmente, sta nel mezzo: di per sè, Lloyd è un personaggio marginale della storia del jazz, un epigono coltrane-iano senza troppa fantasia nè talento, più incline all’estetizzazione che altro, al pari di Pharoah Sanders. Detto questo, dobbiamo anche riconoscerne i centri, come questo album dal vivo registrato nel 1966 celebre al Monterey Jazz Festival. Al tempo la band di Lloyd (al tenore e al flauto) comprendeva i giovanissimi Cecil McBee (contrabbasso), Keith Jarrett (piano) e Jack DeJohnette (batteria), e nonostante fosse insieme da pochi mesi poteva vantare una compattezza invidiabile. (Continua a leggere)
Si sono dette molte cose sul conto di Charles Lloyd, spesso nemmeno lusinghiere, prima fra tutte l’accusa di essere un furbacchione in cerca dei consensi del grande pubblico. Al secondo posto, quella di esser solo bravo a cercarsi i musicisti giusti e lasciar fare tutto a loro. La realtà, probabilmente, sta nel mezzo: di per sè, Lloyd è un personaggio marginale della storia del jazz, un epigono coltrane-iano senza troppa fantasia nè talento, più incline all’estetizzazione che altro, al pari di Pharoah Sanders. Detto questo, dobbiamo anche riconoscerne i centri, come questo album dal vivo registrato nel 1966 celebre al Monterey Jazz Festival. Al tempo la band di Lloyd (al tenore e al flauto) comprendeva i giovanissimi Cecil McBee (contrabbasso), Keith Jarrett (piano) e Jack DeJohnette (batteria), e nonostante fosse insieme da pochi mesi poteva vantare una compattezza invidiabile. (Continua a leggere)
 “Ascoltai quello che mi sembrava un sax tenore. Il chitarrista lo vedevo ma non lo sentivo, chiesi dove fosse. Poi mi resi conto che quel suono, quella specie di sassofono, usciva da uno spartano amplificatore attaccato a una chitarra. Era la cosa più stupefacente che avessi mai sentito. Mi ispirò così tanto, tutto ciò che volevo fare era imitarlo”.
“Ascoltai quello che mi sembrava un sax tenore. Il chitarrista lo vedevo ma non lo sentivo, chiesi dove fosse. Poi mi resi conto che quel suono, quella specie di sassofono, usciva da uno spartano amplificatore attaccato a una chitarra. Era la cosa più stupefacente che avessi mai sentito. Mi ispirò così tanto, tutto ciò che volevo fare era imitarlo”.
Quel chitarrista era un Charlie Christian poco più che ventenne ricordato dalle parole di Mary Osborne, ragazza del North Dakota che quella sera del 1938 di anni ne aveva soltanto 17 e già da un po’ si cimentava con la chitarra, folgorata da Django Reinhardt. Proprio la comune passione per il chitarrista manouche si sarebbe rivelata base di una solida amicizia tra i due, con Christian che si trasformerà in una sorta di mentore per la ragazza, guidandola nell’acquisto della sua prima chitarra elettrica. Siamo in tempi assolutamente pionieristici: prima di loro due in ambito strettamente jazz l’unico ad aver già adottato un’innovazione di quel tipo era Eddie Durham con i Kansas City Six di Lester Young. (Continua a leggere)
 “Bags”, come sappiamo, è il nomignolo affibbiato a Jackson per via delle borse sotto gli occhi, una “bean bag” è una sacca riempita di fagioli secchi… chi sarà mai il “Bean” della situazione? Ma ovviamente Coleman Hawkins! Scemenze a parte, “Bean Bags” fa parte della lunga serie di album incisi da Milt Jackson su Atlantic. Accompagnati da una formazione deluxe (Tommy Flanagan al piano, Kenny Burrell alla chitarra, Eddie Jones al contrabbasso, Connie Kay alla batteria), Bean e Bags affrontano sei brani sovrapponendo due diverse generazioni di jazz. Hawkins e Jones infatti sono musicisti dell’era dello swing, mentre gli altri sono emersi negli anni del bebop: quello che ne esce fuori, se vogliamo, ricorda quel fertilissimo periodo di quindici anni prima in cui Coleman Hawkins stesso, alla guida di piccole formazioni composte da quei musicisti che di lì a poco avrebbero sconvolto le acque, innervava il classico di una tensione nuova. (Continua a leggere)
“Bags”, come sappiamo, è il nomignolo affibbiato a Jackson per via delle borse sotto gli occhi, una “bean bag” è una sacca riempita di fagioli secchi… chi sarà mai il “Bean” della situazione? Ma ovviamente Coleman Hawkins! Scemenze a parte, “Bean Bags” fa parte della lunga serie di album incisi da Milt Jackson su Atlantic. Accompagnati da una formazione deluxe (Tommy Flanagan al piano, Kenny Burrell alla chitarra, Eddie Jones al contrabbasso, Connie Kay alla batteria), Bean e Bags affrontano sei brani sovrapponendo due diverse generazioni di jazz. Hawkins e Jones infatti sono musicisti dell’era dello swing, mentre gli altri sono emersi negli anni del bebop: quello che ne esce fuori, se vogliamo, ricorda quel fertilissimo periodo di quindici anni prima in cui Coleman Hawkins stesso, alla guida di piccole formazioni composte da quei musicisti che di lì a poco avrebbero sconvolto le acque, innervava il classico di una tensione nuova. (Continua a leggere)
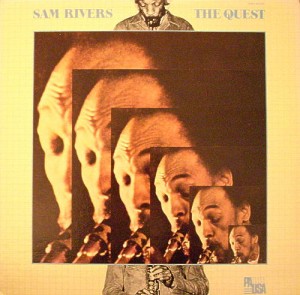
Quella di Barry Altschul e Dave Holland è una sezione ritmica straordinaria, di certo in grado di competere ad armi pari con tante coppie più “famose”. Oggi forse è meno celebrata del dovuto: aver legato il proprio nome soprattutto a formazioni di impostazione free jazz si è rivelato un grosso equivoco, a ben vedere. Altschul e Holland restano troppo grandi per poter essere incasellati in una sola nicchia, e infatti a cavallo tra ’60 e ‘70 sia in compagnia di Paul Bley (solo il batterista) che di Braxton o Corea (nel breve periodo in cui quest’ultimo formò i Circle, formazione con cui tentò di esplorare territori più o meno avanguardistici prima della ben più nota svolta fusion) hanno comunque dimostrato una versatilità che lasciava trasparire una conoscenza del panorama jazzistico a 360 gradi. (Continua a leggere)
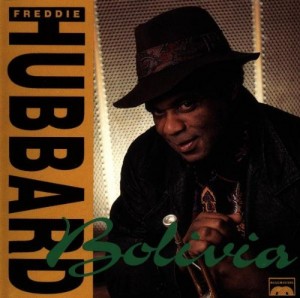
Di recente, in occasione del nuovo, ottimo album di Etienne Charles, parlavamo del solido legame che unisce il jazz con i luoghi e le sonorità dell’America centro-meridionale. Una parentela dalle origini antiche (basti citare il caso forse più famoso, Dizzy Gillespie, che abbeverandosi a quelle fonti ha prodotto alcuni dei migliori episodi della sua sterminata carriera) e che ancora oggi perdura con immutata efficacia grazie alle intuizioni di musicisti come James Carter o lo stesso Charles. Tra coloro che nel tempo hanno strizzato l’occhio alle sonorità caraibiche, quello di Freddie Hubbard non è tuttavia il primo nome a venire in mente. Anzi, nemmeno il secondo o il terzo. Lo si può identificare coi suoi capolavori su Blue Note, con la svolta più “facile” (e assai meno riuscita) verso territori soul/funk, finanche con una manciata di dischi piuttosto sperimentali per i suoi canoni (l’ottimo ‘Red Clay’, da riscoprire), eppure, per quanto trascurato, in certe zone geografico-musicali ci è passato anche lui. Con ottimi risultati, per giunta. (Continua a leggere)
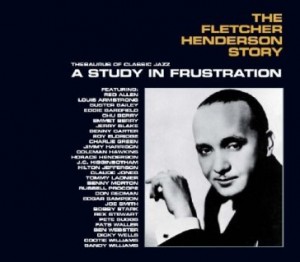 Se esiste il jazz per orchestra lo dobbiamo innanzitutto a Fletcher Henderson, pianista e caporchestra che assemblò e diresse per primo una compagine jazzistica estesa – che è cosa ben diversa dalle dance band di musicisti come Paul Whiteman. Henderson poteva contare su strumentisti di grande valore, fra cui Don Redman, sassofonista, clarinettista e soprattutto arrangiatore di genio. Fu proprio Redman a dare una fisionomia definitiva all’orchestra jazz, con arrangiamenti scritti che lasciavano comunque spazio all’improvvisazione dei solisti, e ad elaborare un suono complessivo che usciva dalla combinazione di sezioni (trombe, tromboni, sassofoni, clarinetti), a volte amalgamate, a volte impegnate in botta e risposta, spesso alle prese con iridescenti tappeti sonori in funzione del solista di turno. (Continua a leggere)
Se esiste il jazz per orchestra lo dobbiamo innanzitutto a Fletcher Henderson, pianista e caporchestra che assemblò e diresse per primo una compagine jazzistica estesa – che è cosa ben diversa dalle dance band di musicisti come Paul Whiteman. Henderson poteva contare su strumentisti di grande valore, fra cui Don Redman, sassofonista, clarinettista e soprattutto arrangiatore di genio. Fu proprio Redman a dare una fisionomia definitiva all’orchestra jazz, con arrangiamenti scritti che lasciavano comunque spazio all’improvvisazione dei solisti, e ad elaborare un suono complessivo che usciva dalla combinazione di sezioni (trombe, tromboni, sassofoni, clarinetti), a volte amalgamate, a volte impegnate in botta e risposta, spesso alle prese con iridescenti tappeti sonori in funzione del solista di turno. (Continua a leggere)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- Chiodi nella bara
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Wayne Shorter: il compositore
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz
