Oldies's Articles
Uno dei cliché critici su Duke Ellington comunemente accettati, recita che egli debba fondamentalmente la sua fortuna e eccezionale fertilità compositiva, senza pari nella storia del jazz, alla intima condivisione artistica e musicale con Billy Strayhorn, che data dal 1938 sino alla sua morte avvenuta nel 1967. In realtà, la cosa è molto più discutibile di quanto non appaia in prima istanza, in quanto, se si va ad indagare meglio, si scopre che, sia prima dell’avvento di Strayhorn in orchestra, che dopo quel lungo intervallo di tempo, Ellington ha scritto decine di composizioni capolavoro. Di più, oserei dire che gli ultimi anni, in particolare, hanno mostrato un Ellington ancora in eccezionale vena creativa, in grado di sfornare una serie di pagine a largo respiro che sono considerabili tra i massimi capolavori della sua discografia e, conseguentemente, dell’intero jazz. (Continua a leggere)
 In un periodo nel quale stenta a proporsi sulla scena contemporanea abbondanza di figure carismatiche, perlomeno se paragonata a quella dei jazzisti delle generazioni precedenti, ho scelto di riproporre questo disco omonimo di Michael Brecker, il suo primo da leader, inciso alla matura età di 38 anni, per omaggiare e non dimenticare un grande tenorsassofonista, scomparso peraltro prematuramente da soli otto anni, tra i più influenti e significativi del post-coltranismo. Eppure Brecker non ha mai goduto di buonissima stampa da parte della nostra critica specializzata, da sempre alla ricerca smaniosa del musicista innovatore sul piano formale e strutturale (per quel che mi riguarda il preambolo formale applicato come criterio generale di valutazione in ambito jazzistico, continuo a trovarlo discutibile, se non in diversi casi persino fuorviante) e poco attenta all’aspetto della forza espressiva, che è da sempre invece la peculiare caratteristica di quella musica improvvisata che da ormai oltre un secolo di nome fa “Jazz”. (Continua a leggere)
In un periodo nel quale stenta a proporsi sulla scena contemporanea abbondanza di figure carismatiche, perlomeno se paragonata a quella dei jazzisti delle generazioni precedenti, ho scelto di riproporre questo disco omonimo di Michael Brecker, il suo primo da leader, inciso alla matura età di 38 anni, per omaggiare e non dimenticare un grande tenorsassofonista, scomparso peraltro prematuramente da soli otto anni, tra i più influenti e significativi del post-coltranismo. Eppure Brecker non ha mai goduto di buonissima stampa da parte della nostra critica specializzata, da sempre alla ricerca smaniosa del musicista innovatore sul piano formale e strutturale (per quel che mi riguarda il preambolo formale applicato come criterio generale di valutazione in ambito jazzistico, continuo a trovarlo discutibile, se non in diversi casi persino fuorviante) e poco attenta all’aspetto della forza espressiva, che è da sempre invece la peculiare caratteristica di quella musica improvvisata che da ormai oltre un secolo di nome fa “Jazz”. (Continua a leggere)
 In un periodo storico nel quale, specie in Europa, sembra prevalere nella musica improvvisata una deriva verso un progressivo allontanamento da certe peculiarità africane-americane proprie del jazz, almeno per come molti di noi lo hanno conosciuto ed imparato ad amare nel secolo scorso, si assiste oggi sempre più spesso in tale ambito ad una sorta di sublimazione delle componenti ritmiche e poliritmiche, in favore di proposte che puntano più ad un utilizzo coloristico e timbrico degli strumenti ritmici (in particolare della batteria) sottraendoli dagli usuali compiti di scansione. Proprio per tale ragione e in un certo senso in contrapposizione a tale tendenza, ho scelto di riproporre all’attenzione questo album di Sonny Rollins del 1966 che, pur non essendo tra i suoi più citati è in realtà un suo sottostimato capolavoro, ed è, a mio avviso, quanto mai esemplificativo in termini musicali del concetto che così sommariamente ho tentato di esporre. (Continua a leggere)
In un periodo storico nel quale, specie in Europa, sembra prevalere nella musica improvvisata una deriva verso un progressivo allontanamento da certe peculiarità africane-americane proprie del jazz, almeno per come molti di noi lo hanno conosciuto ed imparato ad amare nel secolo scorso, si assiste oggi sempre più spesso in tale ambito ad una sorta di sublimazione delle componenti ritmiche e poliritmiche, in favore di proposte che puntano più ad un utilizzo coloristico e timbrico degli strumenti ritmici (in particolare della batteria) sottraendoli dagli usuali compiti di scansione. Proprio per tale ragione e in un certo senso in contrapposizione a tale tendenza, ho scelto di riproporre all’attenzione questo album di Sonny Rollins del 1966 che, pur non essendo tra i suoi più citati è in realtà un suo sottostimato capolavoro, ed è, a mio avviso, quanto mai esemplificativo in termini musicali del concetto che così sommariamente ho tentato di esporre. (Continua a leggere)
SWAY – Sway (1973, Cipiti/Markuee)
 Nello scenario italiano degli anni ’70 si muovevano pure gli Sway, formazione capitanata dal bravo Sante Palumbo (piano e piano elettrico) che esplorava alcune delle sonorità jazz più popolari del tempo con umiltà e passione, senza timori riverenziali. Assime a lui troviamo il contrabbassista Marco Ratti, il batterista Lino Liguori, il chitarrista Sergio Farina e il sassofonista/flautista argentino Hugo Heredia; nel loro primo e unico disco, uscito originariamente per la microscopica Cipiti e solo recentemente ristampato da Markuee, gli Sway incrociano il linguaggio del jazz elettrico con quello di certo rock progressivo, genere popolarissimo in Italia su cui si sono formati centinaia di musicisti. (Continua a leggere)
Nello scenario italiano degli anni ’70 si muovevano pure gli Sway, formazione capitanata dal bravo Sante Palumbo (piano e piano elettrico) che esplorava alcune delle sonorità jazz più popolari del tempo con umiltà e passione, senza timori riverenziali. Assime a lui troviamo il contrabbassista Marco Ratti, il batterista Lino Liguori, il chitarrista Sergio Farina e il sassofonista/flautista argentino Hugo Heredia; nel loro primo e unico disco, uscito originariamente per la microscopica Cipiti e solo recentemente ristampato da Markuee, gli Sway incrociano il linguaggio del jazz elettrico con quello di certo rock progressivo, genere popolarissimo in Italia su cui si sono formati centinaia di musicisti. (Continua a leggere)
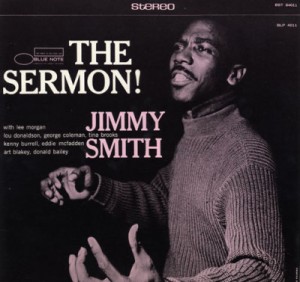 L’organo hammond nacque negli anni ’30 come sostituto economico dell’organo a canne e si diffuse rapidamente nelle chiese degli Stati Uniti. Da lì passò rapidamente all’arcipelago della musica nera, jazz incluso – pezzi grossi come Fats Waller e Count Basie lo utilizzarono di quando in quando, mentre Wild Bill Davis ne fu il primo specialista col suo trio chitarra-hammond-batteria. Ma se c’è un nome che più di ogni altro ha popolarizzato lo strumento, estendendone tecnica e vocabolario oltre il pensabile, quello è Jimmy Smith. Grazie a lui, l’hammond divenne uno strumento solista alla pari dei fiati, e con un inedito uso dei pedali poteva sostituire il classico walkin’ bass. (Continua a leggere)
L’organo hammond nacque negli anni ’30 come sostituto economico dell’organo a canne e si diffuse rapidamente nelle chiese degli Stati Uniti. Da lì passò rapidamente all’arcipelago della musica nera, jazz incluso – pezzi grossi come Fats Waller e Count Basie lo utilizzarono di quando in quando, mentre Wild Bill Davis ne fu il primo specialista col suo trio chitarra-hammond-batteria. Ma se c’è un nome che più di ogni altro ha popolarizzato lo strumento, estendendone tecnica e vocabolario oltre il pensabile, quello è Jimmy Smith. Grazie a lui, l’hammond divenne uno strumento solista alla pari dei fiati, e con un inedito uso dei pedali poteva sostituire il classico walkin’ bass. (Continua a leggere)
 Fra il 1958 e il 1963, Wes Montgomery incise una memorabile serie di album su Riverside (diciotto, da leader e non), per passare poi alla Verve. ‘So Much Guitar!’, del 1961, è solo uno dei capitoli di questo fortunato e prolifico periodo della carriera del chitarrista, all’epoca il più influente e innovativo. L’idea di Orrin Keepnews, produttore delle sessioni, era semplice: mandare in studio Wes con grandi sezioni ritmiche e una scelta di materiale in grado di mettere in risalto tutte le sue doti. In ‘So Much Guitar!’ troviamo il piano, più bluesy e percussivo del solito, del grande Hank Jones, un giovanissimo Ron Carter e la batteria di Lex Humphries, quasi tutta sui piatti; le percussioni di Ray Barretto aggiungono un taglio latino quasi subliminale. (Continua a leggere)
Fra il 1958 e il 1963, Wes Montgomery incise una memorabile serie di album su Riverside (diciotto, da leader e non), per passare poi alla Verve. ‘So Much Guitar!’, del 1961, è solo uno dei capitoli di questo fortunato e prolifico periodo della carriera del chitarrista, all’epoca il più influente e innovativo. L’idea di Orrin Keepnews, produttore delle sessioni, era semplice: mandare in studio Wes con grandi sezioni ritmiche e una scelta di materiale in grado di mettere in risalto tutte le sue doti. In ‘So Much Guitar!’ troviamo il piano, più bluesy e percussivo del solito, del grande Hank Jones, un giovanissimo Ron Carter e la batteria di Lex Humphries, quasi tutta sui piatti; le percussioni di Ray Barretto aggiungono un taglio latino quasi subliminale. (Continua a leggere)
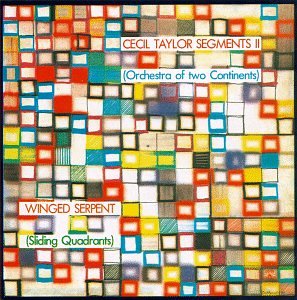 Nella sua lunghissima carriera, Cecil Taylor ha diretto formazioni di tutti i tipi, dal piano solo all’orchestra. Sempre sotto il segno radicale dell’iconoclastia, a volta fin troppo calcata quando non fine a sè stessa, in ogni caso mai banale. ‘Winged Serpent’ vede Taylor alla guida della Orchestra Of Two Continents, ovvero undici elementi proveniente da entrambi i lati dell’Atlantico. Troviamo gli americani Jimmy Lyons (contralto), Frank Wright (tenore), Karen Borca (fagotto), William Parker (contrabbasso), Andre Martined e Rashied Bakr (batteria), e gli europei John Tchicai (tenore), Enrico Rava e Tomas Stànko (tromba), e Gunter Hampel (baritono e clarone). Una simile bocca di fuoco viene utilizzata in ricche tessiture di fiati ed estatici crescendo che culminano in improvvisazioni collettive, spesso e volentieri caotiche, stridenti, ancorate a terra da ostinati di basso o dalla pulsazione suggerita da un pianoforte invasivo e martellante. (Continua a leggere)
Nella sua lunghissima carriera, Cecil Taylor ha diretto formazioni di tutti i tipi, dal piano solo all’orchestra. Sempre sotto il segno radicale dell’iconoclastia, a volta fin troppo calcata quando non fine a sè stessa, in ogni caso mai banale. ‘Winged Serpent’ vede Taylor alla guida della Orchestra Of Two Continents, ovvero undici elementi proveniente da entrambi i lati dell’Atlantico. Troviamo gli americani Jimmy Lyons (contralto), Frank Wright (tenore), Karen Borca (fagotto), William Parker (contrabbasso), Andre Martined e Rashied Bakr (batteria), e gli europei John Tchicai (tenore), Enrico Rava e Tomas Stànko (tromba), e Gunter Hampel (baritono e clarone). Una simile bocca di fuoco viene utilizzata in ricche tessiture di fiati ed estatici crescendo che culminano in improvvisazioni collettive, spesso e volentieri caotiche, stridenti, ancorate a terra da ostinati di basso o dalla pulsazione suggerita da un pianoforte invasivo e martellante. (Continua a leggere)
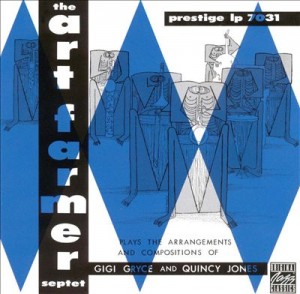 Queste incisioni rappresentano l’inizio della carriera da leader di Art Farmer, che fino a quel momento aveva suonato presso vari altri musicisti, non ultimo Lionel Hampton, che lo schierava nella sezione delle trombe assieme a Clifford Brown e Quincy Jones. Proprio quest’ultimo sarà il braccio destro del buon Art nella prima incisione a suo nome, per la Prestige nel 1953. Si tratta di quattro brani in settetto dove Jones siede al pianoforte e si occupa degli arrangiamenti, mentre l’anno successivo un altro settetto, forte della penna di Gigi Gryce, ne inciderà altri quattro. In entrambe le sessioni si avverte l’influenza del ‘Birth Of The Cool’ di Miles Davis: registri alti (tromba, tenore) e gravi (sax baritono, trombone) in combinazioni dal suono leggero e arioso, con in più un colore complessivo scuro che fa risaltare la tromba sobria ed elegantissima di Art Farmer. (Continua a leggere)
Queste incisioni rappresentano l’inizio della carriera da leader di Art Farmer, che fino a quel momento aveva suonato presso vari altri musicisti, non ultimo Lionel Hampton, che lo schierava nella sezione delle trombe assieme a Clifford Brown e Quincy Jones. Proprio quest’ultimo sarà il braccio destro del buon Art nella prima incisione a suo nome, per la Prestige nel 1953. Si tratta di quattro brani in settetto dove Jones siede al pianoforte e si occupa degli arrangiamenti, mentre l’anno successivo un altro settetto, forte della penna di Gigi Gryce, ne inciderà altri quattro. In entrambe le sessioni si avverte l’influenza del ‘Birth Of The Cool’ di Miles Davis: registri alti (tromba, tenore) e gravi (sax baritono, trombone) in combinazioni dal suono leggero e arioso, con in più un colore complessivo scuro che fa risaltare la tromba sobria ed elegantissima di Art Farmer. (Continua a leggere)
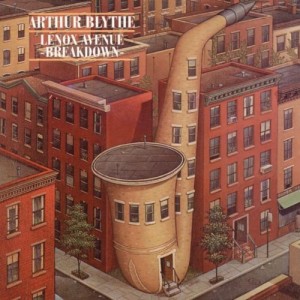 Quando il sassofonista Arthur Blythe incide ‘Lenox Avenue Breakdown’ ha trentasette anni e un lungo apprendistato alle spalle: ha suonato con Horace Tapscott, Chico Hamilton e Gil Evans e ha già pubblicato due dischi a suo nome. In entrambi si mette in mostra come musicista avventuroso, per certi versi iconoclasta, ma lontano da qualsiasi forma di ermetismo. Emerge soprattutto l’intenzione di rileggere in chiave originale forme e repertorio della tradizione jazzistica, come già stavano facendo musicisti come Henry Threadgill, David Murray Julius Hemphill e Lester Bowie. In ‘Lenox Avenue Breakdown’, Blythe si pone l’obiettivo di dare una rappresentazione musicale di tutta la ricchezza sonora di Harlem (Lenox Avenue è la via principale del quartiere newyorkese) con un organico strumentale inconsueto: il flauto di James Newton in frontline, la chitarra di James Blood Ulmer, la tuba di Bob Stewart, una sezione ritmica deluxe formata da Cecil McBee e Jack DeJohnette. (Continua a leggere)
Quando il sassofonista Arthur Blythe incide ‘Lenox Avenue Breakdown’ ha trentasette anni e un lungo apprendistato alle spalle: ha suonato con Horace Tapscott, Chico Hamilton e Gil Evans e ha già pubblicato due dischi a suo nome. In entrambi si mette in mostra come musicista avventuroso, per certi versi iconoclasta, ma lontano da qualsiasi forma di ermetismo. Emerge soprattutto l’intenzione di rileggere in chiave originale forme e repertorio della tradizione jazzistica, come già stavano facendo musicisti come Henry Threadgill, David Murray Julius Hemphill e Lester Bowie. In ‘Lenox Avenue Breakdown’, Blythe si pone l’obiettivo di dare una rappresentazione musicale di tutta la ricchezza sonora di Harlem (Lenox Avenue è la via principale del quartiere newyorkese) con un organico strumentale inconsueto: il flauto di James Newton in frontline, la chitarra di James Blood Ulmer, la tuba di Bob Stewart, una sezione ritmica deluxe formata da Cecil McBee e Jack DeJohnette. (Continua a leggere)
 Cosa mi affascina del Ganelin trio… Forse il ricordo di quando da giovane mi avvicinai a questa musica: la ricerca dei dischi, delle riviste e dei libri dei quali sentivi parlare. Eravamo un piccolo gruppo di carbonari, quei pochi, almeno dalle mie parti, che parlavano di jazz. Lo stesso si può dire di questo gruppo: il jazz arrivava dall’America, tutt’al più dall’Inghilterra, chi poteva immaginare che oltre la cortina di ferro ci fossero dei musicisti come loro? La loro qualità emergeva già nei primi dischi prodotti e registrati dall’etichetta di stato Meloydia, rimasti introvabili per anni e poi grazie anche a Ebay e alla caduta del muro diventati di più facile reperibilità, e se non fosse stato per l’imperfezioni dei vinili forse sarebbero di spessore ancora maggiore di questo disco. (Continua a leggere)
Cosa mi affascina del Ganelin trio… Forse il ricordo di quando da giovane mi avvicinai a questa musica: la ricerca dei dischi, delle riviste e dei libri dei quali sentivi parlare. Eravamo un piccolo gruppo di carbonari, quei pochi, almeno dalle mie parti, che parlavano di jazz. Lo stesso si può dire di questo gruppo: il jazz arrivava dall’America, tutt’al più dall’Inghilterra, chi poteva immaginare che oltre la cortina di ferro ci fossero dei musicisti come loro? La loro qualità emergeva già nei primi dischi prodotti e registrati dall’etichetta di stato Meloydia, rimasti introvabili per anni e poi grazie anche a Ebay e alla caduta del muro diventati di più facile reperibilità, e se non fosse stato per l’imperfezioni dei vinili forse sarebbero di spessore ancora maggiore di questo disco. (Continua a leggere)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- Chiodi nella bara
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Wayne Shorter: il compositore
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz

