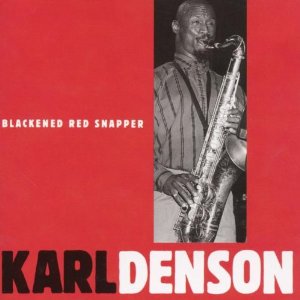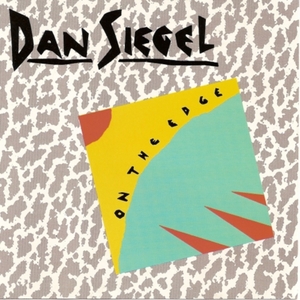Cut Out Bin's Articles
 Blix. Così si chiama il trombonista leader del quartetto norvegese che in questo lavoro dà prova di notevole compattezza, bellissimo sound e creatività. L’album (‘Texas’), pubblicato nel 1998 per la Nor-CD, alterna brevi improvvisazioni libere a brani maggiormente strutturati, e in entrambe le dimensioni i risultati sono eccellenti.
Blix. Così si chiama il trombonista leader del quartetto norvegese che in questo lavoro dà prova di notevole compattezza, bellissimo sound e creatività. L’album (‘Texas’), pubblicato nel 1998 per la Nor-CD, alterna brevi improvvisazioni libere a brani maggiormente strutturati, e in entrambe le dimensioni i risultati sono eccellenti.
Le composizioni, la maggioranza a firma del chitarrista Nils-Olav Johansen, soddisfano appieno l’anima rockettara che si nasconde in ognuno di noi; sempre piene di sorprese e suonate con energia, intricate ed intriganti, a volte basate su interessanti stratificazioni melodico/ritmiche (rimandano facilmente alle “forme verticali” di George Russell che – guarda un po’! – visse e lavorò anche nei paesi scandinavi).
Un’atmosfera entusiasmante avvolge la musica della Blix Band e bisogna darne il merito a tutti: contrabbasso (ottimo suono, naturale e diretto) e batteria valorizzano tutto (ma proprio tutto) con grande gusto, belli anche gli interventi dell’ospite Didrik Ingvaldsen alla tromba. I due solisti hanno stili affatto differenti: ad una chitarra virtuosa speziata di funky si accosta lo stile sintetico del trombone di Blix. Astratto e gestuale, Blix suona solo lo stretto necessario… ed è una grande dote. Io quando lo ascolto mi emoziono e per questo vivamente lo consiglio. (Carlo Cimino)
LEE AARON & THE SWINGIN BARFLIES (a.k.a. Come rifarsi una verginità e dimenticare i capelli cotonati)
 Dopo la decade degli ’80 vissuta da Metal Queen, la popolarità della canadese Lee Aaron è colata a picco al volgere del nuovo decennio, e con lei quella di molte altre stelle del rock duro, ormai rimpiazzate da Seattle e dintorni. Sarebbe più che lecito chiedersi perché parliamo di tutto ciò in questa sede, e infatti sono ben pochi a conoscere il seguito della storia: dopo aver fondato i 2Precious, con i quali prova (senza successo) a cavalcare l’onda di popolarità del rock alternativo con un disco scialbetto (poi ristampato a suo nome), agli albori del nuovo millennio la nostra cambia di nuovo pelle, proponendosi, ebbene sì, in un contesto jazz. Facile che i maligni pensino all’ennesimo tentativo di risollevare una carriera ormai ristagnante (e in parte è senz’altro così), ma la svolta stupisce solo fino a un certo punto: i più attenti ricorderanno certamente come la Aaron, anche nei giorni a base di metallo e cotonature, non abbia mai fatto mistero di essere cresciuta ascoltando e cercando di emulare le grandi voci del jazz, una passione a quanto pare mai sopita. (Continua a leggere)
Dopo la decade degli ’80 vissuta da Metal Queen, la popolarità della canadese Lee Aaron è colata a picco al volgere del nuovo decennio, e con lei quella di molte altre stelle del rock duro, ormai rimpiazzate da Seattle e dintorni. Sarebbe più che lecito chiedersi perché parliamo di tutto ciò in questa sede, e infatti sono ben pochi a conoscere il seguito della storia: dopo aver fondato i 2Precious, con i quali prova (senza successo) a cavalcare l’onda di popolarità del rock alternativo con un disco scialbetto (poi ristampato a suo nome), agli albori del nuovo millennio la nostra cambia di nuovo pelle, proponendosi, ebbene sì, in un contesto jazz. Facile che i maligni pensino all’ennesimo tentativo di risollevare una carriera ormai ristagnante (e in parte è senz’altro così), ma la svolta stupisce solo fino a un certo punto: i più attenti ricorderanno certamente come la Aaron, anche nei giorni a base di metallo e cotonature, non abbia mai fatto mistero di essere cresciuta ascoltando e cercando di emulare le grandi voci del jazz, una passione a quanto pare mai sopita. (Continua a leggere)
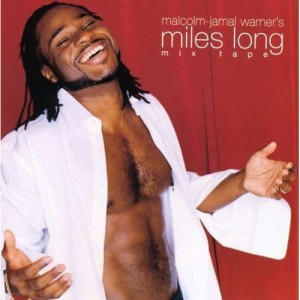 ‘L’album dei Robinson’ è il titolo con cui, mi pare, a metà degli anni ’90 venivano trasmesse in TV le repliche del ben noto telefilm di Bill Cosby. L’album che interessa a noi, però, è qualcosa di più letterale: un disco vero. Che la serie avesse un legame particolare col jazz è risaputo: guest star come Dizzy Gillespie e Nancy Wilson, riferimenti plurimi nelle trame di numerosi episodi, per non parlare della sigla dell’ultima stagione, interpretata da Lester Bowie. Le premesse sarebbero persino buone, resta però un fatto quasi incontestabile: ogni volta che un personaggio più o meno noto, sia esso un attore, uno sportivo o quel che volete, si gioca la carta della musica, i risultati sono da hall of shame. L’elenco è lungo e agghiacciante: da Brian Austin Green (il David di Beverly Hills 90210) e Macho Man Randy Savage che giocano a fare i rapper, al tremebondo pop-rock latino di Abel Balbo, fino ad arrivare al re dei re, l’immarcescibile David Hasselhoff. Ci fermiamo qui per non sconfinare troppo, ma vi basti sapere che scavare in acque ancor più torbide è possibile. (Continua a leggere)
‘L’album dei Robinson’ è il titolo con cui, mi pare, a metà degli anni ’90 venivano trasmesse in TV le repliche del ben noto telefilm di Bill Cosby. L’album che interessa a noi, però, è qualcosa di più letterale: un disco vero. Che la serie avesse un legame particolare col jazz è risaputo: guest star come Dizzy Gillespie e Nancy Wilson, riferimenti plurimi nelle trame di numerosi episodi, per non parlare della sigla dell’ultima stagione, interpretata da Lester Bowie. Le premesse sarebbero persino buone, resta però un fatto quasi incontestabile: ogni volta che un personaggio più o meno noto, sia esso un attore, uno sportivo o quel che volete, si gioca la carta della musica, i risultati sono da hall of shame. L’elenco è lungo e agghiacciante: da Brian Austin Green (il David di Beverly Hills 90210) e Macho Man Randy Savage che giocano a fare i rapper, al tremebondo pop-rock latino di Abel Balbo, fino ad arrivare al re dei re, l’immarcescibile David Hasselhoff. Ci fermiamo qui per non sconfinare troppo, ma vi basti sapere che scavare in acque ancor più torbide è possibile. (Continua a leggere)
RON HOLLOWAY – Slanted (1993, Milestone)
 Se ‘Slanted’ fosse uscito da un sax qualunque, probabilmente le critiche, anche superficiali, non sarebbero mancate: scarsa originalità, poca inventiva, suoni datati… A Ron Holloway, però, che gli vuoi dire? Non che il nome in copertina cambi i contenuti, ma calato nel suo giusto contesto questo disco assume un’identità più che significativa: quella dell’emozionante atto d’amore. Già, perché Ron è cresciuto in una casa di Washintgon D.C. nutrendosi con passione della collezione di dischi di suo padre (40 anni di vinile immarcescibilmente affastellati e una smodata attrazione per le ance), una dedizione che lo ha portato ad imbracciare egli stesso un sax tenore e trascorrere intere giornate estive sigillato in casa cercando di emulare idoli vecchi e nuovi. ‘Slanted’ è il primo passo da leader dopo circa tre lustri di carriera assai variegata, che lo vedono passare con nonchalance dalla straripante miscela rock/funk/r&b del fattone Root Boy Slim a Gil Scott-Heron fino alla corte di Dizzy Gillespie, del cui ultimo quintetto sarà colonna portante. Prima di guardare avanti (cosa che gli riuscirà abbastanza bene con ‘Struttin’’, di due anni successivo), Ron sente il bisogno di dedicarsi, finalmente in libertà, al suono che ha sempre amato e che in precedenza ha potuto assaporare solo a sprazzi, per giunta da sideman. (Continua a leggere)
Se ‘Slanted’ fosse uscito da un sax qualunque, probabilmente le critiche, anche superficiali, non sarebbero mancate: scarsa originalità, poca inventiva, suoni datati… A Ron Holloway, però, che gli vuoi dire? Non che il nome in copertina cambi i contenuti, ma calato nel suo giusto contesto questo disco assume un’identità più che significativa: quella dell’emozionante atto d’amore. Già, perché Ron è cresciuto in una casa di Washintgon D.C. nutrendosi con passione della collezione di dischi di suo padre (40 anni di vinile immarcescibilmente affastellati e una smodata attrazione per le ance), una dedizione che lo ha portato ad imbracciare egli stesso un sax tenore e trascorrere intere giornate estive sigillato in casa cercando di emulare idoli vecchi e nuovi. ‘Slanted’ è il primo passo da leader dopo circa tre lustri di carriera assai variegata, che lo vedono passare con nonchalance dalla straripante miscela rock/funk/r&b del fattone Root Boy Slim a Gil Scott-Heron fino alla corte di Dizzy Gillespie, del cui ultimo quintetto sarà colonna portante. Prima di guardare avanti (cosa che gli riuscirà abbastanza bene con ‘Struttin’’, di due anni successivo), Ron sente il bisogno di dedicarsi, finalmente in libertà, al suono che ha sempre amato e che in precedenza ha potuto assaporare solo a sprazzi, per giunta da sideman. (Continua a leggere)
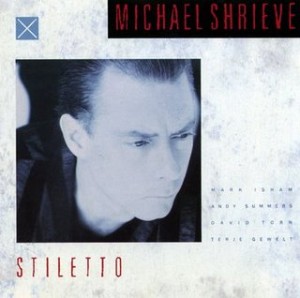 Michael Shrieve ha suonato con Neal Schon e Sammy Hagar nel progetto H.S.A.S.. È stato anche il batterista di Santana, ma forse all’epoca (quella in cui mi sono imbattuto in questo disco) non lo sapevo. Ad ogni modo, si tratta di referenze che oggi forse sarebbero più che sufficienti a non farmi comprare un disco; tanti anni fa però (credo fosse il 1997, a occhio e croce) furono abbastanza per convincermi a investire qualche migliaia di lire nell’audiocassetta (rigorosamente cut out, il CD purtroppo non c’era) di ‘Stiletto’. Dopo un primo ascolto concluso con un emblematico “ma le chitarre elettriche le ha dimenticate a casa?” (non sono cose belle da rivelare, ma almeno apprezzate l’onestà) di polvere ne prese tanta. Le chitarre elettriche, a dirla tutta, c’erano pure (a cura di Andy Summers per giunta), ma da uno che aveva comprato il disco (cioè, la cassetta) grazie a Neal Schon e Sammy Hagar (idolo, non fraintendete) cosa pretendere? Ci volle qualche mese, forse più, per riprendere quel nastro e, pian piano, iniziare ad “entrarci”. (Continua a leggere)
Michael Shrieve ha suonato con Neal Schon e Sammy Hagar nel progetto H.S.A.S.. È stato anche il batterista di Santana, ma forse all’epoca (quella in cui mi sono imbattuto in questo disco) non lo sapevo. Ad ogni modo, si tratta di referenze che oggi forse sarebbero più che sufficienti a non farmi comprare un disco; tanti anni fa però (credo fosse il 1997, a occhio e croce) furono abbastanza per convincermi a investire qualche migliaia di lire nell’audiocassetta (rigorosamente cut out, il CD purtroppo non c’era) di ‘Stiletto’. Dopo un primo ascolto concluso con un emblematico “ma le chitarre elettriche le ha dimenticate a casa?” (non sono cose belle da rivelare, ma almeno apprezzate l’onestà) di polvere ne prese tanta. Le chitarre elettriche, a dirla tutta, c’erano pure (a cura di Andy Summers per giunta), ma da uno che aveva comprato il disco (cioè, la cassetta) grazie a Neal Schon e Sammy Hagar (idolo, non fraintendete) cosa pretendere? Ci volle qualche mese, forse più, per riprendere quel nastro e, pian piano, iniziare ad “entrarci”. (Continua a leggere)
Qualunque consumatore abituale di musica potrà confermarlo senza problemi: comprare un disco a scatola chiusa è un’azione che implica una serie di variabili perversamente affascinanti. Io, chiaramente, non faccio eccezione e anzi, mi metto in cima alla lista. Un giorno, per esempio, durante il periodico spulciare presso un negozio in cui mi servo, passò davanti ai miei occhi la copertina di ‘Blackened Red Snapper’: “È il tizio che suonava con Lenny Kravitz”, dissi tra me (perché prima che la senilità precoce s’impossessasse di lui, Lenny Kravitz era persino bravo). Neanche il tempo di finire il pensiero che già ero immerso per l’ennesima volta nel solito, amletico dubbio: comprarlo o lasciarlo lì? A convincermi ci pensarono il prezzo più o meno irrisorio, il fatto che nella backing band di Kravitz ci avessi già scoperto a suo tempo l’ottima Cindy Blackman (hai visto mai fosse buona palestra?) e, non ultimo, l’impeto di nostalgia dettato dalla visione di un bollino SIAE di quelli blu (altra fisima che risulterà empatica giusto a una ristretta cerchia di musicofili nerd che hanno varcato da un pezzo il punto di non ritorno). Il tempo di tornare a casa ed esaminarlo un attimo con più cura che già arriva il primo segnale sconfortante: sul disco suona John Patitucci. Lungi da me sminuire le capacità tecniche di uno dei più quotati bassisti al mondo, ma, mentre la mia schiena era percorsa dai brividi, una domanda si faceva inesorabilmente strada: “vuoi vedere che è roba da riccardoni?” (Continua a leggere)
Lo dico subito: se esistesse un tribunale preposto al giudizio dei crimini musicali e io fossi in toga, allo smooth jazz l’ergastolo non lo toglierebbe manco l’avvocato Taormina. Musica buona tutt’al più come sottofondo in sala d’aspetto del dentista: sarà che uno l’associa inevitabilmente a trapani, urla belluine e parcelle salate, con quale coraggio poi a casa riesce a mettere un disco di Kenny G (che ha studiato e sa suonare, ci tengo a specificarlo prima che qualche cultore del bello chieda la mia testa)? Tutto questo per dire che il pianista americano Dan Siegel è diventato famoso (si fa per dire) e si è fatto una credibilità all’interno di questa nicchia, cosa che ai miei occhi non dovrebbe rendergli particolari onori (e infatti), tuttavia io ‘On The Edge’ lo adoro. È un po’ come fare coming out (no, è peggio), ma chi non ha una lista corposa di guilty pleasures o scheletri nell’armadio scagli pure il primo disco. A mia parziale discolpa posso dire che ‘On The Edge’ non è smooth jazz “duro e puro” come potreste immaginare, ma si abbevera copiosamente dal più patinato pop/rock della sua epoca (il 1985. Mi rendo conto di come ciò per taluni possa essere un deterrente piuttosto che un’attenuante, ma tant’è). (Continua a leggere)
WELCOME TO THE CUT OUT BIN
 Nei primi anni ’90 l’arrivo dei cut out (dalle nostre parti meglio noti come “forati”) fu una piccola manna dal cielo. Ero solo un bambinetto, ma la fame di nuova musica era tanta e i quattrini, ovviamente, pochi, dunque poter andare in negozio e portare a casa qualcosa di nuovo con sole cinquemila lirette era una novità a dir poco eccitante. E poi quelle enormi scatole di cartone che contenevano i CD erano bellissime a vedersi. A prima vista sembrava potessero contenerne addirittura due o tre, ma, considerando il prezzo, anche realizzare che in realtà ne racchiudevano solo uno non era certo un cattivo affare. Anni dopo scoprii che quelle scatole avevano uno scopo ben preciso: l’altezza di dodici pollici permetteva di poterle disporre negli stessi espositori utilizzati per i vinili, favorendo la “riconversione” dei negozi dopo l’arrivo sul mercato dei compact disc. (Continua a leggere)
Nei primi anni ’90 l’arrivo dei cut out (dalle nostre parti meglio noti come “forati”) fu una piccola manna dal cielo. Ero solo un bambinetto, ma la fame di nuova musica era tanta e i quattrini, ovviamente, pochi, dunque poter andare in negozio e portare a casa qualcosa di nuovo con sole cinquemila lirette era una novità a dir poco eccitante. E poi quelle enormi scatole di cartone che contenevano i CD erano bellissime a vedersi. A prima vista sembrava potessero contenerne addirittura due o tre, ma, considerando il prezzo, anche realizzare che in realtà ne racchiudevano solo uno non era certo un cattivo affare. Anni dopo scoprii che quelle scatole avevano uno scopo ben preciso: l’altezza di dodici pollici permetteva di poterle disporre negli stessi espositori utilizzati per i vinili, favorendo la “riconversione” dei negozi dopo l’arrivo sul mercato dei compact disc. (Continua a leggere)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- Chiodi nella bara
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Wayne Shorter: il compositore
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz