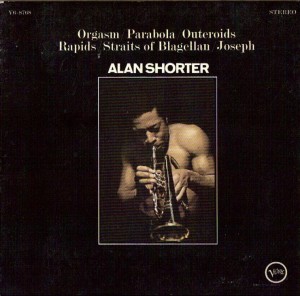Cut Out Bin's Articles

Di Tex Allen si era già detto qualche tempo fa, in occasione del recupero di ‘Blue Autumn’ a firma Nat Adderley, album nel quale uno dei pezzi migliori, ‘The Fifth Labor Of Hercules’, portava proprio la firma di questo compositore di Houston dal background poco pubblicizzato ma valoroso: anni di studi, dozzine su dozzine di concerti macinati prima nel suo Texas (quasi sempre alla tromba, pur essendo anche abile pianista), poi nell’adottiva New York City, dove ebbe la prima grande occasione nell’orchestra di Gil Evans (sull’ottimo ‘Svengali’, 1973). La partecipazione prestigiosa non si rivelò il trampolino sperato, complice anche un carattere poco incline a compromessi (“Non ho mai sacrificato la mia musica nel nome del business”, diceva) con il quale, sgomitando sgomitando, riuscì tuttavia a ritagliarsi un’onestissima carriera da mediano, sia componendo per altri, che sui palchi della grande mela. (Continua a leggere)
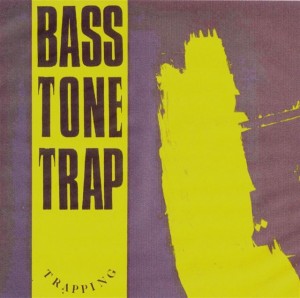 Tra le note di copertina, uno stralcio di recensione dell’epoca dipinge i Bass Tone Trap come “la Art Ensemble Of Chicago che suona canzoni pop scritte da Ornette Coleman”, definizione che strappa un sorriso e di sicuro incuriosisce. Piccola mosca bianca all’interno del panorama inglese, il sestetto sheffieldiano nasceva dalle ceneri degli ostici De Tian, autori di un unico EP (‘Two Spires Split’) dalle forti tendenze avanguardistiche. Concluso quel progetto, Paul Shaft (contrabbasso) e Martin Archer (polistrumentista) restarono uniti, coltivando l’intenzione di virare verso sonorità più immediate: è la genesi di una storia tanto breve quanto intensa.
Tra le note di copertina, uno stralcio di recensione dell’epoca dipinge i Bass Tone Trap come “la Art Ensemble Of Chicago che suona canzoni pop scritte da Ornette Coleman”, definizione che strappa un sorriso e di sicuro incuriosisce. Piccola mosca bianca all’interno del panorama inglese, il sestetto sheffieldiano nasceva dalle ceneri degli ostici De Tian, autori di un unico EP (‘Two Spires Split’) dalle forti tendenze avanguardistiche. Concluso quel progetto, Paul Shaft (contrabbasso) e Martin Archer (polistrumentista) restarono uniti, coltivando l’intenzione di virare verso sonorità più immediate: è la genesi di una storia tanto breve quanto intensa.
‘Trapping’ viene registrato nel 1983 ed è particolare sin dalla formazione, che schiera in campo due chitarre, la sezione ritmica e due sax (uno ad opera del funambolo Derek Saw, che si cimenta anche coi clarinetti, e uno ad opera di Archer stesso, che si dedica pure ad organo e violino). La musica è una miscela di jazz, rock e funk altrettanto anomala, specie perché di albionico, pur lasciando trasparire un certo amore di fondo per i Soft Machine, ha davvero ben poco, preferendo semmai guardare oltreoceano. (Continua a leggere)
 Ne abbiamo parlato spesso: gente che si trova a un punto della carriera (artistica ma non necessariamente musicale) più o meno morto, e allora tenta la fatidica carta del disco jazz per “rifarsi una verginità”. Qualche volta la mossa riesce bene – penso a Lee Aaron o a Marla Gibbs – altre volte non brilla, ma neanche fa troppi danni (come il disco di Molly Ringwald di cui abbiamo parlato di recente), ma nella maggior parte dei casi ci troviamo davanti a schifezze senza possibilità di redenzione (non ultimo il buon Joe Jackson che si avventa sulla carcassa di Ellington). È sulla scia di questi che andiamo a ripescare dal passato recente un’iniziativa analoga come ‘Passing Strangers’.
Ne abbiamo parlato spesso: gente che si trova a un punto della carriera (artistica ma non necessariamente musicale) più o meno morto, e allora tenta la fatidica carta del disco jazz per “rifarsi una verginità”. Qualche volta la mossa riesce bene – penso a Lee Aaron o a Marla Gibbs – altre volte non brilla, ma neanche fa troppi danni (come il disco di Molly Ringwald di cui abbiamo parlato di recente), ma nella maggior parte dei casi ci troviamo davanti a schifezze senza possibilità di redenzione (non ultimo il buon Joe Jackson che si avventa sulla carcassa di Ellington). È sulla scia di questi che andiamo a ripescare dal passato recente un’iniziativa analoga come ‘Passing Strangers’.
La carriera di Tony Hadley comunque, almeno quella solista dopo i fantastilioni di copie venduti con gli Spandau Ballet, più che a un punto morto non era mai decollata: dell’uscita di ‘The State Of Play’, l’esordio in proprio, se ne accorse giusto qualcuno in Italia (paese dove, strano ma vero, gente come Spandau e Duran ha continuato a mantenere uno zoccolo durissimo anche quando il resto del mondo provava a seppellirli nell’oblio delle vecchie glorie con malcelato imbarazzo). (Continua a leggere)
 Fine anni ’70, la Sala Bossi a Bologna, luogo culto della musica “seria”, un manipolo di musicisti (e goliardi?) tra cui Edoardo “Dado” Ricci, Stefano Bartolini (ambedue continuatori del NEEM – Nuove Esperienze di Eresia Musicale), Riccardo Fassi (questa la sua prima registrazione), Filippo Monico, Paolino Della Porta e Roberto Del Piano (al sax tenore e soprano …ma va?), una registrazione quasi interamente dal vivo (!) e un’etichetta alternativa (la Materiale Sonori: come poteva non esserlo?). Frullate tutto, aggiungetevi un po’ di Art Ensemble Of Chicago, testi dadaisti, Jingle pubblicitari, ritornelli ironici, musica bandistica (dovuta forse alla presenza di musicisti non prof) e forse capirete che sonorità escono. Ma non basta, perchè NEEM non era solo un gruppo da ascoltare, ma anche da vedere, d’altronde la presenza sulla copertina della scritta “TEA TRAZZ” (che starebbe per “teatro jazz”), qualche indicazione pur la dava! Sul palco poi, stando alle parole di Roberto Del Piano – che ringrazio di avermi inviato i file di questo introvabile vinile – c’erano anche giocolieri, mangiafuoco… (Continua a leggere)
Fine anni ’70, la Sala Bossi a Bologna, luogo culto della musica “seria”, un manipolo di musicisti (e goliardi?) tra cui Edoardo “Dado” Ricci, Stefano Bartolini (ambedue continuatori del NEEM – Nuove Esperienze di Eresia Musicale), Riccardo Fassi (questa la sua prima registrazione), Filippo Monico, Paolino Della Porta e Roberto Del Piano (al sax tenore e soprano …ma va?), una registrazione quasi interamente dal vivo (!) e un’etichetta alternativa (la Materiale Sonori: come poteva non esserlo?). Frullate tutto, aggiungetevi un po’ di Art Ensemble Of Chicago, testi dadaisti, Jingle pubblicitari, ritornelli ironici, musica bandistica (dovuta forse alla presenza di musicisti non prof) e forse capirete che sonorità escono. Ma non basta, perchè NEEM non era solo un gruppo da ascoltare, ma anche da vedere, d’altronde la presenza sulla copertina della scritta “TEA TRAZZ” (che starebbe per “teatro jazz”), qualche indicazione pur la dava! Sul palco poi, stando alle parole di Roberto Del Piano – che ringrazio di avermi inviato i file di questo introvabile vinile – c’erano anche giocolieri, mangiafuoco… (Continua a leggere)
 C’era una puntata di Beverly Hills 90210 in cui al Peach Pit (per i profani all’ascolto: il locale dove quei figuri usavano intrattenersi) veniva installata dell’apparecchiatura per il karaoke, e per tutta la durata dell’episodio i protagonisti “ggiovani” perculavano allegramente il “matusa” signor Walsh, che si ostinava a salire sul palchetto per cantare con inscalfibile stoicismo un pezzo che alle orecchie di quegli adolescenti dal capello impomatato suonava “giurassico” anzichenò: ‘Doo Wah Diddy Diddy’ nella versione dei Manfred Mann. Ovviamente dopo un’ora di risatine arrivava il finale “volemose bbene” e tutti insieme, ggiovani e matusa, a cantare “There she was just walkin’ down the street…”: un tale trauma che ancora oggi, quando sento nominare i Manfred Mann, la prima immagine che mi viene in mente raffigura il padre di Brenda e Brandon Walsh al karaoke.
C’era una puntata di Beverly Hills 90210 in cui al Peach Pit (per i profani all’ascolto: il locale dove quei figuri usavano intrattenersi) veniva installata dell’apparecchiatura per il karaoke, e per tutta la durata dell’episodio i protagonisti “ggiovani” perculavano allegramente il “matusa” signor Walsh, che si ostinava a salire sul palchetto per cantare con inscalfibile stoicismo un pezzo che alle orecchie di quegli adolescenti dal capello impomatato suonava “giurassico” anzichenò: ‘Doo Wah Diddy Diddy’ nella versione dei Manfred Mann. Ovviamente dopo un’ora di risatine arrivava il finale “volemose bbene” e tutti insieme, ggiovani e matusa, a cantare “There she was just walkin’ down the street…”: un tale trauma che ancora oggi, quando sento nominare i Manfred Mann, la prima immagine che mi viene in mente raffigura il padre di Brenda e Brandon Walsh al karaoke.
I Manfred Mann prendevano il nome dal loro omonimo leader/tastierista d’origine sudafricana, e nella prima metà degli anni ’60 riuscirono a vendere qualche palata di dischi con un sound a metà strada tra pop zuccheroso e rhythm’n’blues, tuttavia il loro legame con la musica che normalmente trattiamo su queste pagine è più saldo di quanto si possa pensare. (Continua a leggere)
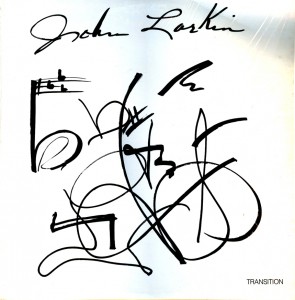 L’anno era il 1995. Forse l’ultimo della stagione d’oro della cosiddetta eurodance, che di lì a poco avrebbe sparato i fuochi conclusivi. In mezzo a tante canzoni che impazzavano tra radio, TV e discoteche ce n’era una in particolare che si distingueva dalle altre, e non c’è bisogno di chissà quale memoria per ricordarla. Non la cantavano ragazze dalla voce squillante né qualche nerboruto rapper: l’insolito interprete era un signore sulla cinquantina dall’aria simpatica, riconoscibilissimo per la Fedora alla Tom Landry sempre incollata sul cranio e il baffo pronunciato modello birra Moretti. Su quella base fatta su misura per le piste da ballo dell’epoca, costui si esibiva in attorciglianti scioglilingua in stile scat, e infatti si presentava con un nome che era tutto un programma: Scatman John. I milioni li fece con un ritornello martellante che per tutti era una cosa tipo bi bo bo bo bobò (scopro solo oggi che, a quanto pare, diceva ski ba bop ba dop dop. Potenza dell’internet), completato da un testo motivational (“Don’t let nothin’ hold you back / If the Scatman can do it so can you”) che spiegava come quel tipo di cantato jazz avesse aiutato lui, balbuziente, ad accettare quel difetto di pronuncia che per anni l’aveva condizionato, spingendolo persino a un passo dal baratro: “Avevo così tanta vergogna della mia balbuzie che per anni mi sono quasi ucciso con alcool e droghe”, rivelava in un’intervista. (Continua a leggere)
L’anno era il 1995. Forse l’ultimo della stagione d’oro della cosiddetta eurodance, che di lì a poco avrebbe sparato i fuochi conclusivi. In mezzo a tante canzoni che impazzavano tra radio, TV e discoteche ce n’era una in particolare che si distingueva dalle altre, e non c’è bisogno di chissà quale memoria per ricordarla. Non la cantavano ragazze dalla voce squillante né qualche nerboruto rapper: l’insolito interprete era un signore sulla cinquantina dall’aria simpatica, riconoscibilissimo per la Fedora alla Tom Landry sempre incollata sul cranio e il baffo pronunciato modello birra Moretti. Su quella base fatta su misura per le piste da ballo dell’epoca, costui si esibiva in attorciglianti scioglilingua in stile scat, e infatti si presentava con un nome che era tutto un programma: Scatman John. I milioni li fece con un ritornello martellante che per tutti era una cosa tipo bi bo bo bo bobò (scopro solo oggi che, a quanto pare, diceva ski ba bop ba dop dop. Potenza dell’internet), completato da un testo motivational (“Don’t let nothin’ hold you back / If the Scatman can do it so can you”) che spiegava come quel tipo di cantato jazz avesse aiutato lui, balbuziente, ad accettare quel difetto di pronuncia che per anni l’aveva condizionato, spingendolo persino a un passo dal baratro: “Avevo così tanta vergogna della mia balbuzie che per anni mi sono quasi ucciso con alcool e droghe”, rivelava in un’intervista. (Continua a leggere)

Da quando abbiamo aperto i battenti, su queste pagine si è parlato di Bill Cosby praticamente in tutte le salse. Nonostante la sovraesposizione, credetemi se dico che fino adesso non abbiamo ancora fatto luce sul motivo che già da solo potrebbe giustificare la presenza dell’entertainer americano in questa sede: ‘Badfoot Brown & The Bunions Bradford Funeral & Marching Band’. Nome improbabile, ma non è un complesso: si tratta in realtà del titolo di un disco originariamente stampato nel 1971 dalla UNI (sottoetichetta della MCA), prima prova strettamente musicale del futuro Dottor Robinson dopo una manciata di album spoken word comici e un paio di dischi in cui cantava successi rhythm’n’blues dai testi riveduti e corretti.
Bill Cosby suona il Rhodes ed è autore di tutte le musiche, ma l’uscita, a quarant’anni di distanza, resta ancora avvolta da una piccola cappa di mistero: nell’album non appare alcun elenco dei credits, dunque è non è dato sapere con precisione chi altri abbia suonato cosa. Voci più o meno attendibili confermano la presenza di Bobby Hayes al basso e del grande Big Black (no, non c’entra Steve Albini) alle percussioni, ma sul resto l’enigma è totale. (Continua a leggere)
 Lo dicevamo già da qualche parte altrove: lo scaffale (o il cestone) delle offerte dimenticate da Dio e da Satana è croce e delizia. Soddisfazione sbrodolante quando ci si porta a casa un capolavoro sconosciuto per pochi spiccioli, certo, ma anche residenza stabile di pattume senza possibilità di redenzione (“sucks ass”, direbbero gli amici anglofoni). Per quanto impregnato di un certo fascino perverso, il titolo di cui andiamo a parlare oggi è sicuramente ascrivibile alla seconda delle due categorie: il tipico disco che se si trova nel cut out bin c’è un motivo e non sarebbe una cattiva idea lasciarlo lì.
Lo dicevamo già da qualche parte altrove: lo scaffale (o il cestone) delle offerte dimenticate da Dio e da Satana è croce e delizia. Soddisfazione sbrodolante quando ci si porta a casa un capolavoro sconosciuto per pochi spiccioli, certo, ma anche residenza stabile di pattume senza possibilità di redenzione (“sucks ass”, direbbero gli amici anglofoni). Per quanto impregnato di un certo fascino perverso, il titolo di cui andiamo a parlare oggi è sicuramente ascrivibile alla seconda delle due categorie: il tipico disco che se si trova nel cut out bin c’è un motivo e non sarebbe una cattiva idea lasciarlo lì.
Con una rapida ricerca sull’amico Google scopro che la PMB, che nel 2006 ha pubblicato questa roba, è un’etichetta argentina specializzata in operazioni del genere, trattamento di cui è stata vittima gente come Madonna (pure pure), Stones (addirittura con due volumi, poveri loro), Ramones (…) e Bob Marley (questo qui lo immagino come IL MALE ASSOLUTO, sulla fiducia). Ora, fermatevi un attimo e provate a immaginare pezzi come ‘It’s So Easy’, ‘Welcome To The Jungle’ e ‘You Could Be Mine’ riletti in un frullato di elettronica da aperitivo con spruzzate jazz e bossa nova tipo compilation di Stéphane Pompougnac (ok, lo ammetto: il fine principale di quest’articolo era poter scrivere “Stéphane Pompougnac”). (Continua a leggere)
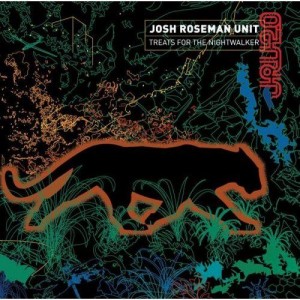 Josh Roseman, trombonista, è uno dei musicisti più attivi del foltissimo sottobosco newyorkese, fra collaborazioni e progetti personali. La sua discografia personale, purtroppo, è tutt’altro che nutrita, ma forse perché preferisce la qualità alla quantità. ‘Treats For The Nightwalker’, sua seconda uscita, è un lavoro intrigante e originale: lo si potrebbe chiamare jazz for raving and nightclubbing, non fosse che poi salterebbe su qualcuno a rompere le scatole sulla purezza e la commercialità e l’arte etc etc, e quindi non lo facciamo.
Josh Roseman, trombonista, è uno dei musicisti più attivi del foltissimo sottobosco newyorkese, fra collaborazioni e progetti personali. La sua discografia personale, purtroppo, è tutt’altro che nutrita, ma forse perché preferisce la qualità alla quantità. ‘Treats For The Nightwalker’, sua seconda uscita, è un lavoro intrigante e originale: lo si potrebbe chiamare jazz for raving and nightclubbing, non fosse che poi salterebbe su qualcuno a rompere le scatole sulla purezza e la commercialità e l’arte etc etc, e quindi non lo facciamo.
In questi settanta minuti di musica (!) il sestetto base di Roseman viene aumentato da una nutrita serie di ospiti, diversi a seconda del pezzo: organo, tastiere, quartetto d’archi, tromba e flicorno, diveri sassofoni, percussioni, chitarra. Ma al di là degli assoli, comunque bellissimi, a cura di Roseman e dei vari Russell Gunn, Liberty Ellman, Myron Walden, Chris Potter etc, quello che conta realmente è il suono d’insieme. E infatti ‘Treats…’ suona come una gigantesca, interminabile jam di jazz elettrico che parte dagli anni ’70 di Miles Davis (‘Live/Evil’, ‘On The Corner’, ‘Agartha’, ‘Pangea’) e Herbie Hancock (‘Mwandishi’, ‘Sextant’, ‘Headhunters’), passa per le complesse polimetrie dello Steve Coleman dei primi anni ’90 (‘Drop Kick’ e ‘Def Trance Beat’ soprattutto) e getta infine uno sguardo indagatore sul mondo della musica dub, reggae, trip-hop e drum’n'bass. (Continua a leggere)
“Una volta, al Cafè Bohemia, Alan passò accanto a Miles Davis. Entrambi indossavano giacche e pantaloni dello stesso stile. Miles disse: ‘Stai cercando di imitarmi!’. Alan gli rispose: ‘No: sei tu che stai cercando di imitarmi!’. Miles venne da me e iniziò a ridere come un matto: ‘Tuo fratello è davvero unico, amico…’.”
Così nelle note di copertina di ‘Orgasm’ Wayne Shorter ricorda suo fratello maggiore Alan. Non che la sua musica avesse molto in comune con Miles Davis, ma l’episodio rende in maniera abbastanza vivida il profilo di un personaggio perennemente sopra le righe e in costante opposizione a qualunque cosa gli sembri accademica o imposta. Una voglia di unicità che lo porterà persino ad abbandonare il sax, suo strumento d’origine, per differenziarsi da quel fratello che inizia a farsi un nome nella schiera dei volti nuovi del jazz. E infatti sia durante il periodo (grossomodo tra la metà dei ’60 e i primi ’70) presso le corti di Archie Shepp e Marion Brown, che in ‘Orgasm’, prima prova da leader datata 1969 (l’altra sarà ‘Tes Esat’ di un paio d’anni dopo), Alan Shorter suona il flicorno. (Continua a leggere)
- Ondrey Zintaer and the ZTB trio, a novel...
- ZTB Trio – BREATH – Antenna ...
- Amanita CALANDRA Manitù Records 2020
- Francesco Mascio e Alberto La Neve I TH�...
- Deep Art Men DEEP ART MEN ed. Caligola 2...
- MAURO MUSSONI LUNEA ed. Alfa Music 2018
- LOSTINWHITE Matters of Time Ed. Vittorio...
- Alberto La Neve Night Window Manitù Rec...
- MACIEK PYSZ/DANIELE DI BONAVENTURA ̵...
- GB PROJECT – Magip (2018, Alfa Pro...
- Oscar Peterson fra ignoranza e pregiudiz...
- Riceviamo & pubblichiamo: Ibrido Ho...
- PICTURE THIS: Cyrus Chestnut@Dizzy’...
- Riceviamo & pubblichiamo: JAZZ AL P...
- ALL RISE: il nuovo album di Jason Moran ...
- PICTURE THIS: Terence Blanchard@New Orle...
- Chiodi nella bara
- PICTURE THIS: Kamasi Washington@Regent T...
- Wayne Shorter: il compositore
- PICTURE THIS: Greg Osby @Quasimodo, Berl...
Categorie
- Attualità (255)
- Comunicazioni e varie (122)
- Cut Out Bin (18)
- Filthy McNasty (61)
- I dimenticati del jazz (6)
- Interviste (42)
- Live (72)
- Oldies (57)
- Picture This (235)
- Playlist (17)
- Rassegna Stramba (11)
- Recensioni (346)
- Record Store Day (12)
- Speciali (50)
Archivi
- marzo 2023 (1)
- ottobre 2022 (1)
- maggio 2020 (1)
- febbraio 2020 (1)
- dicembre 2019 (4)
- gennaio 2019 (1)
- giugno 2018 (1)
- aprile 2018 (2)
- marzo 2018 (3)
- febbraio 2018 (1)
- gennaio 2018 (4)
- dicembre 2017 (3)
Links
- A Proposito Di Jazz
- Black Vibrations
- DeMIUSìK
- Emusic
- Instant Jazz Mailorder
- ItaliaJazz
- Jazz & Libri, Pisa
- Jazz Convention
- Jazz From Italy
- Jazz Hard…ente & Great Black Music
- Jazz nel Pomeriggio
- Kind Of Duke
- Magazzino Jazz
- Mi piace il jazz
- Mondo Jazz
- Quinta Stagione
- Soulful Corner
- The David W. Niven Collection
- The Mellophonium Online
- Tracce Di Jazz